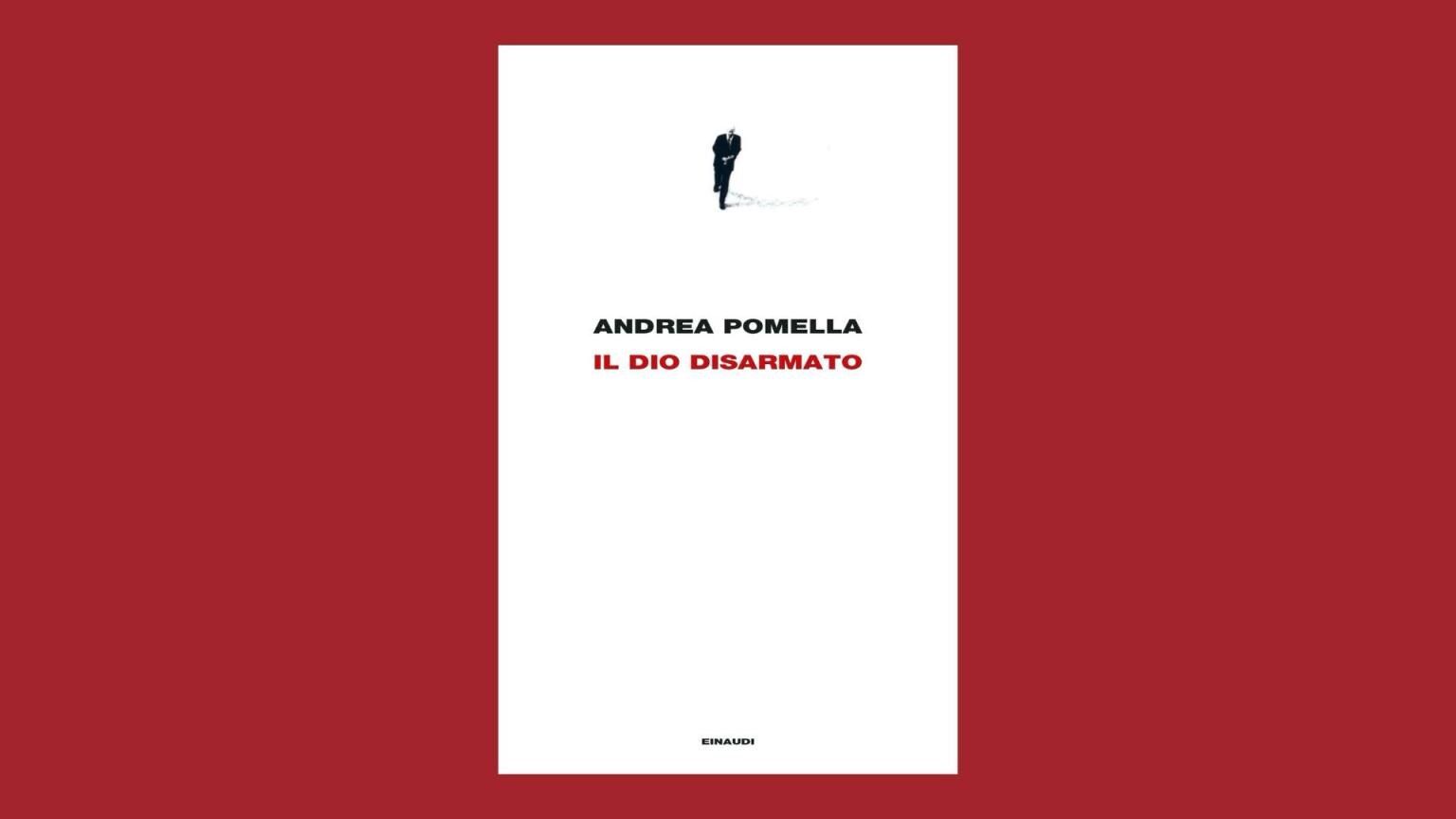
Su “Il dio disarmato” di Andrea Pomella
La meditazione della morte non insegna a morire;
non rende l’esodo più facile, ma non è questo quel ch’io cerco.
(M. Yourcenar, Memorie di Adriano)
Nel romanzo Il dio disarmato (Einaudi, 2022), Andrea Pomella trasfigura in finzione narrativa le ore immediatamente precedenti il sequestro di Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta, a partire dalla notte pressoché insonne, l’ultima, che il Presidente trascorre tra le mura domestiche.
L’autore dilata enormemente il tempo del racconto dividendo la narrazione in sei parti – L’incantesimo, La rabbia, Il mutamento, Tu intendi il mio pensiero da lontano, Vento d’acciaio, Sunt lacrimae rerum – e restituendo al ralenti una vicenda ben nota e più volte ricostruita nel suo svolgimento per quanto concerne la verità storica; tuttavia è dal punto di vista finzionale che Pomella intende ricrearla, appellandosi nella Nota finale alla lezione manzoniana espressa nella Lettera al signor Chauvet, laddove si ricorda come tutto ciò che riguarda l’aspetto interiore e intimo di chi ha fatto la Storia è “dominio della poesia”.
Dunque per tale ragione nel Dio disarmato, Moro e tutte le figure che ruotano attorno al pugno di ore trascorse tra la notte e le prime ore del mattino del 16 marzo 1978 – i familiari più stretti, gli agenti di scorta, i brigatisti, perfino gli ignari testimoni – sono trasfigurati in homines ficti: grazie alla letteratura possiamo conoscerne pensieri, progetti, preoccupazioni, osservazioni, timori, desideri. Il narratore in terza persona non si limita a narrare i fatti e le azioni, che deduce dalla nutrita bibliografia, dalla visione dei filmati d’epoca, dai referenti oggettuali come la Fiat 130 crivellata di colpi osservata di persona al Museo della motorizzazione civile di Roma. Non può accontentarsi di verbi che “designano processi esterni, di cui possiamo accertarci a partire da ciò che possiamo percepire – per così dire – dall’esterno delle persone” ma, viceversa, ha “bisogno dei verbi dei processi interiori – come pensare, riflettere, credere, intendere, sentire, sperare, ecc. – di cui si serve in un modo proprio a lui solo, come non potrebbe fare nessun altro emittente o narratore (oralmente o per iscritto)”, come afferma Kate Hamburger (La logica della letteratura, Pendragon, 2015):
La prima cosa che distingue è il tappeto, i motivi di palmette e viti che s’intrecciano su uno sfondo rosso persiano. Poi le sue pantofole di pelle nera che ricordano delle sobrie calzature pontificie. Prova a scrutare gli altri oggetti nella stanza. Ha l’impressione di essere entrato a passi felpati in una concitatissima riunione di partito a Piazza del Gesù, di essersi accostato a uno di quegli enormi tavoli di legno massiccio dietro cui si siedono eterni notabili in doppiopetto grigio, di essere strisciato lungo le pareti spoglie, dove tuttavia non mancano mai un crocifisso e una foto del papa, e che nella sala sia calato un silenzio angoscioso, e che adesso gli occhi indagatori di tutti i presenti convergano su di lui, occhi che luccicano dietro espressioni costernate e mani giunte nell’irriflesso gesto cattolico, una posa che in quei frangenti assomiglia più a una minaccia che a una preghiera. Di là c’è Noretta che dorme. (A. Pomella, Il dio disarmato, Torino, Einaudi, 2022, p. 26)
Moro si è appena risvegliato dopo essersi assopito in poltrona: la casa è immersa nel sonno, ma lui veglia attendendo il rientro del figlio Giovanni. I timori per quanto potrebbe accadere ai congiunti sono perfino maggiori a quelli che nutre per se stesso; del resto tutta la famiglia vive da tempo in uno stato di angoscia che sembra amplificarsi di giorno in giorno, soprattutto nella figlia maggiore, Maria Fida. Il Presidente trascorre, dunque, quelle prime ore della notte tra la riflessione e il dormiveglia: il cuore del romanzo di Pomella sta in buona parte proprio nel Moro domestico, in quel “dio disarmato” che dà il titolo al libro e che designa non l’uomo pubblico – noto per “l’abilità del tessitore e il talento dell’equilibrista” – ma l’uomo privato che “depone i fardelli della forza e del potere per godere pienamente della propria disadorna umanità”. (p. 118)
Tuttavia sarebbe riduttivo risolvere la lettura di questo libro alla sola ricostruzione della personalità privata di Moro; in effetti l’autore mostra di muoversi su più piani temporali che vengono di volta in volta fusi e alternati in un montaggio che costringe il lettore a seguire bruschi cambiamenti nel tempo. Tra le immersioni in un passato lontano ci sono quelle con cui si ricostruisce narrativamente chi è stato Mario Fani, un giovane cattolico vissuto a metà del XIX secolo, morto a seguito di un’infezione polmonare contratta per portare in salvo, in nome del motto che aveva fatto suo: “Preghiera, azione sacrificio”, un uomo che rischiava di annegare. E ancor più si arretra nel tempo nell’inserire una vicenda – che nel corso del libro mostra di avere un valore allegorico, coincidendo con l’oscuro sogno che accompagna Moro l’ultima notte e che il Presidente fatica a ricordare al risveglio – che riguarda Camillo Borghese, cognato di Napoleone, da cui prende nome il quartiere della Camilluccia, limitrofo al Trionfale, scenario del rapimento di Moro. Infine, oltre a intrecciare i fili di tutti gli attori presenti sulla scena della mattina del 16 marzo 1978, si assiste anche alle numerose visite che Pomella compie sul luogo del rapimento, come se lo scrittore potesse rintracciare qualche elemento inerte e silente ma in grado di mostrare una crepa non ancora vista nella piega degli eventi mille volte ricostruiti: “Che si può trovare di ciò che è stato?”, si chiede (p.181). È in una mattina del luglio 2021 che assiste a una sorta di congiunzione dei piani temporali che lo lascia, dapprima, sbigottito:
Ecco, la scena. Si palesa davanti a me in questo lunedì di luglio nello stesso modo in cui l’ho sempre immaginata, o meglio, in cui le vecchie istantanee raschiate dal tempo me l’hanno sempre fatta immaginare. All’incrocio con via Stresa la ripetizione, l’ennesima, ma stavolta, per così dire, reale: le tre macchine di via Fani, la 128 targata corpo diplomatico guidata da Moretti, la 130 su cui viaggiava Moro, l’Alfetta dei poliziotti. La prima ha il fanale posteriore rotto, le ultime due sono crivellate di colpi. Le vedo in posizione. […] Al di là dell’incrocio di via Stresa enormi Suv e macchine rumorose sfrecciano nel tempo presente. È come se all’altezza del famoso stop ci fosse una parete invisibile che separa due epoche lontane ma coesistenti. È una scollatura assurda nella realtà. Ciò che è vero, o parzialmente vero, o che è stato vero e ora non lo è più: tutto davanti ai miei occhi nel medesimo istante. (pp. 182-183)
Aggirandosi tra gli uomini che stanno allestendo la scena del rapimento per la serie TV Esterno notte, firmata dal regista di Marco Bellocchio, Pomella ancora sente di cercare “una verità più sfuggente, percettiva e razionale, insieme intima e collettiva”: sono, queste, le pagine del romanzo che più ricordano come la vicenda Moro sia ancora, per la storia italiana, per la storia dei cittadini italiani, una vicenda priva di pacificazione e che, per questo, continua a moltiplicare le narrazioni. In quella mattina di luglio non solo Pomella si reca al quartiere Trionfale come usa fare nel corso della scrittura del suo libro, ma lì si stanno per girare le scene del rapimento e della strage su cui Bellocchio a sua volta ha deciso di tornare, a distanza di vent’anni dal film Buongiorno notte. Come per una sorta di coazione a ripetere, la vicenda Moro coagula ancora su di sé in modo esemplare tutte le contraddizioni, le aporie, i segreti, le lacerazioni dei cosiddetti anni di piombo, rimasti di fatto privi di una elaborazione comune, collettiva e condivisa nonostante alcuni recenti tentativi (penso in particolare alle esperienze di giustizia riparativa portate avanti da Mons. Bertagna, dal criminologo Adolfo Ceretti e dalla giurista Claudia Mazzucato e raccolte ne Il libro dell’incontro).
Dunque, Il dio disarmato ha in sé il pregio di dare spazio al Moro privato con quella dilatazione temporale che permette all’autore perfino di immaginare che uno starnuto – il giorno del rapimento lo statista aveva una leggera influenza – gli impedisca di capire subito che la sua auto sta per essere proditoriamente bloccata dalla Fiat 128 guidata da Moretti:
Gli occhi gli si chiudono per riflesso nel momento in cui la convulsiva espulsione della massa d’aria che risale dai polmoni gli attraversa il naso e la bocca. […] L’impossibilità di tenere gli occhi aperti, dettata dalla meccanica fisiologica dello starnuto, impedisce al presidente di esercitare la lungimiranza di cui è naturalmente dotato” (p.188)
Nonostante questo, però, il Presidente della DC, l’uomo che sta per raggiungere la Camera dei Deputati per la votazione di fiducia al governo Andreotti da lui voluto e pensato con l’appoggio del PCI, seduto all’interno della 130 appare disarmato anche come statista e questo la dice lunga sul valore non solo individuale ma anche collettivo dell’intera vicenda:
Ma non c’è stato forse un momento in tutta la sua vita in cui si sia sentito più solo di ora, appoggiato con le scapole contro il sedile, il giornale sule gambe. Divide con due uomini lo spazio interno di un’automobile, perciò non potrebbe in assoluto dirsi così solo. Eppure le circostanze cruciali in cui si trova stanno già dispiegando i loro effetti. Perché quei due uomini, il cui compito è proteggerlo, sono vie agli sgoccioli e stanno per tramutarsi in pure assenze. […] Nell’aria si fa un silenzio chimerico, che dura poco più di un istante. Ma è un istante perfetto, supremo: sembra che non sia rimasto più nulla al mondo. […] Il finestrino del guidatore esplode a contatto con una forza siderurgica, ferro lega contro vetro. Nella nebulosa di schegge che trasvolano nell’abitacolo compare il calcio di un’arma da fuoco. (pp. 193-194)
Articoli correlati
Commento
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Alessandro Gilioli, un giornalista onesto (ve ne sono ancora, poiché non sempre questo sostantivo e questo aggettivo dànno luogo ad un ossimoro), scrisse sull’“Espresso” quanto segue: «La verità giudiziaria ha stabilito la colpevolezza dei brigatisti, che ancora sostengono di aver fatto tutto da soli. La ricerca della verità storica invece procede per indizi e analisi logiche». Bene, consegnando ai cultori di illazioni infondate e malfilati raziocini le analisi logiche, vediamo i fatti reali.
I cinque uomini che erano seduti nell’auto (Moro e i quattro agenti della scorta) furono colpiti con armi semiautomatiche e automatiche, il 16 marzo 1978, a due metri di distanza, e i colpi che vennero sparati furono più di novanta. Prima osservazione: visto il volume di fuoco e vista la rosa dei colpi sulle portiere e sui finestrini dell’auto, qualsiasi cacciatore potrà confermare che a sparare furono dei dilettanti. Seconda osservazione: dato che almeno due di quelle armi si incepparono, qualsiasi armaiolo potrà confermare che a compiere quell’azione non furono dei professionisti. Terza osservazione: il fatto che i brigatisti non fossero muniti ciascuno di un’arma di riserva induce a dubitare sulla adeguatezza delle dotazioni. È evidente che coloro che operarono puntarono ad approfittare soprattutto dell’effetto sorpresa e della impreparazione da parte della scorta.
Conclusione: il pubblico non è mai soddisfatto dalla realtà e non manca mai qualcuno – pennivendolo, scrittorucolo, magistrato in cerca di visibilità, politicante da strapazzo o, ancor peggio, cineasta masturbatorio – che per spacciare la propria merce o per fare carriera è disposto a sostenere qualsiasi cosa. Tuttavia, il fitto polverone, che i “mass media” sollevano da decenni su questa vicenda con regolare cadenza, mira, quale che sia il grado di consapevolezza dei singoli attori, ad uno scopo ben preciso: quello di negare autonomia strategica e operativa alle Brigate Rosse.
Ma chi ha raccontato la verità, fin dalla sua prima lettera, esisteva: si chiamava Aldo Moro.