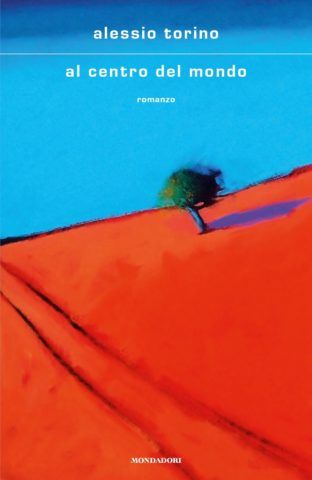
Al centro del mondo. Sull’ultimo romanzo di Alessio Torino
Piccolo viaggio Al centro del mondo
Lo vide l’Anna dal suo orto, lo videro i due muli, lo videro gli occhi verdi del nonno che era sulla sedia incatenata al ciliegio. Il ragazzo attraversava il campo, lungo la striscia dritta dove non cresceva l’erba, spingeva la carriola piena di legna. Il nonno cominciò a vedere un attimo dopo che il ragazzo si era fermato e aveva mollato la carriola con un gesto tanto brusco che tutto il carico cadde da una parte. Tlong, tlong, tlong. E allora il nonno si girò sulla sedia, verso la collina, e lo vide che si avvicinava alla quercia. Damiano sollevò lo sguardo ai rami dove foglie nuove e minuscole facevano un rumore d’acqua. Era il rumore che lo aveva impietrito mentre ci passava accanto, l’acqua più vicina era giù nel fosso dall’altra parte della collina, neanche un vento forte l’avrebbe mai portato fin lì. (A. Torino, Al centro del mondo, Mondadori, 2020, p.9).
Quella quercia è da dieci anni senza foglie, da quando ci si era impiccato il padre di Damiano Bacciardi. L’aveva trovato lui, che era soltanto un bambino di otto; un trauma – dicono – che l’aveva segnato per sempre, che l’aveva reso quel matto che adesso prendeva una quercia a colpi d’accetta (p.20). Peraltro, dopo poco, la madre l’aveva abbandonato, andando via così, di punto in bianco, in apparenza senza spiegazione. Damiano era rimasto affidato a Nonna Adele, che, dopo una disgrazia del genere, aveva ancora la forza di sfornare i suoi dolci e con quelle stesse mani accarezzava il nipote (p.29), al nonno, partigiano decorato con la medaglia al valore, che però stava per ore sulla sedia sotto il ciliegio e parlava così poco, e mai della guerra (p.33), allo zio Vince, detto il Gorilla, uno che nel novembre precedente aveva festeggiato l’elezione di Trump, uno che dava ai galli i nomi degli stati americani che applicavano la pena di morte, un giocatore d’azzardo (p.28). Damiano vive con loro a Villa la Croce, circondato da un piccolo gruppo di figure tutte in qualche modo legate a casa Bacciardi, sempre le stesse: l’Anna, con le sue oche, Baldeschi coi suoi maiali, Chessa con le sue pecore:
Sei case. Nove, con le tre abbandonate. Ma tutto il borgo era abbandonato. Giù in paese la chiamavano Villa dei Matti. (…) Abbandonata da tutti, Villa la Croce. In ultimo da sua madre Miruna. Eppure, nel corridoio di casa c’erano foto di una Villa la Croce piena di gente. Il prato della Noce affollato per una festa. Un corteo intorno a due sposi sul sagrato delle Stelle… Baldeschi non se n’era andato perché aveva i campi e la macchia, l’Anna perché aveva gli animali. I Bacciardi invece erano rimasti lì a fare il loro miele, la manna. (p.26)
Si dice che questo miele sia afrodisiaco, che ingravidi le donne. Come tale lo zio Vince lo vende al mercato, nei barattoli ordinati che Nonna Adele pulisce, riempie, sigilla, vergando le etichette a una a una con bella grafia. Al mercato lo zio ogni tanto ci porta anche Damiano, perché lo aiuti, perché impari, perché la smetta di stare attaccato alla nonna, perché quando la vecchia se ne va in cielo, tu passi sotto di me (p.49). E la nonna davvero a un certo punto muore. Allora i propositi di zio Vince – vendere Villa la Croce e andare altrove –, fin lì minacciati, sbandierati, goffamente intrapresi, abortiti, prendono corpo; anzi, i corpi di potenziali compratori olandesi. Damiano deve respingerli. L’ha detto il nonno, quando la quercia s’è rimessa a far foglie: «Il demonio si è preso tuo padre e adesso vorrà qualcun altro (…) L’hai vista la quercia. È tornato» (p.31). Non è rimasto che lui, Damiano, a tener testa al demonio; a salvare una volta per sempre quel nucleo irriducibile di natura – terra, alberi, uccelli, api, maiali, oche, uomini, donne, odori, sapori – al centro del mondo.
Radici Al centro del mondo
Ha radici importanti questo ultimo romanzo di Alessio Torino. Alcune – Tozzi, Faulkner, Volponi… – sono dichiarate già dalla quarta di copertina, altre si svelano lentamente; e se le prime sono chiavi di lettura affidabili, le altre ci aprono davvero i recessi della vicenda narrata. Nella triste figura del protagonista si rintracciano nitidamente i lineamenti di quella «grande dinastia di idioti» inaugurata da Cervantes e alimentata da Dostoevskij. Nei modi grossolani e castranti di zio Vince rivivono le intemperanze di Domenico Rosi (padre padrone di Pietro in Con gli occhi chiusi), nella sua frenesia di sbarazzarsi di Villa la Croce si ridefinisce e si inabissa l’inadeguatezza di Remigio, inetto proprietario del Podere. Nelle pagine dov’è più intenso il dolore feroce della lacerazione storica tra la natura e l’uomo, dov’è più grande la ferita dei legami recisi tra i padri e i figli, tra la famiglia e la società e tra la società e le sue parti, lì si sente – e non è solo un’eco – l’urlo e il furore. E se Damiano ci appare, in qualche modo, fratello minore di Damìn (per entrambi, ad esempio, «il centro del mondo che ogni giorno cresceva e si illuminava sempre di più era la splendida figura del nonno», P. Volponi, Il lanciatore di giavellotto, Einaudi 1981, p.9), d’altra parte l’intera narrazione si direbbe attraversata dalle linee di tensione scaturite dal conflitto tra progresso tecnologico ed economico e impoverimento delle relazioni, che è tema caro a Volponi.
Ma se, dentro un perimetro al tempo stesso così ampio e così netto, volessimo indicare la radice più pura di questa storia, la cercheremmo in Billy Budd, il romanzo, appartenuto al padre, che Damiano sfoglia ossessivamente:
Avrebbe voluto leggere Billy Budd da cima a fondo, ma c’erano pagine troppo complicate. Gli piaceva ritrovare i segni fatti dal padre e leggere le frasi che lui aveva sottolineato. Erano come isolate e gli sembrava che bastassero per tutto il resto. In un solo caso il padre aveva usato un inchiostro rosso, quasi all’inizio, quando si cominciava a parlare del marinaio Billy Budd. “Era analfabeta” aveva sottolineato, Damiano non sapeva perché. E poi “La vita nella coffa di trinchetto ben s’accordava a Billy Budd”, aggiungendo qui tre segni verticali di lato. Però era strano, pensò, nelle ultime pagine dove Billy Budd è impiccato sul pennone per quel pugno, il padre non aveva sottolineato né annotato nulla. (p.163)
È lì, nel groviglio spaventoso di innocenza e colpevolezza, di legge della natura e leggi degli uomini, di impotenza e onnipotenza, che affonda la radice narrativa più estesa. Imperdonabile agli occhi di tutti (tranne che dei nonni), Damiano si macchia con candida premeditazione di gesti delittuosi e sublimi, eroe socialmente pericoloso e naturalmente indiscusso, vendicatore non richiesto e necessario delle offese arrecate dal mondo-altro al centro del mondo – offese spesso inconsapevoli e pertanto vieppiù oltraggiose, nel loro sottintendere l’ignoranza o la trascuratezza dei segni e dei sensi:
L’olandese alto intanto si era incamminato lungo il muro della casa di Nonna Adele. Damiano lo vide saltare sul prato e sbandierare la giacca della tuta. Se lo immaginò seduto sulla sedia del nonno, con le gambe troppo lunghe e la testa troppo vicina ai fiori. Se lo immaginò che apriva i cassetti della cucina di Nonna Adele, tirava fuori piatti e posate e li esaminava uno per uno. Avrebbe dormito in diagonale nel letto dei nonni, un sonno duro che non s’interrompeva neanche con il sole pieno in camera. (p.198)
Le voci Al centro del mondo
Agli oltraggi come ai rimproveri, alle domande come alle proposte, Damiano non risponde quasi mai con le parole; semplicemente, come un nuovo Bartleby, si sottrae ai discorsi col silenzio e le sue battute di dialogo per larghissima parte sono fatte così: «…». Il lettore, che raramente ne ascolta la voce, ne conosce tuttavia lo sguardo sulle cose e le persone. La voce narrante, esterna, procede infatti come una telecamera per una ripresa in soggettiva. Da principio l’artificio della regressione (che è di Verga, in primis, e di altri grandi narratori del vero) investe tutti i personaggi e gli ambienti: gli eventi e i loro attori sono restituiti attraverso il prisma dello sguardo di tutti su tutti. È così – per esempio – che all’inizio viene messa a fuoco la figura del protagonista. Lo guarda la nonna:
«Lo sai» disse Nonna Adele «chi fa sempre la stessa strada nei campi?»
«No.»
«Le bestie.»
«…»
«Le bestie e te.»
«Io…»
«Ti ho visto.»
«…»
«Fai il segno nel campo come i caprioli.»
«…»
«Domani passi sotto la quercia.»
«…»
«E vedrai che non ti succede niente.» (p.30)
Lo guarda l’Anna:
(…) si accorse di Damiano che camminava nel campo come un mentecatto. Una falcata lunga, poi una breve, poi una ancora lunga, un’altra con il ginocchio sospeso per aria, incerto, come se dovesse uscire da un campo minato. Avrebbe dovuto provare pietà, l’Anna. Invece ogni volta pensava che Dio doveva spazzare via i Bacciardi dalla faccia della terra. Damiano Bacciardi per primo. (…) Lei capiva, ma non poteva avere pietà, no, perché non si fidava. (p.27)
Lo guarda la sua insegnante di lettere:
Non aveva mai confessato a qualcuno dei familiari che aveva paura della pietra delle case. Lo aveva scritto una volta in un tema. La professoressa, il giorno che l’aveva riportato, ne aveva letto un pezzo ad alta voce – mentre lui l’ascoltava rimanendo con le gambe accavallate, la punta del gomito sulla coscia e il pugno sotto il mento, in quella che l’insegnante di sostegno chiamava la postura di chiusura. Alla fine la professoressa aveva detto: «Un non so cosa di bello c’è». Appena andava via il sole, aveva scritto Damiano, la pietra rivelava la propria natura. Come se qualcosa di più grande del sole, più imponente e presente del sole, abbandonasse Villa la Croce. (p.21)
Ma poi lentamente, quasi impercettibilmente, il campo si stringe e a condurre il lettore attraverso la storia è lo sguardo eccitato di Damiano. Gli accadimenti continuano a essere narrati nel rispetto scrupoloso della diacronia, ma la loro coerenza interna nelle relazioni di causa-effetto sembra quasi interamente imposta dalla lente attraverso cui Damiano li osserva. Probabilmente è per questo che il mondo, fuori Villa la Croce, si riduce a pochissimi luoghi e a pochissimi oggetti, tutti minacciosi: il luna park dove s’imboscano i due macedoni, i primi grotteschi complici di zio Vince nei tentativi di vendita del podere; il supermercato da cui proviene il patetico alberello di Natale dell’Anna, che faceva una piccola aurora blu (p.187); la più grande concessionaria di trattori e mietitrebbia (p.132) del padre di Teo, un pittore di strada spiantato conosciuto per caso al mercato; e quell’Olanda da cui arrivano i potenziali acquirenti di Villa la Croce:
Parlavano la lingua dei porci. Erano arrivati con un fuoristrada direttamente da Groninga e ora lo stradone era pieno di quei suoni che uscivano dal naso e dal fondo della gola come sputi di catarro. Da dietro le persiane della cucina di zio Vince, Damiano provò a tapparsi le orecchie. Dal modo in cui si atteggiavano non sembravano del tutto padroni di se stessi, ma come presi da una smania che si erano portati dietro dall’Olanda. Uno era vestito con la giacca elegante e una maglietta con dei mostri gialli, un altro con la tuta del Chelsea, il terzo con una camicia dalle maniche risvoltate e una cravatta. (…) Forse non erano gli olandesi che dovevano stare un mese da loro, pensò, ma davvero i porci di Baldeschi. Venduti, trasformati in uomini e tornati a Villa la Croce (p.197).
Come gli olandesi, tutto il mondo fuori Villa la Croce parla una lingua che è frastuono, a difendersi dal quale non vale tapparsi le orecchie e nel quale è difficile udire la voce della natura. Damiano la sente invece forte e chiara, ne sente il richiamo – sia esso ronzio operoso di api (virgiliane? forse, finché non uccidono), sterminato odore dei fiori (p.211), grazia lenta della vecchiaia del nonno (p.165) o bisogno di rilasciarsi a fiotti dentro Joyce (p.210), la giovane olandese che vorrebbe, salvandola dal branco, fare sua sposa. E finalmente, zittiti i nemici, a quella voce Damiano si restituisce e s’arrende, non più solo ombra del ragazzo quercia (p.90), ma «quercia, giovane, vecchia, forte, come l’albero che aveva sorretto suo padre, una quercia che sapeva molte cose ma che non le avrebbe mai potute raccontare» (p.259).
Si conclude così senza finire una storia che, se ha una data d’inizio (9 aprile 2017, avrebbero registrato gli archivi del nonno, p.67), del tempo disperde poi le sovrastrutture degli uomini, recuperandone il solo fluire. È una storia col fiato robusto e la parola corposa della narrazione realista, ma anche col respiro lungo e talvolta sfuggente della parabola; e per questo talvolta può risultare sospesa in un limbo. Ma è serio l’intento che la sostiene e meditata la parola; e a chi la legge, dunque, non mancano solidi appigli e, come s’è tentato di illustrare, molte buone ragioni.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 La controriforma di lunga durata della scuola e i venti di guerra
La controriforma di lunga durata della scuola e i venti di guerra -
 ʃconnessioni precarie, Nella terza guerra mondiale. Un lessico politico per le lotte del presente
ʃconnessioni precarie, Nella terza guerra mondiale. Un lessico politico per le lotte del presente -
 A che serve la poesia? Parole da Gaza
A che serve la poesia? Parole da Gaza -
 La pigra potenza. Filmare Sandro Penna tra documento, cinema sperimentale e televisione
La pigra potenza. Filmare Sandro Penna tra documento, cinema sperimentale e televisione -
-
La scrittura e noi
-
 Proposte per giovani lettori – La porta delle stelle. Un racconto di Natale di Ingvild Rishøi
Proposte per giovani lettori – La porta delle stelle. Un racconto di Natale di Ingvild Rishøi -
 Inchiesta sulla letteratura Working class /5 – Matteo Rusconi
Inchiesta sulla letteratura Working class /5 – Matteo Rusconi -
 Storie di famiglie. Su Una famiglia americana di Joyce Carol Oates
Storie di famiglie. Su Una famiglia americana di Joyce Carol Oates -
 Inchiesta sulla letteratura Working class /4 – Fabio Franzin
Inchiesta sulla letteratura Working class /4 – Fabio Franzin -
-
La scuola e noi
-
 Scuola e Gnac
Scuola e Gnac -
 Indagine sul Lonfo (con ripasso)
Indagine sul Lonfo (con ripasso) -
 QUASI DISCRETO = 6/7 = 6.75 = VA BENINO?
QUASI DISCRETO = 6/7 = 6.75 = VA BENINO? -
 Tradire Manzoni? Una proposta didattica su “The Betrothed” di Michael Moore
Tradire Manzoni? Una proposta didattica su “The Betrothed” di Michael Moore -
-
Il presente e noi
-
 La zeppa delle elezioni regionali
La zeppa delle elezioni regionali -
 Non più di 20 per classe – Il nostro sostegno alla proposta di legge per un’istruzione di qualità
Non più di 20 per classe – Il nostro sostegno alla proposta di legge per un’istruzione di qualità -
 Su Il sentiero azzurro (O Último Azul) di Gabriel Mascaro
Su Il sentiero azzurro (O Último Azul) di Gabriel Mascaro -
 Un “collegio” dei docenti nazionale per Gaza
Un “collegio” dei docenti nazionale per Gaza -
Commenti recenti
- Franca Antonia Di Liddo su Non più di 20 per classe – Il nostro sostegno alla proposta di legge per un’istruzione di qualitàLe classi, anche di 20 alunni, sono ormai eterogenee per modalità di apprendimento, per condizioni…
- Federica Ivaldi su Non più di 20 per classe – Il nostro sostegno alla proposta di legge per un’istruzione di qualitàIndividualizzare, progettare, costruire rapporti, valutare con coscienza e spendersi per la formazione dei nostri studenti…
- Eros Barone su ʃconnessioni precarie, Nella terza guerra mondiale. Un lessico politico per le lotte del presentePer quanto riguarda la concezione dell’Europa e il connesso europeismo, sono convinto che occorre sottolineare…
- Rinaldo su QUASI DISCRETO = 6/7 = 6.75 = VA BENINO?Gentile Cristiano, quindi se ho capito bene lei e’ il prof Corsini. Io mi riferivo…
- Cristiano su QUASI DISCRETO = 6/7 = 6.75 = VA BENINO?Gentile Rinaldo, lei ha chiamato in causa me (o era un mio omonimo?) affermando che…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento