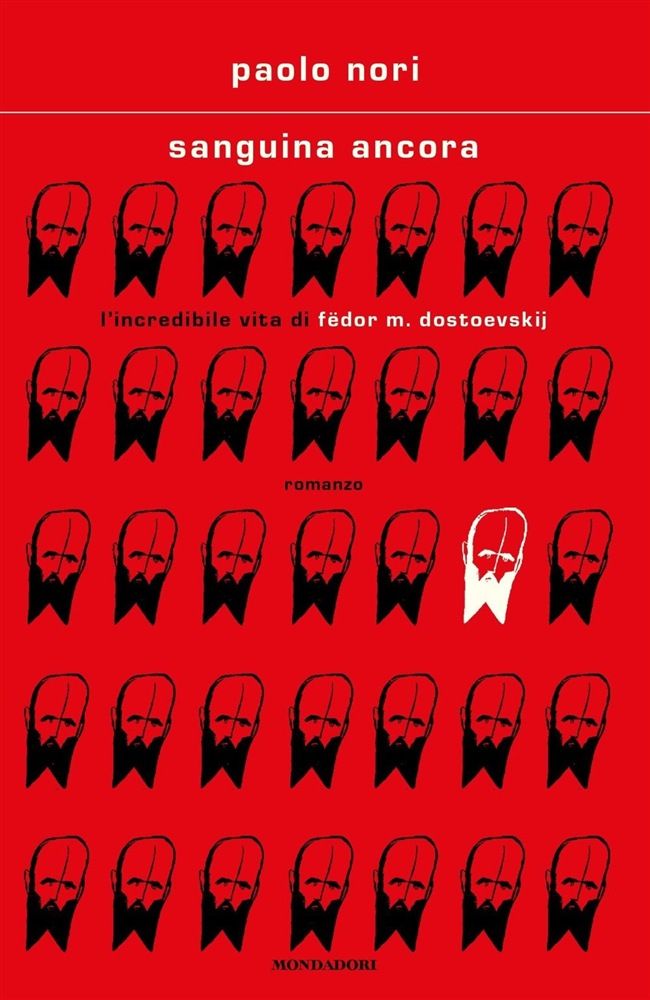
Sanguina ancora: l’incredibile vita di Dostoevskij raccontata da Paolo Nori
Che senso ha, oggi, nel 2021, leggere Dostoevskij?
Perché una persona di venti, o di trenta, o di quaranta, o di settant’anni dovrebbe mettersi, oggi, a leggere, o a rileggere, Dostoevskij?
Ecco.
Domanda che non mi mette minimamente in imbarazzo.
La mia risposta è: non lo so.
Io, qualsiasi domanda mi si faccia, rispondo quasi sempre, come prima cosa, che non lo so. Poi, delle volte, vado avanti.
In questo caso, se mi si chiedesse che senso ha, oggi, nel 2021, leggere, o rileggere, Dostoevskij, direi che non lo so.
Poi andrei avanti.
(Paolo Nori, Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij, Mondadori, 2021, p.7)
CHE SENSO HA, OGGI, LEGGERE, O RILEGGERE, DOSTOEVSKIJ?
E va bene. Ammettiamo che sia vero. Ammettiamo che Paolo Nori – studioso, traduttore e curatore delle opere non solo di Dostoevskij ma di tanti altri autori russi (Puškin, Gogol’, Tolstoj, Čechov…) – non sappia rispondere alla domanda “Perché leggere Dostoevskij?”. Ammettiamo che non voglia sforzarsi di farlo nemmeno incalzato dalla ricorrenza del bicentenario della nascita dello scrittore. Ammettiamo che (lo ha dichiarato nell’intervista rilasciata a Roberto Festa per il Venerdì di Repubblica, 09.04.2021, p.92) abbia avuto paura a ripercorrere, a cinquantasette anni, le emozioni provate a quindici, a riaprire la ferita prodotta da quella prima lettura di Delitto e castigo, a scoprire che «sanguina ancora», perché non ha ancora trovato risposta per sé alla domanda già così lacerante per Raskol’nikov: “Ma io, sono come un insetto o sono come Napoleone?”. Ammettiamolo. Però a questo punto l’interrogativo per il lettore potrebbe diventare “Perché leggere Paolo Nori che ci racconta Dostoevskij, se ammette di non sapere perché leggere Dostoevskij?”. Perché in questo libro Dostoevskij c’entra moltissimo ma non c’entra affatto; perché questo libro non è la biografia di un celebre scrittore, ma è un romanzo, anzi, quasi un romanzo di formazione; e il protagonista non è esattamente Dostoevskij, ma è un uomo che, da ragazzo che era, è diventato adulto leggendo Dostoevskij (e non solo). Ed è un’altra storia; davvero, è tutta un’altra storia.
Ora, io non conosco la motivazione con la quale la giuria del Campiello ha inserito questo romanzo nella cinquina, ma non nascondo di esserne stata contenta e di aver pensato “L’avevo detto, io, che era tutta un’altra storia!”. L’avevo detto, mentre qualcuno storceva il muso, quasi che Nori avesse dileggiato un mostro sacro, raccontandone aneddoti e tic a quel modo apparentemente svagato e divagante che sembra buttare tutto in burletta. Ma io non mi sono mai sentita burlata da Nori. Ho riso, a tratti, lo confesso; ma per lo più mi sono commossa, e mi sono trovata a mio agio, fra le pagine di questo suo libro, come fra le stanze di casa mia. Perché anch’io
Delitto e castigo l’ho letto che avevo forse quindici anni, son passati ormai quarantun anni e, di quel momento in cui ho incontrato Delitto e castigo, io mi ricordo tutto; mi ricordo la stanza dov’ero, la mia stanzetta all’ultimo piano della nostra casi di campagna, mi ricordo com’ero voltato, mi ricordo l’ora del giorno, mi ricordo lo stupore di quello che stava succedendo, mi ricordo che mi chiedevo nella mia testa “E io?”. (p.9)
La mia casa non era in campagna ma sul mare, dai miei quindici, di anni, ne son passati trentanove e il libro che leggevo era Guerra e pace di Tolstoj; ma mi ricordo tutto, perché
Quel libro, come i libri memorabili che ho incontrato nella mia vita, ha fatto diventare un momento qualsiasi tra gli innumerevoli momenti che ho passato nei cinquantasei (cinquantaquattro, ndr) e passa anni che sono stato al mondo un momento indimenticabile, un momento in cui ero consapevole del fatto che stavo al mondo, un momento che mi sentivo il sangue che mi pulsava dentro le vene. (p.9)
Il romanzo di Nori è il racconto di come i «libri memorabili» possano trasformare i momenti qualsiasi delle nostre vite in momenti indimenticabili, in consapevolezza pulsante di noi.
UN «PAZZO BENEDETTO»
Certo, questo racconto passa anche attraverso il racconto dell’«incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij». Nori la condensa in pochi tratti folgoranti all’inizio del romanzo:
ingegnere senza vocazione, traduttore umiliato dai propri editori, genio precoce della letteratura russa, nuovo Gogol’, meglio di Gogol’, aspirante rivoluzionario miseramente scoperto e condannato a morte, graziato e mandato per dieci anni in Siberia a scontare la sua colpa, riammesso poi nella capitale, (…) giocatore incapace e disperato, scrittore spiantato vittima di editori cattivi, marito innamorato di una stenografa venticinque anni più giovane di lui, padre incredulo (…), uomo dall’aspetto insignificante, (…) malato, confuso, disperato, ridicolo così simile a noi che riesce a morire nel momento del suo più grande successo. (p.10)
Però poi continua a raccontarla per intervalla, percorrendo onestamente, perfino rigorosamente, le linee secanti di diacronia e sincronia. Ma in questo movimento narrativo trova spazio il racconto di un’altra diacronia e di un’altra sincronia, quella di se stesso lettore, studioso, traduttore di Dostoevskij. E quietamente ma risolutamente marcando le distanze dai formalisti russi (perché «a me, questi signori, son sempre sembrati delle gente che si china sopra le opere letterarie come un meccanico si china sopra un motore e si chiede se funziona, e perché», «che si propone di concentrare la propria attenzione non tanto su cosa significa un’opera letteraria o sul perché è stata scritta, ma su come è fatta», p.162), Nori confessa con candore di non ritenere sbagliato «parlare di Tolstoj (ovvero di Dostoevskij, ndr) parlando di me» (ovvero di sé), perché
I romanzi di Tolstoj, e di Dostoevskij, sono opere d’arte perché non parlano solo la lingua “superiore dell’arte”, non rispondono solo alle “nobili necessità dell’anima”, parlano di me, delle mie miserie, delle mie paure, delle mie ferite, della mia famiglia, del mio essere solo, senza un babbo, senza una mamma, a cinquantasette anni, un ridicolo, vecchio orfano parmigiano che abita a Casalecchio di Reno. (p.156)
In questa prospettiva, niente di strano che, mentre racconta di Dostoevskij, Nori passi a raccontare di sua moglie («la mamma di mia figlia, che ha un carattere un po’ così, deciso, è laureata in Storia dell’Unione Sovietica e io la chiamo Togliatti, perché lei è profondamente, intimamente, indubitabilmente convinta di essere “il migliore”, p.15), di sua figlia detta “La Battaglia”, e di Benjamin, Gadamer, Heidegger e Bachtin, o ancora di Antonio Pennacchi («questo romanzo su Dostoevskij, che io lo chiamo romanzo senza essere sicuro che sia un romanzo, se non ci fosse stato Pennacchi forse non l’avrei mai scritto», p.208) o di Berlusconi («È stato un po’, in un certo senso, il protagonista di quel periodo, era talmente presente che veniva voglia di dimenticarselo, ma era difficile», p.172) o perfino di Veronica Lario («si lamentava del fatto che suo marito disertasse i compleanni dei loro figli per frequentare delle ragazze poco vestite, alcune molto giovani, nei dopocena», pp.172-173, due paginette esilaranti).
IL PERDENTE
E però, a furia di leggerlo, e studiarlo, e tradurlo, Nori finisce quasi per introiettarlo, questo Dostoevskij, fino a farne suo perfino lo stile paradossale, quella “orrenda scrittura” già osservata da Tolstoj (che intendeva fargli un complimento, però; come ci spiega lo stesso Nori nell’intervista di cui sopra, e anche a p.188 del suo romanzo). Ecco, solo a titolo d’esempio, il personaggio Paolo Nori nelle vesti di perfetto idiota dostoevskijano:
Mi sono ricordato di una volta che, avevo appena incominciato ad abitare con Togliatti (nom de plume, come s’è visto, della moglie, ndr), e avevo appena firmato un contratto con una grande casa editrice che si chiama Einaudi, e una sera, non so perché, non lo facevo quasi mai, ma, aspettando che Togliatti tornasse a casa, mi ero messo a lavare i piatti e, intanto che lavavo i piatti, “Ma pensa” avevo pensato, “uno che sta per firmare un contratto con una grande casa editrice che si chiama Einaudi, guarda qua che lava i piatti. Che umiltà” avevo pensato, e poi mi ero fermato nel mio lavare, “Ma sei deficiente?” avevo pensato.
Ero deficiente.
Mi succede, di essere deficiente, abbastanza spesso, anche. (pp.18-19)
Non è che una delle moltissime digressioni cui Nori piega, senza usargli forza, il racconto della incredibile vita di Fëdor Michajlovič. Di alcune di queste digressioni è marcato con chiarezza il punto di tangenza con il plot principale: è il caso in cui il narratore sconfina nel racconto della vita o delle opere di altri scrittori con cui Dostoevskij era venuto direttamente o indirettamente a confronto (straordinarie le pagine su Puškin e Gogol’), o delle donne di cui si era innamorato, o degli editori con cui aveva lavorato, o del fratello con cui era costantemente in contatto etc., cioè con tutte quelle figure che hanno effettivamente incrociato la sua strada e che lo hanno agevolato oppure ostacolato nel percorrerla. Ma per altre digressioni, no; per altre il punto di tangenza va cercato, rintracciato in una somiglianza di sangue ovvero di sanguinamento:
Uno, mi rendo conto, potrebbe chiedermi: Ma a te piace sanguinare?
In un certo senso, sì.
Nel senso che viviamo, mi sembra, in un tempo in cui valgono solo le vittorie e i vincenti, un tempo in cui il participio presente perdente non indica una condizione temporanea, è un’offesa, in un tempo in cui, se ti chiedono «Come stai?» (e te lo chiedono, continuamente), devi rispondere «Benissimo!» col punto esclamativo, in un tempo in cui devi nascondere le tue ferite e i tuoi dispiaceri, come se tu non fossi fatto di quelle, e di quelli. (p.11)
E Nori sembra a tratti quel Petronio arbitro del racconto tacitiano (Annales, XVI, 18) che, recise le vene, le chiude e le riapre, discorrendo via via che il sangue scorre: così il narratore riapre e richiude la ferita e la guarda sanguinare; e forse un poco questo suo modo di procedere può sconcertare, ma è seducente quanto sa esserlo un elegantiae arbiter perdente.
Perché lì è il punto di tangenza: nell’essere perdente senza che questo implichi rinuncia. Anche il perdente Dostoevskij, «ci resta molto male, ma non rinuncia nemmeno dopo l’insuccesso. Non aveva paura, degli insuccessi» (p.22): Dostoevskij è il terapeuta della «ritrosogna». Questo sentimento, altre volte teorizzato da Paolo Nori, viene qui nuovamente ripreso con convizione:
Quel sentimento lì io l’ho riconosciuto, la prima volta, una volta che andavo a prendere una ragazza in stazione, era la prima volta che veniva a trovarmi, a Parma, abitavo a Parma, allora, e intanto che andavo in stazione, mi piaceva tanto, quella ragazza lì, intanto che andavo in stazione mi dicevo “Ma dove credi di andare, ma cosa credi di combinare, ma torna indietro, ma vai a casa”.
Era un misto di ritrosia e di vergogna, ritrosogna, si potrebbe chiamare, che brutto nome, ritrosogna, ecco io la ritrosogna, son passati vent’anni, e quella ragazza lì è diventata la mamma di mia figlia ma io la ritrosogna ce l’ho ancora (…). E anche quando ho cominciato a scrivere questo libro sulla vita di Dostoevskij, nella mia testa mi dicevo “Ma cosa credi di fare, ma cosa vuoi scrivere, ma cosa credi di combinare, ma pianta lì”, invece adesso non pianto lì, vado avanti. (p.12)
Novello uomo del sottosuolo («è quello che mi assomiglia di più, secondo me. E non c’è da vantarsene», p.197), anche Nori, come Dostoevskij e i suoi personaggi, sembra stupirsi «spesso, non dell’ignoranza altrui, ma della propria ignoranza, dei propri difetti, della propria cattiveria, delle proprie limitazioni» e, come loro, sembra che «invece di nasconderli, li metta in mostra: guardate, guardate che spettacolo» (p.20). Ed è davvero uno spettacolo, perché quest’uomo dostoevskijano, «consapevole di non essere stato capace di diventare niente, né cattivo né buono, né disonesto né onesto, né un eroe né un insetto» (p.196), quest’uomo che, come nel racconto del principe Myškin, «ne ha persi tanti, di minuti» (p.128), forse proprio per questo, uscendo dal sottosuolo, quando di minuti da vivere non gliene resta che una manciata, sceglie di contemplare i tetti che brillano al sole (cfr.pp.126-127), consegnando anche al lettore, condensato in un momento, il senso di una vita intera: «l’esperienza di essere il riflesso dorato di una cupola» (p.128). E questa è già, da sola, ragion sufficiente per leggere Dostoevskij, ma anche per leggere Nori mentre ci accompagna a vedere il riflesso.
Articoli correlati
No related posts.
Comments (2)
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Ho letto questo articolo dopo aver letto Nori e intanto che mi è venuta voglia di rileggere Dostoevskij. Mi è piaciuto tanto Nori, l’articolo e Dostoevskij.
Il volontario intreccio della vita dei due in “Sanguina ancora” tradisce l egocentrismo subdolo di Nori,ma contribuisce alla riscoperta di Dostoevskij da parte di chi ha fatto in tempo a conoscerlo e a dimenticarlo.
Per cui va riconosciuto il merito del primo di aver fatto rileggere lo scrittore russo, con una maggior leggerezza rispetto a qualsiasi, ulteriore , biografia si volesse scrivere del grande Dostoevskij.
Antonella