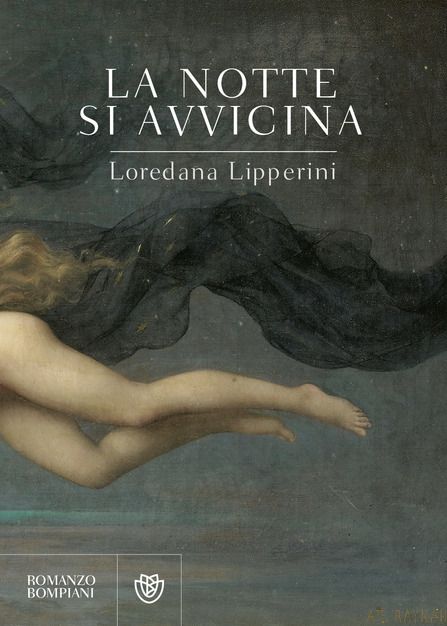
La notte si avvicina (ma le stelle-stelline no): sull’ultimo romanzo di Loredana Lipperini
Storie di donne
Ho letto La notte si avvicina (Bompiani, 2020), l’ultimo romanzo di Loredana Lipperini, nei giorni in cui lavoravo a un progetto di formazione alle Pari opportunità della mia scuola. Teresa, l’amica-collega di Storia e Filosofia, lo porta avanti da anni, senza retorica e senza rivendicazionismo, e mi aveva chiesto di tracciare per gli studenti e le studentesse la parabola delle donne della letteratura: donne-autrici e donne-immaginate, donne-scrittrici e donne-scritte. Voleva che mi concentrassi in particolare sul Novecento e sulla contemporaneità. Sul percorso sensato e assennato che mi pareva di aver individuato, quest’altra storia di donne, raccontata da una donna, è stata per me come una pietra d’inciampo. Proverò a spiegare perché.
«L’inizio è plurale» (ma forse anche l’epilogo)
Il romanzo (candidato allo Strega) racconta di una moderna pestilenza che – come quella di tanti scrittori e scrittrici che ne hanno raccontata (bene) una (e in quest’epoca di pandemia non abbiamo mancato di passarle in rassegna tutte, le epidemie letterarie, insieme alle consorelle apocalissi) – è l’evento rivelatore del male, e del bene quando c’è. A scatenarla è l’unico uomo che, nel romanzo, compia un’azione di qualche rilievo: Fabrizio «uno scienziato che pecca di superbia, come molti prima di lui» (p.35), un biologo che «isola le proteine del batterio Yersina pestis»: «ventisei sono le proteine che cattura e ignora le macchie che gli appaiono, quasi invisibili, sulla gamba destra, convincendosi che un contagio non era possibile» (p.34). In quella fatale estate 2008, nel bosco che costeggia lo sperduto paese marchigiano di Vallescura («un paese come gli altri ma diverso da tutti gli altri, perché ha un cuore nero», p.257), Fabrizio, stremato dalla febbre e dall’arsura, incontra Maria, che nel bosco c’è venuta però cercando il suicidio. Maria è una illustratrice che, rimasta vedova molto giovane, s’è ritrovata ingiustamente vittima della feroce emarginazione del piccolo gruppo delle «mammeperfette» (p.247), cioè le madri dei compagni di classe dei suoi bambini. Privata dei figli dai servizi sociali, incapace di continuare a vivere circondata dagli oggetti del suo passato, ha scelto di lasciare Roma e di andare ad abitare, in compagnia dell’alcool, in quel piccolo borgo selvaggio; che tuttavia l’ha da subito respinta con astio e con sospetto. A guidare quella sorta di caccia alla strega, tanto più dolorosa quanto più inspiegabile (Maria è mite, timida, provata, apparentemente inoffensiva), è stata Saretta:
Era il cuore del paese, Saretta, tutti aspettavano una sua parola o una sguardo per decidere cosa fare (…). Era stata la prima bambina a nascere lì, la prima a giocare a campana e alla corda nei vicoli che allora erano coperti di paglia sporca sopra i sassi di fiume. La prima a mangiare mele acerbe a cavalcioni del mezzo tronco che univa le sponde, prima che venisse costruito il ponte. La sola bambina che aveva guardato, nascosta dietro il vecchio salice che cresceva vicino alla fontana, il gruppetto di vecchi che versava liquido da un bidone sulla soglia e sotto le finestre e poi dentro le finestre della casa sul fiume, e poi uno di loro aveva gettato la torcia accesa e la casa stessa aveva fatto viummm ed era bruciata, e da dentro si sentiva urlare come il maiale quando viene scannato, e poi nulla, c’erano stati solo i riflessi gialli e rossi sulle foglie del salice e sul suo viso. (p.69)
Maria, nonostante sia decisa a non tornare da chi non la vuole, ignara della malattia contratta da Fabrizio, sceglie di aiutarlo a raggiungere il paese, per cercare soccorso; ma il biologo, ormai in fin di vita, le rivela di quale male soffra. E a quel punto Maria, consapevole di essersi esposta al contagio, matura lucidamente un piano di vendetta. Questo però è solo l’epilogo e la voce narrante (chi sia è una sorpresa per il lettore) lo racconterà nel sottofinale, senza risparmio ma anche senza accordargli più spazio di quanto invece ne accordi a «cercare altri inizi»:
I fatti non sono mai sufficienti: perché quello che bisogna trovare, sepolto dalla carta e dalle immagini e dalle parole con cui si espongono e si ripetono i fatti per svuotarli, è il motivo per cui nessuno si è accorto di quello che è accaduto prima di quel giorno. Per questo è importante cercare altri inizi, che non sono legati ai fatti, ma coincidono, uno dopo l’altro, con la fine di un’epoca e con l’apertura di un nuovo ciclo che ha portato al nostro tempo (… ) L’inizio passa sempre inosservato, come tutto ciò che segna una disaffezione. (p.35)
«L’inizio è plurale» (p.39) e ha la sua genesi nelle storie delle donne (Maria, Saretta, Chiara, Aurelia, Carmen, ma anche le «mammeperfette» di Roma come di Vallescura) che sono protagoniste del romanzo e che insieme però non fanno mai un coro: le loro vite s’incontrano, si scontrano, s’intrecciano, si annientano a vicenda, senza che le loro voci parlino all’unisono, senza che nessuna tenti di definire uno spazio comune di azione solidale; al contrario, ognuna tira dritta lungo la sua retta e «the woman’s angle» (sul quale Virginia Woolf s’interrogava già nel 1935) si dilata, si deforma, perde ogni aspirazione, istanza, velleità di ripetersi, misurato e costante, agli spigoli di uno spazio equilatero.
L’inizio è plurale, dunque, e lo svolgimento è scaleno.
Lo svolgimento è scaleno
La suggestione mi viene da Nadia Fusini, autrice (tra l’altro) di un saggio (prezioso) del 2013:
Rispetto a “equilatero” e “isoscele”, (“scaleno”) mi appare più irregolare e più adatto a definire l’ “angolo” al femminile. Sento in quel termine l’idea di qualcosa che non è piano, ma diseguale. Così io penso le donne: tutte, una per una, diseguali, e niente affatto piane, ma ricche di pieghe, complesse, plissé. Deprivate fin dalla nascita di un significante universale – perché in tal caso dobbiamo arrenderci all’unico provvisto dalla lingua e riconoscerci “uomini” anche noi, nei discorsi grandi, ufficiali – non possiamo che ravvolgerci nelle pieghe dell’essere e del sembrare, e scovare, lì, in quella complessità, il nascondiglio della nostra malcelata identità. (N. Fusini, Hannah e le altre, Einaudi, 2013, pp.4-5)
Mi è tornata in mente come una folgorazione leggendo la scena finale del romanzo, quando, nel bosco in fiamme di Vallescura, s’incontrano, per una specie di redde rationem, Maria, Saretta e Chiara. Quest’ultima, romana pure lei, è una scrittrice di poco conto, che ha «perso, pezzo dopo pezzo, gli entusiasmi», una «donna malinconica (…) che guarda tutto e che niente riesce a toccare» (p.290); in paese per qualche tempo, ospite dell’amata suocera Aurelia, ha guardato appunto con attenzione tanto Saretta che Maria e, avendo più o meno confusamente compreso le intenzioni persecutorie dell’una e la pericolosa fragilità dell’altra, prova a raggiungere segretamente quella che lei crede la vittima. Saretta la segue, e, «terribile» ma «quasi bella, sotto i raggi della luna» (proprio lei, che è grassa, vecchia, priva d’ogni grazia), «mentre sul suo viso il riflesso delle fiamme si mescola con l’argento» (p.332), affronta le due straniere con parole ipnotiche:
Ti sei mai chiesta, Maria, perché non sei riuscita ad andartene? Potevi cercare un altro rifugio e non l’hai mai fatto. Non è vero?
Maria annuisce, affascinata, fra le braccia di Chiara.
Non l’hai fatto perché Aradia [1] ha due facce, anzi tre. E Aradia ti concedeva la possibilità di distruggere come concedeva a me la possibilità di fermarti. (…)
Chiara scuote la testa. Queste, dice, sono follie. È una follia rimanere qui, con l’incendio alle spalle, a parlare di streghe. Le streghe non esistono.
Saretta ride.
E tu perché sei qui, allora? Anche tu potevi andartene. Potevi portare via Aurelia da molto tempo. Eppure sei rimasta, rischiando la tua vita. Anche tu hai un ruolo. Sei la terza faccia. Aradia è anche amore, e ragione. Tu sei in un certo senso l’ago della bilancia. (p.332-333)
Intorno a questa strega una e trina si dispone un sabba di streghe minori ma non meno insidiose, che infrange il recinto politicamente corretto di certa letteratura al femminile e il mito della solidarietà tra donne. Non necessariamente nemiche, eppure mai autenticamente amiche, le donne di questo romanzo sono pervase da una forza antica, ancestrale, che le rende capaci di generare e distruggere, di conservare con senno o dilapidare per amore. È una forza incontrollabile e oscuri sono pertanto i sensi di colpa, come se non traessero origine da quello che, al giudizio comune, è il male perpetrato sugli altri, ma da un peccato originale: il peccato di essere madri. Madri amorevoli. Madri deprivate. Madri fallite. Madri impedite, aspiranti, in potenza… Non importa la declinazione: importa che sia quello l’atomo, il nucleo irriducibile della loro “stregoneria”.
Stabat mater
Lipperini non ha mai fatto mistero del suo apprezzamento per Stephen King, e in particolare per il suo primo romanzo, Carrie (e non nella versione di Brian De Palma, che lei definisce pop). E certamente ci viene in mente Carrie, quando vediamo esplodere, dopo tanto subire, l’atroce vendetta di Maria; vendetta che però non si limita a travolgere il paese che l’ha respinta, ma si serve come strumento di colei che Maria individua come scaturigine di tutti i suoi mali, Virginia, la capitana delle «mammeperfette» e, tra di loro, l’unica superstite: le altre hanno già fatto una brutta fine. Non è di questa vendetta, tuttavia, che Maria si sente colpevole: «Io non sono una persona cattiva. Non lo sono mai stata» – dice a Chiara che tenta di riportarla in paese, mentre nel bosco divampa l’incendio – «Forse sono stata egoista, forse ho pensato troppo ai miei figli, o meglio a me attraverso i miei figli. (…) Non ho fatto male a nessuno, e me li hanno tolti» (p.331). Sono solo (come vorrebbe Chiara, interpretando la parte ragionevole di Aradia) «due donne che delirano, una prendendosi colpe che non ha, (…) e l’altra che cerca di trovare un colpevole per la sua stessa infelicità»? (p.331). Non la pensava così, Chiara, a tre giorni dall’esplosione dalla pestilenza: era a bordo di una piscina insieme alla suocera – quell’Aurelia che le vuol bene «anche se all’inizio ci è andata d’accordo ad ondate, dipendeva dal periodo, dall’umore, dalla guerra con la madre di Chiara, perché tutte le madri entrano in competizione fra loro, non c’è modo di sfuggire» (p.187); osservavano insieme con «sguardo d’intesa» (p.188) un nugolo di ragazzini male educati da genitori compiacenti e arroganti, guardiaspalle insolenti di potenziali bulli (sono pagine esemplari, andrebbero diffuse nelle scuole tra i genitori di parecchi studenti, ma questo è un altro discorso; o forse no). Allora si era ritrovata a pensare questo:
Cosa ci è successo, pensa Chiara. Quando siamo diventate così. Quando abbiamo cominciato a pensare che dovevamo annientare gli altri per i nostri figli, anzi, per noi stesse. Ci bastava che fossero felici, ma non pensavamo che gli altri dovessero diventare infelici per questo. Quale mondo, pensa ancora. E ci sarà un altro mondo, pensa inoltre (p.191).
Se un altro mondo ci sarà, sarà di Carmen (la ragazza ribelle che Chiara e Aurelia hanno preso sotto la loro protezione), che scampa alla peste come Renzo, ma che, come lui, per sopravvivere è costretta a scappare da casa: la madre (ancora una volta una madre…) avrebbe preferito ucciderla pur di impedirle di infrangere l’ordine imposto a Vallescura da Saretta; l’ordine iperprotettivo di una madre mancata (che, non a caso, gestisce un emporio di generi alimentari…) che per figlio ha adottato un intero paese e non esita, per vederlo felice, a rendere infelice «chi non lo rende omogeneo, presentabile, quieto» (p.199). Venire meno a questo compito anche per Saretta si configura come colpa:
Poteva essere una madre. Desiderava essere una madre da quando era bambina. Aveva trovato la bambola sotto l’albero di Natale (…). Era la prima bambola della sua vita, e doveva essere costosa. (…) Non ha mai saputo perché le avessero regalato la bambola. Forse perché, anche se grassa e sgraziata, era l’unica figlia, e sull’unica figlia si ripongono le speranze, perché si diventa madri per questo, per riporre speranze in qualcuno che però è destinato a deluderle, o a realizzarne di diverse, perché un genitore ignora che i figli non sono e non saranno mai uguali, e forse neanche somiglianti, a quelli che vivono nella sua testa. (…) Qualcuno che l’avrebbe voluta ci fu, veramente. Era il figlio scemo del pecoraio (…). Ma Saretta non l’aveva voluto. Quella sera stessa aveva tirato fuori da sotto il letto la cesta di vimini che conteneva i suoi vecchi giocattoli. (…) Nella mano destra impugnava le forbici da sarta della madre. Ciao bambina, aveva sussurrato. (…) Stella stellina la notte si avvicina. (…) Aveva calato le forbici sulla bambola. (…) Però il patto era siglato: non sarebbe diventata madre. O meglio, suo figlio sarebbe stato il paese intero. E poi poteva diventare una strega. (…) Una strega che uccide chiunque provi a far del male al suo paese.
Non sono riuscita neanche in questo, pensa Saretta (pp.304-307)
In una lingua densa, intrisa di oggetti e di presagi, di materia e di trasfigurazioni, Lipperini racconta la colpa di essere madri, la colpa di esserlo senza un’autentica consapevolezza di cosa essere madri sia, descrivendone con acume lancinante la genesi, lo sviluppo, la sintomatologia, gli effetti indesiderati e non:
La maternità è un obiettivo? si chiede ora Maria. Volevo diventare madre perché lo consideravo un traguardo, come un bel voto sulla pagella? Volevo vincere? E alla fine, una volta diventata madre, una volta che ho partorito, sono stata una buona madre? Hanno avuto ragione a togliermi i bambini? Hanno visto in me qualcosa che io stessa non riuscivo a vedere? E se così fosse, perché non me ne sono accorta prima? Perché ho continuato a odiare gli altri? (pp.300-301)
Comincia con un senso di non coincidenza fra la mente e il corpo. Dire uno stordimento sarebbe sbagliato. (…) È un passo falso, un annebbiamento dei margini. (…) Comincia così, col fatto che intanto dormi di più. Dopo che hai mangiato, per esempio. (…) E ti è venuto sonno, proprio non riuscivi più a tenere gli occhi aperti, ti sei dovuta alzare e buttare sul divano e buio, nero, niente. Ti sei svegliata di colpo, aspirando aria perché probabilmente il sonno era così profondo che ti eri dimenticata di respirare, hai tossito, e poi hai vomitato (…). Passa. Però sei stordita. A qualunque ora. Provi a leggere, e le righe ti si confondono sotto gli occhi e devi ricominciare da capo, due, tre volte, e non riesci a dare un senso a quello che leggi. Se provi a camminare è peggio, i piedi ti si gonfiano subito (…). E poi ci sono i vestiti, non sopporti più i pantaloni, devi slacciarli dopo mezz’ora. Il reggiseno sembra filo spinato. E infine i pensieri; volano come palloncini, provi a stringere il filo ma ti sfugge sempre, e quelli se ne vanno chissà dove, non c’è un discorso logico che riesci a portare a termine, ma neanche un pensiero compiuto, solo immagini, echi, tua madre che canta creola dalla bruna aureola, il viola dell’etichetta di un 33 giri, il tavolo di marmo su cui facevi i compiti, il primo paio di collant ricamati, bianchi, una lettera di Natale con la porporina, un western che faceva paura. La paura, la paura, la paura.
Comincia così, essere madri, pensa Maria. (…) Se i bambini fossero rimasti con lei, cosa sarebbe diventata, infine? Avrebbe finito per prendere a schiaffi le insegnanti? Avrebbe attaccato briga in metropolitana con quelli che non cedevano loro il posto? Li avrebbe fatti piangere di umiliazione? E no, non avrebbe dato peso a quelle lacrime, certamente, perché quello che sarebbe contato, per lei, era lei stessa. Il suo ruolo di madre. Il suo potere di madre. (…)
Bisognerebbe impedire a chi non è in grado di accudire gli altri di diventare madri. Spiegarlo bene prima. (pp.315-317)
[1] «Aradia era la figlia della dea Diana, che scese sulla terra per insegnare la stregoneria, e al momento in cui torna da sua madre, una volta al mese quando la luna è piena, viene celebrata dalle donne che da lei hanno imparato a curare con le erbe e a fare incantesimi». (p.325)
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento