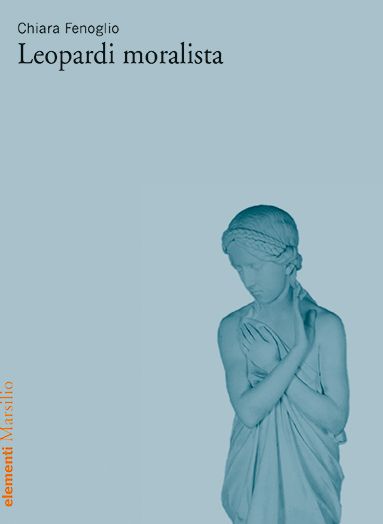
Rinnovare la letteratura per fondare una nazione: una morale politica?
È uscito, per Marsilio editore, Leopardi moralista di Chiara Fenoglio. Pubblichiamo un estratto dal capitolo quinto, ringraziando l’editore e l’autrice per la concessione.
***
Tutto proteso verso l’edificazione coerente di un sistema universale, che soddisfi le esigenze degli uomini e spieghi la natura delle cose in ogni luogo e tempo, Leopardi scende raramente nell’agone della cronaca e di una progettualità politica – quella risorgimentale – che è inequivocabilmente lo spirito dei tempi. Tra i nostri autori ottocenteschi, egli è probabilmente il meno interessato a un discorso sul genio dei popoli, eppure anch’egli quando parla di patria iscrive il suo ragionamento nella contrapposizione tra centro e periferia che caratterizza tutta la stagione risorgimentale. Così, in una lettera a Giordani dell’agosto 1823, la partenza da Roma è descritta come rientro nella propria «povera patria», come ritorno ai margini e al sepolcro, e tuttavia un ritorno assai poco doloroso se anche nel centro romano egli dice di «non aver mai saputo vivere».[1]
Dopotutto per Leopardi, come molti anni dopo per Alberto Arbasino, l’Italia è un paese senza, senza centro e senza costumi, privo di autentico senso di appartenenza, di “coscienza antropologica” e dunque anche di civiltà, perché tutto compreso nella contrapposizione di piccole patrie periferiche assimilabili a tanti sepolcri, repubblichette e città che, «formando tante nazioni […] nemiche scambievoli», fomentano fin dal medioevo «la piccolezza delle virtù patrie, e il poco splendore dello stesso eroismo».[2] Per dirla ancora con Arbasino, è un’Italia che si rituffa di continuo nei medesimi Corsi e Ricorsi storici, vivendoli di volta in volta come farse o tragedie, senza mai riuscire a prendere coscienza del fatto che si tratta di vere costanti antropologiche e non di inopinati bubboni destinati, una volta guariti, a non presentarsi più.[3]
Tuttavia, rispetto alla letteratura risorgimentale più tipica, questa dinamica centro-periferia è declinata da Leopardi in modo affatto diverso: l’orizzonte di ricomposizione identitario che, qualche anno dopo, farà dire al protagonista de Le confessioni di un italiano «Io nacqui veneziano […] e morrò per grazie di Dio italiano», manca del tutto in Leopardi. La tensione ideologica tra la periferia in cui si sente confinato e un centro nazionale sfuggente e ambito è la stessa che spinge Leopardi prima a Roma, poi a Bologna e Milano, pur in assenza di quel progetto di ricomposizione simbolica degli sparsi frammenti di una storia secolare che caratterizza l’esperienza di Nievo: quando Leopardi parla della gens italica si pone più sul fronte della polemica moralistica che non su quello dell’azione risorgimentale.[4] Inutile dunque invitare un volgo disperso a sollevare la testa, se è vero che non l’occupazione straniera del suolo italico, ma l’incivilimento ha provocato la scomparsa dell’amor patrio e la progressiva riduzione delle società fino al raggiungimento uno stato di solitudine primitiva:
Considerate le antichissime società, e vedrete che amor di patria, ossia di essa società, si trovava in ciascun individuo […]. Venite giù di mano in mano, e troverete le società sempre più ristrette e legate in proporzione dell’incivilimento. Ma che? Osservate i nostri tempi. Non solo non c’è più amor patrio, ma neanche patria. Anzi neppur famiglia. L’uomo, in quanto allo scopo, è tornato alla solitudine primitiva. L’individuo solo, forma tutta la sua società.[5]
Il problema vero non è storico né politico, ma civile: come aveva già notato Sebastiano Timpanaro, il legame tra politica e morale è in Leopardi destituito di ogni banale moralismo, fondandosi piuttosto su una idea di partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita culturale, prima che politica:[6] […] nel nostro autore manca quasi completamente la dimensione progettuale dell’indagine storica e politica, tipica per esempio del già citato Nievo: alla consapevolezza di un progetto, Leopardi sostituisce una più semplice concezione della storia come memoria. All’immagine del sacrificio, centrale nella simbologia religiosa risorgimentale, egli preferisce l’immagine del dramma, del crollo, della ruina o, per riprendere una intuizione di Giulio Bollati, dell’arretratezza che toglie consistenza alle risorse dell’immaginazione e dell’animo.[7] […] Lo sguardo sull’Italia è essenzialmente sguardo ritorto, che si volge indietro. L’Italia, nazione in fieri oltre che territorio in fieri, è emblema – nel suo non esserci ancora – del suo non esser più: itale ruine, appunto, figli sonnacchiosi che non sembrano all’altezza degli avi e che se hanno combattuto con eroismo, non si sono accorti di aver agito al servizio del tiranno di turno più che della loro patria. Per questo costoro non devono essere spronati, ma semmai consolati […].
Cosa significa dunque essere italiano, per Leopardi? Poiché è chiaro che Leopardi non esita mai a definirsi italiano, a riconoscersi in una patria insieme ideale eppur ben presente: «mia patria è l’Italia per la quale ardo d’amore, – scrive a Giordani nel ’17 – ringraziando il cielo d’avermi fatto italiano, perché alla fine la nostra letteratura, sia pur poco coltivata, è la sola figlia legittima delle due sole vere tra le antiche». Si tratta di un Leopardi giovanissimo, che espone in modo già compiuto un ambizioso progetto non individuale, ma decisamente nazionale. Rifacendosi al centro culturale di una patria comune, contrapposto alla periferia della vilissima zolla recanatese in cui è nato, egli pensa a un risorgimento che prenda avvio da «quei rarissimi ingegni che sostenendo in questa misera età l’ultimo avanzo della gloria italiana, danno speranza di vederla forse anche per loro aiuto riaversi e tornare in fiore».[8]
L’italianità dopotutto è una categoria apolitica, una categoria morale per chi, come Leopardi, la lega a ingegno, eroismo e magnanimità: in questa prospettiva, riflettere su un progetto di fondazione nazionale significa in primo luogo riflettere su una tradizione che ci sta alle spalle e ci sovrasta, trovare il modo di riconnettere questa tradizione con la nostra storia poetica, renderla fertile rispetto all’abiezione di un presente incapace di esercitare i sensi e l’immaginazione perché più morto degli stessi morti. Questo progetto, compiutamente formulato nella Canzone ad Angelo Mai, è teorizzato con notevole lucidità già in una lettera a Giuseppe Montani, datata 12 maggio 1819 (dunque due mesi prima del fallito tentativo di fuga da Recanati):
Quando bene io fossi stato di ghiaccio verso la patria, le parole di V.S. m’avrebbero infiammato: né certamente io presumo di potere altro che pochissimo […]. Secondo me non è cosa che l’Italia possa sperare finattanto ch’ella non abbia libri adattati al tempo, letti ed intesi dal comune de’ lettori, e che corrano dall’un capo all’altro di lei; cosa tanto frequente tra gli stranieri quanto inaudita in Italia.
Progettare una nazione non si può se non si hanno a disposizione i mezzi appropriati, e poiché l’amore patrio è irrecuperabile, «l’amore è sparito affatto, sparita la fede, la giustizia, l’amicizia, l’eroismo», allora si dovrà far ricorso a quei «libri veramente nazionali [atti] a destare gli spiriti addormentati di un popolo e produrre grandi avvenimenti».[9] In effetti, se non esiste alcun «fondamento di morale», né convenienze sociali adatte inventare (cioè immaginare) una nazione che nella penisola ancora manca, solo la letteratura potrà fornire quel senso di appartenenza necessario per cementare la storia di un popolo:[10] Una storia che corra su binari linguistici e culturali, ma soprattutto che proceda su quei binari con lo sguardo rivolto indietro (come sarà nel XX secolo l’angelo raffigurato da Walter Benjamin), tenendo ben fisso e presente l’esempio dei padri che custodiscono nel loro silenzio una speranza per il futuro, a fronte della rovina e della corruzione che insidiano la modernità. Ancora a Giordani, il 20 marzo 1820, discutendo di quanto occorra fare per la patria, e di quanto ancora manchi, Leopardi dichiara il suo intento: non solo creare la lirica, rifondare la filosofia, la satira e l’eloquenza, ma soprattutto dar forma a «una lingua e uno stile ch’essendo classico e antico, paia moderno e sia facile a intendere e dilettevole così al volgo come ai letterati»:[11] come preciserà in seguito nello Zibaldone, «Noi abbiamo una lingua […] ricchissima, vastissima, bellissima, potentissima […]. Ma ella è antica […] ed essendo antica non basta né si adatta tal quale ella è, a chi vuole scriver cose moderne in maniera moderna».[12]
Desta interesse che questo disegno, chiaramente culturale e a-politico, ma non per questo meno engagé, debba avere nelle intenzioni dello stesso estensore una precisa ricaduta sociale: si tratta cioè di un progetto morale, del progetto morale di chi – nel medesimo 1820 – a un altro interlocutore, il Brighenti, dichiara la sua totale sfiducia nei confronti della società,
perché tutte le classi sociali sono appestate dall’egoismo distruttore di tutto il bello e di tutto il grande; e il mondo senza entusiasmo, senza magnanimità di pensieri, senza nobiltà di azioni, è cosa piuttosto morta che viva.[13]
Se tutto ciò è vero allora è proprio la via della magnanimità (cioè della morale, della filosofia e della letteratura) che bisogna percorrere per dar forma e senso a una proposta che possa avere respiro nazionale. L’intellettuale ha un mandato, che non è necessariamente quello di salire sulle barricate: Leopardi non accetta pacificamente l’idea rassicurante e positiva di una società edificabile a partire da un progetto politico compiuto e affida piuttosto alla filosofia le sue residue speranze per la creazione di una letteratura propriamente moderna, a cui è delegata ogni utopia di autentico, intrinseco risorgimento nazionale, poiché solo la filosofia (e nella fattispecie la filosofia morale) può sanare «l’infelice stato della morale pubblica ai nostri tempi, e quella totale rovina e dissoluzione dalla quale è minacciata al presente la società, per la diffusione di principii incompatibili colla vita sociale degli uomini».[14] Per questo la contrapposizione centro/periferia, tipica del discorso politico, spiega e fonda il progetto morale leopardiano esattamente come la contrapposizione tradizione/presente, o quella immaginazione/ragione, rivelando come per Leopardi il piano dell’indagine sociale tenda a essere inglobato in quello letterario, l’unico capace di superare le contingenze dell’attualità e del transeunte, purché non si riduca «a un giuoco e ad un passatempo la letteratura dalla quale sola potrebbe aver sodo principio la rigenerazione della nostra patria».[15]
[1] Lettera del 4 agosto 1823, in Epistolario, p. 737.
[2] Zib., f. 1092 del 26 maggio 1821.
[3] A. Arbasino, Un paese senza, Milano, Garzanti, 1990.
[4] Getto spiegò benissimo che il sentimento della patria, in Leopardi, si poneva come «pretesto di una vita interiore che urge e cerca sfogo, di una condizione esistenziale di profonda insoddisfazione»: anche nella più “risorgimentale” delle canzoni, l’Italia scompare ben presto dalla scena, per lasciare la ribalta all’io lirico che si interroga, si impegna, si appassiona (Saggi leopardiani, Firenze, Vallecchi, 1966, pp. 43-44).
[5] Zib., f. 876 del 30 marzo – 4 aprile 1821, un momento cruciale del nostro Risorgimento.
[6] S. Timpanaro, Il Leopardi e la rivoluzione francese, in Classicismo e illuminismo cit., p. 324.
[7] G. Bollati, Il modo di vedere italiano (note su fotografia e storia), in L’italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione, Torino, Einaudi, 1996 [19831], pp. 136-140.
[8] Lettera a Giordani del 21 marzo 1817 e a Borghesi del 16 febbraio 1819, in Epistolario, pp. 71 e 254.
[9] Zib., f. 890 del 30 marzo 1821 e lettera a Montani del 21 maggio 1819, in Epistolario, p. 305.
[10] Sulle intersezioni tra progetto morale, sociale e letterario in Leopardi, E. Raimondi, Un poeta e la società, in Letteratura e identità nazionale, Milano, Mondadori, 1998, pp. 30-66.
[11] Lettera a Giordani del 20 marzo 1820, in Epistolario, p. 249.
[12] Zib., ff. 3324-3325 del 1-2 settembre 1823.
[13] Lettera a Pietro Brighenti del 28 agosto 1820, in Epistolario, p. 435.
[14] Lettera a Karl Bunsen del 3 agosto 1825, ivi, p. 917.
[15] Lettera a Francesco Puccinotti del 5 giugno 1926, ivi, p. 1175.
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento