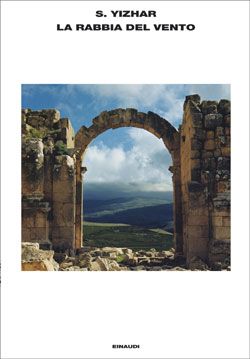
Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar
Einaudi ha ripubblicato, nel dicembre scorso, il romanzo breve di S. Yizhar, La rabbia del vento (nella traduzione di Dalia Padoa), uno dei libri fondativi della letteratura israeliana contemporanea. Un’opera che si conferma basilare e necessaria a 75 anni dalla sua pubblicazione mentre è in corso da mesi la devastante campagna di bombardamenti sulla Striscia di Gaza con un bilancio di morti e sfollati di proporzioni immani. Si tratta di una lettura indispensabile per chiunque voglia ripercorrere la storia dello Stato di Israele a partire dalla guerra del 1948 e dalle operazioni di pulizia etnica che causarono l’espulsione di circa 750.000 palestinesi, uno spartiacque epocale iscritto nella memoria collettiva palestinese come Nakba, la catastrofe.
Khirbet Khizeh, un villaggio palestinese nel 1948
Il titolo originale del libro è La storia di Khirbet Khizeh, un nome di fantasia a rappresentare un villaggio palestinese reale, che assurge, al contempo, a simbolo di tutti i villaggi palestinesi – più di 500 – cancellati dalle mappe durante la guerra del 1948. Chi narra è un soldato di un plotone dell’esercito israeliano incaricato di procedere all’evacuazione degli abitanti del villaggio, avviarli alla deportazione e distruggerne le abitazioni. Un soldato, proprio come lo fu Yizhar Smilansky, l’autore, che partecipò alla guerra, avendo già alle spalle un’esperienza di scrittore e alcuni libri di narrativa al suo attivo. Era quindi nell’ordine delle cose che quel cumulo di esperienze turbinose, vissute in un così breve spazio temporale, trovasse sbocco sulla pagina scritta. Come accadde da noi agli scrittori della Resistenza, Calvino e Fenoglio in primis. Il romanzo è basato su memorie di prima mano, elaborate a caldo e pubblicate a conflitto appena concluso, nel 1949, anche se l’incipit sembra suggerire che sia passato molto tempo dai fatti narrati: “In verità tutto ciò accadde molto tempo fa, ma da allora non mi ha più abbandonato” (p.4). La storia di Khirbet Khizeh uscì insieme ad un racconto, ugualmente importante – “Il prigioniero” – che narra della cattura di un incolpevole pastore condotto in prigione da un soldato che si pone molti dei dubbi che tormentano anche il soldato di Khirbet Khizeh. Un racconto che ricorda l’“Andato al comando” di Calvino, con la differenza che il pastore non è un combattente mentre il prigioniero di Calvino è un fascista e che tra il prigioniero di Yzhar e la sua guardia non vi è comunicazione nel viaggio che li porta alla destinazione stabilita.
La rabbia del vento si presenta come il flusso di coscienza del soldato che si interroga sulla moralità di quanto è chiamato a compiere. Egli è da subito in contrasto con le certezze dei commilitoni, che hanno fatta propria la dimensione della caccia, cui pure, inizialmente, anche lui era sembrato conformarsi. Ai compagni che cercano di colpire a distanza gli uomini che vedono fuggire, indica dei possibili bersagli, salvo ritrarsi subito sconvolto da questo deprecabile impulso. Egli avverte, infatti, che stanno commettendo qualcosa di profondamente ingiusto, un atto che va contro i principi della moralità ebraica in cui è stato educato.
L’io narrante, anche se non specificato, è un sabra, un ebreo nato in Palestina, come lo era Yzhar, discendente di immigrati russi che si erano trasferiti in Palestina nel corso della prima alya nella seconda metà dell’Ottocento. Egli veniva da una famiglia di scrittori: lo erano il padre stesso e un prozio, Moshé Smilansky, cui sono intitolati strade e kibbutz. Un giovane che padroneggia l’ebraico, la lingua risuscitata da Eliezer Ben-Yehuda alla fine dell’Ottocento, appresa sui banchi della scuola, legata all’ebraico delle Scritture, ma di necessità aperta all’innesto di nuovi termini, molti basati su radici arabe, e ai cambiamenti che andavano verificandosi sul terreno dell’uso nella Palestina mandataria. La formazione biblica è centrale e riaffiora in momenti cruciali della narrazione: gli abitanti di Khirbet Khizeh – “E tutti quei ciechi, zoppi, vecchi, deboli, donne, bambini, gli ricordavano un passo della Bibbia in cui si raccontava qualcosa di simile”(p.51). Una reminiscenza che gli pesa sull’animo. Insieme con quella biblica nel racconto s’accampa l’iconografia dell’Olocausto: i palestinesi del villaggio sono descritti come un gregge di pecore condotte al macello, inermi e incapaci di capire la loro situazione, anche se in alcuni di loro sta cominciando a montare la consapevolezza di quanto sta accadendo, del profilarsi dell’irreparabile sradicamento. Una donna, in particolare, che trattiene il suo dolore, accompagnata da un bambino, “una leonessa” è definita, tanto orgogliosa da non voler scoppiare a piangere davanti ai nemici. “Il bambino stesso era portatore di qualcosa dentro, che lo faceva piangere e che si sarebbe trasformato in seguito in una vipera” (p.71).
Le disastrose dimensioni della tragedia
Come hanno osservato i critici più accorti, i palestinesi inermi del villaggio – donne, vecchi e bambini – appaiono ai soldati come la letteratura antisemitica descriveva gli ebrei: sporchi, imbelli, bestie. Proprio quelle immagini e i riferimenti biblici, insieme agli aggettivi usati per descrivere quanti stanno per essere sradicati dalla propria terra, fanno dire a Elias Khoury – il grande scrittore libanese scomparso il 15 settembre scorso – che l’essenza del romanzo consiste nell’assegnazione ai palestinesi del ruolo degli ebrei per i nuovi israeliani che si apprestano a cacciarli, in un gioco di specchi che li libera dal passato del ghetto. Per Yzhar, l’Altro è uno specchio collettivo che gioca il ruolo del liberatore psicologico. Operazione necessaria, secondo Khoury, per aprire la strada al nuovo ebreo che taglia i ponti con l’ebreo della diaspora.
Ma per il narratore a un certo punto si fa lampante la drammaticità del frangente: “Qualcosa mi colpì come un fulmine. All’improvviso tutto sembrò significare qualcosa di diverso, più precisamente: esilio. Questo era l’esilio. Ecco com’era l’esilio. Ecco come appariva l’esilio” (Ib.). Il personaggio non si limita a riconoscere nel destino di quella povera gente quello di generazioni di ebrei della diaspora. Pur non essendo mai stato nella diaspora, il narratore sa, glielo hanno raccontato i genitori, lo ha succhiato con il latte materno, lo ha letto: “La nostra protesta contro il mondo: l’esilio”. Ecco cosa avevano perpetrato. Quegli sventurati – vecchi, donne e bambini – venivano condotti via. Poco prima davanti a due vecchie abbandonate ai lati della strada, “mostri da cui esalava un odore di tombe scoperchiate, una cosa disumana, stomachevole” (p.35) gli si era strozzato in gola il grido di Kurtz in Cuore di tenebra: “L’orrore! L’orrore!” Poco più avanti, il narratore innalza il livello della gravità dell’accusa: “Le mie viscere urlavano. Colonialisti, urlavano, bugiardi! Khirbet Khizeh non è nostra. Una mitragliatrice Spandau non potrà mai conferirci alcun diritto” (p.74).
Gli Ebrei, dopo una millenaria storia di persecuzioni e di esilio sono ora I padroni, ma lo sono diventati mandando in esilio un altro popolo:” I muri di questo villaggio non avrebbero gridato nelle orecchie di chi fosse venuto ad abitare qui?” (p.74) Lungi dal sentirsi a casa nella terra ancestrale, come voleva la retorica sionista, il narratore si sente completamente fuori luogo, preda di una sensazione di totale spaesamento. La terra gli brucia sotto i piedi.
Tutto questo contrasta con lo scenario naturale, con la bellezza di quella terra, così mirabilmente descritta e così familiare allo scrittore che la conosceva sin dall’infanzia, trascorsa nella pacifica convivenza con i nativi, personaggi per lui familiari e parte naturale dell’ambiente. Una terra, coltivata con amore dai nativi e non certo disabitata come voleva la propaganda sionista:
Ecco i campi quadrati, arati e verdeggianti, i frutteti fitti d’ombra, le siepi che ritagliavano il terreno in sagome tranquille e distanti, le colline multiformi che nascondevano e rivelavano orizzonti lontani, azzurrini. E su tutto questo scendeva una tristezza orfana, un velo d’ombra (…). E già i campi ti osservavano con sguardi accusatori e il silenzio di quegli sguardi, come quello di un animale offeso, ti seguiva senza tregua. (p. 60-61)
La contrastata ricezione
Nonostante contenesse queste brucianti accuse, nel 1964 il libro venne incluso nel curriculum scolastico, senza suscitare le animate discussioni e polemiche, che invece solleverà, nel 1978, l’uscita del film per la televisione che il regista Ram Loevy aveva tratto dal romanzo. Yzhar, in risposta alle critiche vertenti in particolare sulla veridicità di quanto evocato nel libro, affermava: “Benché si tratti di un’opera narrativa, tutto vi è riportato con grande precisione, documentato meticolosamente, a cominciare dall’ordine di operazione in una certa data, fin nei minimi dettagli.” Lo stesso procedimento, puntigliosamente e realisticamente aderente ai fatti, lo scrittore segue in Convoglio di mezzanotte, pubblicato nello stesso anno (uscito per Einaudi nel 2013 con la traduzione di Elena Loewenthal). Un racconto in cui sono assenti i rimorsi perché vi si narra di una missione giusta che ha l’obiettivo di portare aiuto a un avamposto assediato dall’esercito egiziano.
La polemica sul contenuto del libro e sul film non oscurò il riconoscimento della straordinaria tecnica narrativa che fa di Yzhar uno dei maestri nell’utilizzo di uno strumento, la lingua ebraica, ancora non applicato in un contesto tanto drammatico a una materia così scottante in partenza e in una posizione fortemente problematica quale contrappunto alla retorica ufficiale del nuovo Stato.
Per La rabbia del vento, come pure per il racconto “Il prigioniero” pubblicato insieme al romanzo, vale ancora oggi il giudizio di Jacqueline Rose che nel 2011 sul Guardian, all’uscita della versione inglese dell’opera la definì “la convalida del potere del pensiero critico di registrare le ingiustizie della storia”, o come scrisse Elias Khoury “una rara dimostrazione della capacità della letteratura di superare i muri delle rappresentazioni dominanti”.
Non ci potrebbe essere contrappunto più forte ed essenziale anche dal punto di vista narrativo alla storia ufficiale del sionismo, ben prima che Benny Morris e i nuovi storici, quarant’anni dopo, rivelassero il peccato originale della fondazione dello Stato. E fa questo, lo scrittore, rappresentando in modo icastico i tratti della tragedia del popolo palestinese, la Nakba, proprio nelle sue fasi iniziali offrendoci uno spezzone drammaticamente significativo del suo svolgersi. Galut, l’esilio, che da duemila anni aveva contrassegnato l’ebraismo ora diventava il destino della gente che gli ebrei avevano cacciato dalla propria terra. Il sogno sionista si materializzava solo grazie alla cancellazione di un altro popolo.
Un precursore solitario, Yzhar, che nel 1967 all’indomani della Guerra dei sei giorni si pronuncia contro l’occupazione. Pur non arrivando a sostenere che l’occupazione avrebbe corrotto gli occupanti, come fece in modo lungimirante il filosofo Yeshayahu Leibowitz, a Yzhar, in quei giorni, bastò ripetere le parole del soldato nel romanzo di Khirbet Khizeh: ”Il mitragliatore Spandau non ci ha mai dato alcun diritto”.
L’inclusione del libro insieme con il racconto “Il prigioniero” nel programma scolastico delle secondarie non fu tuttavia un tributo a una visione critica della guerra e tanto meno un riconoscimento dell’ingiustizia inferta ai palestinesi. L’accento fu posto, da generazioni di docenti, sull’analisi dei personaggi o sui meriti artistici o sulle virtù linguistiche dello scrittore e soprattutto sul tormento di coscienza del vincitore a sottolineare, paradossalmente, la superiorità morale di un esercito che si interroga sul proprio operato. Un atteggiamento che perdura nelle affermazioni di chi oggi, anche in presenza del genocidio in corso a Gaza, sostiene che quello israeliano è l’esercito più morale al mondo. Come ha ben mostrato Nurit Peled-Elhanan nel suo libro La Palestina nei testi scolastici di Israele – Ideologia e propaganda nell’istruzione, (Edizioni Gruppo Abele, 2012), i libri scolastici sono pieni di rappresentazioni razziste e disumanizzanti dei palestinesi, che vengono dipinti solo come una minaccia e di cui viene cancellata la storia. Il servizio militare viene presentato ai bambini come una responsabilità sin dalla scuola dell’infanzia. Uno degli auguri più frequenti che vengono rivolti alle future madri è “che il figlio diventi un buon soldato”. La studiosa stessa è stata di recente vittima della censura e dell’ostracismo per avere, all’indomani della strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre, postato una citazione da Sartre in una chat con colleghi: “Dopo tanti anni in cui il collo dell’occupato è stato soffocato sotto il tuo piede di ferro e all’improvviso gli è stata data la possibilità di alzare gli occhi, che tipo di sguardo ti aspettavi di trovarvi?” “Noi, commentava Peled, abbiamo visto questo sguardo”.
Yzhar è anche il precursore di un genere narrativo basato sulle memorie dei soldati, che da lui arriva fino a quelli che hanno reso testimonianza per Breaking the Silence e hanno scritto dello sconvolgimento provocato nelle loro vite dall’esperienze dello spossessamento e della violenza esercitata dall’esercito nelle guerre, come è il caso di Ari Folman, il regista di Valzer con Bashir, un film d’animazione fortemente ancorato alle esperienze dello stesso Folman nella guerra del Libano del 1982 o quello di Noam Chayut, l’autore di The Girl Who Stole my Holocaust (2010), che racconta il momento di svolta esistenziale provocato in lui, soldato nei Territori occupati, dallo sguardo di una bimba nei cui occhi egli vede rispecchiato il male assoluto che lui in quel momento incarna per lei. Chayut non seppe spiegare al momento della pubblicazione del libro perché fosse stata proprio quella bambina a provocargli quello shock trasformativo dato che momenti rivelatori non erano mancati prima: il bambino ammanettato nella jeep, o la bambina nella cui casa erano penetrati una notte per arrestarne la madre e la zia. “Centinaia di bambini che piangevano mentre rovistavamo tra le loro cose. E c’era il bambino di Jenin cui facemmo saltare il muro di casa con una carica esplosiva che provocò un buco pochi centimetri sopra la testa lasciandolo miracolosamente incolume, dal punto di vista fisico, ma sicuramente non da quello psicologico.” Negli occhi della bimba,ha scritto Masha Gessen, sul New Yorker a dicembre, “Chayut vide un riflesso del male annichilente, il genere che gli era stato insegnato era esistito, ma solo tra il 1933 e il 1945 e solo dove governavano i nazisti”.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
Commenti recenti
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
- Matteo Zenoni su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Stefano, isolo questa frase “la digitalizzazione non ha prodotto una riduzione del lavoro, ma…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento