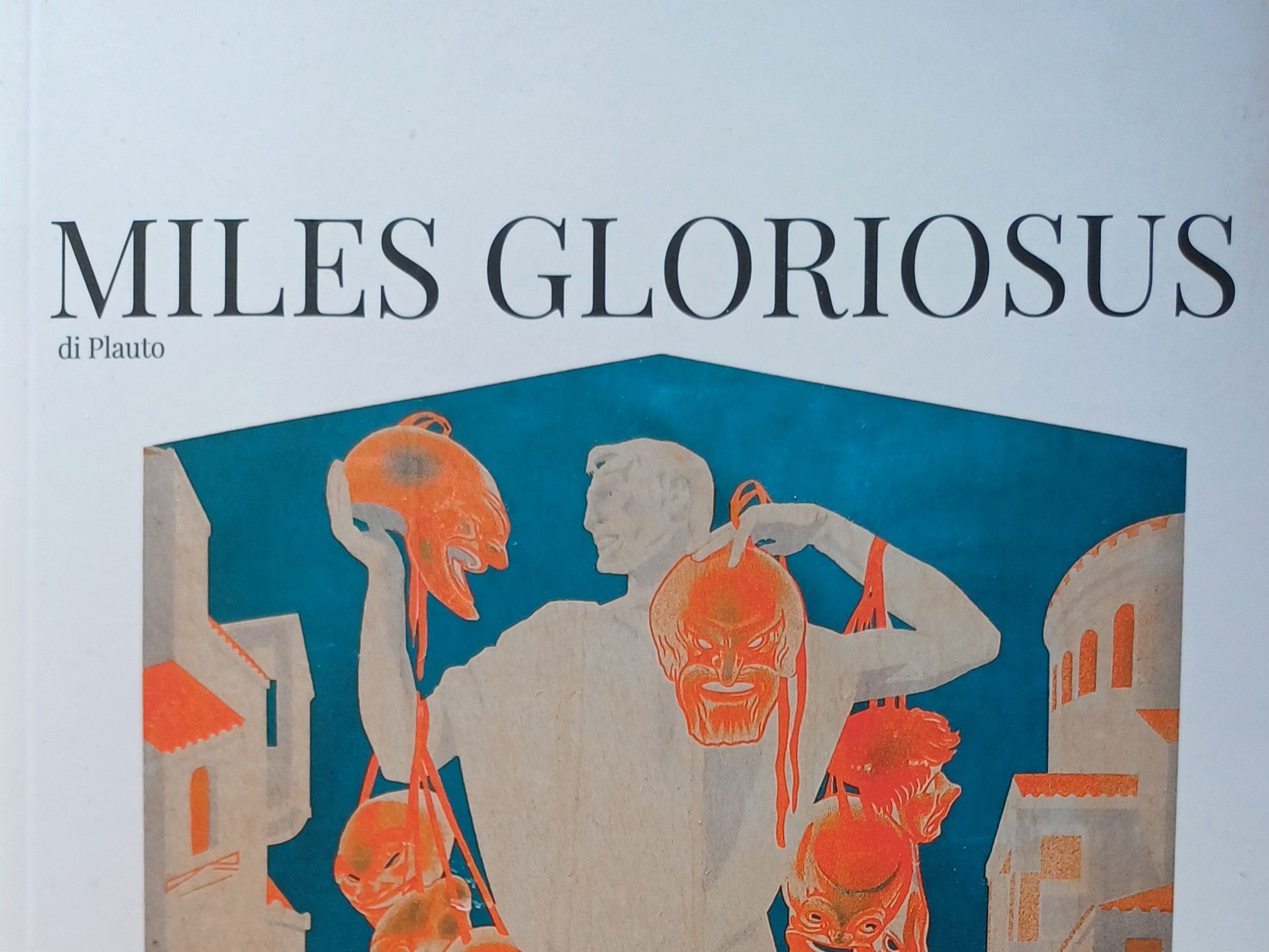
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Un soldato [Pirgopolinìce, ndr] si porta dietro da Atene a Efeso una prostituta [Filocomàsio]. Uno schiavo [Palestriòne], mentre vuole avvertire il padrone [Plèusicle] che ne è innamorato e si trova lontano, viene anch’egli catturato durante la traversata e offerto in dono proprio a quello stesso soldato. Lo schiavo riesce a far arrivare il suo padrone da Atene e di nascosto pratica un foro nella parete comune alle due abitazioni per consentire agli amanti di incontrarsi. Dal tetto un servo di guardia [Scèledro] li vede abbracciati, ma viene gabbato e finisce per credere che si tratti di un’altra ragazza [la gemella di Filocomàsio]. Nel mentre Palestriòne spinge il soldato a lasciare la concubina poiché la moglie [Acrotelèuzio, in realtà una prostituta assoldata] del suo vecchio vicino di casa [Periplectòmeno, che ospita Plèusicle] brama di condividere il talamo con lui. Il soldato prega la ragazza di andarsene spontaneamente e la ricopre di regali. Sorpreso nella casa del vecchio, subisce il castigo degli adulteri.
(Tito Maccio Plauto, Miles gloriosus, Argomento I, traduzione di Caterina Mordeglia, Fondazione INDA 2024, p.89)
Fortune e disgrazie di un fanfarone
Al teatro greco di Siracusa ha debuttato il 13 giugno scorso, con un cast interamente femminile, Miles gloriosus di Plauto, nella traduzione (luminosa) di Caterina Mordeglia e per la regia (intelligente) di Leo Muscato. Chi ha avuto o avrà modo di vederlo in scena, chi non ne ha che qualche sbiadito ricordo liceale non potrà fare a meno di riprendere in mano questo testo antico; e di sorprendersi.
Il soldato fanfarone e il suo sgangherato drappello di mercenari nascono a Roma, all’inizio del II secolo a.C., mentre ancora erano accesi gli ultimi fuochi della seconda guerra punica, e conquistano fortuna immediata e durevole. Si reincarnano infatti, nei secoli successivi, in svariate soldatesche del teatro come del cinema, pur virando spesso verso le tinte più scure del tragico, implicito, ma non assente, nella commedia che, non a caso, trova il suo epilogo nella crudelissima punizione del fanfarone; sproporzionata, peraltro, perché Pirgopolinìce (in greco sarebbe, più o meno, “colui che riporta vittoria su fortezze e città”) s’è macchiato, sì, di insopportabili smargiasserie, e di vigliaccheria, di arroganza, di abusi d’autorità, ma non dell’adulterio per cui finisce in ceppi e riceve il castigo. Pensiamo a Oreste-Sordi e Giovanni-Gassman ne La grande guerra di Mario Monicelli (1959), giusto per fare l’esempio forse più straordinario; e torniamo al testo latino.
Margherita Rubino ci ricorda che Orazio, nelle Epistole (II, 1, 75), accusava Plauto di pensare solamente a intascar quattrini, «da tipico intellettuale che sdegna ciò che alla gente piace» (Un’invenzione fortunata, p.62); e, aggiungiamo noi, senza chiedersi perché alla gente piacesse, o motivando il gradimento con ragioni non meno sdegnose. Proviamo a darne noi qualcuna un poco più solida.
La guerra di Plauto
Caterina Mordeglia ci avverte: «Plauto non lascia impronte di chi sia Pirgopolinìce, né potrebbe, memore della persecuzione politica subìta dal predecessore Nevio (…). Proprio questa generica astrattezza – come accade anche per le maschere animali della favola esopica – rafforza l’universalità all’atto stesso della nascita del miles plautino» (Miles gloriosus. Il linguaggio e il riso, p.82). Il pubblico di allora, segnato dall’esperienza della guerra come da ferita perennemente aperta, immerso nell’immaginario militare come fosse elemento naturale, non è difficile ipotizzare che riconoscesse nel testo figure e situazioni note; e che gli elementi parodici potessero contribuire ad aumentare l’effetto comico e il gradimento generale. Tuttavia, venute meno comunque quelle figure e quelle situazioni, il testo continua a incontrare il favore di spettatrici e spettatori e a parlare loro forse anche più di allora, proprio perché quei rimandi, ammesso che ci fossero, sono venuti meno e netta, trasparente, disarmante (si vorrebbe dire, concedendosi al gioco degli ossimori) emerge l’idea che Plauto ha della guerra: «Un gioco insensato a somma zero». Quella di Leo Muscato (che firma anche gli Appunti di regia, p.13) non è una indicazione-scudo, politicamente corretta, per passare indenni le linee di fuoco che oggi incendiano le regioni di mezzo mondo. Esprime piuttosto il potenziale esplosivo della commedia, tenuto a bada dalla comicità, ma latente, davvero come fuoco sotto la cenere.
Pirgopolinìce è un mercenario che dovrebbe addestrare mercenari:
Il re Seleuco mi ha pregato con la massima insistenza di radunargli e arruolargli dei mercenari. Ho deciso di dedicare la giornata di oggi al servizio del re. (atto I)
Oggi ho inviato al re Seleuco il mio parassita con i mercenari che avevo assoldato qui per lui. Ci penseranno loro a difendere il suo regno, mentre io mi prendo un po’ di riposo. (atto IV, 1)
Dunque è un uomo abituato a servire e che solo in quanto servitore ha conquistato la possibilità di comandare (incredibile dictu per un uomo senza qualità; ma – ahinoi – non così difficile da credere…). L’autorità che esercita sugli altri non gli viene dal valore, ma dalla sottomissione; e la sua adesione alla vita militare non è motivata da una idealità, quale essa sia (appartenenza, identità, amor di patria…), giacché (facile cercare le parole nel capitolo XII del Principe) le truppe mercenarie «non hanno altro amore né altra cagione che le tenga in campo, che uno poco di stipendio, il quale non è sufficiente a fare che voglino morire per te». Sprovvisto dunque tanto di qualità quanto di aspirazioni, anche solo velleitarie, per rivendicare il proprio ruolo il miles è quasi obbligato a esibirne i segni esteriori: lo scudo, la spada, la forza e – ultimo ma non ultimo – la virilità, che del teorema della guerra è (ridicolo) corollario. Entra infatti in scena ostentando e ordinando:
Avanti! Forza, il mio scudo deve splendere e risplendere, rendetelo più luminoso dei raggi del sole quando è bel tempo! Così, al momento di usarlo, quando la battaglia infuria, abbaglierà la vista delle schiere nemiche. Voglio che questa spada mi si consoli e la smetta di lamentarsi e di scoraggiarsi, perché me la porto dietro da tanto tempo e lei deve stare in ozio, mentre, poverina, smania dal desiderio di tagliare a fette i nemici. (atto I)
Nulla di strano, dunque, se anche le sue truppe siano (per dirla ancora con Machiavelli) «disunite, ambiziose, sanza disciplina, infedeli» e se Artotrògo, suo parassita e servile biografo della sua rutilante vita immaginaria, ammetta senza problemi: «C’è un solo motivo per cui sto con lui: le focaccette che si mangiano in casa sua sono talmente buone!» (atto I).
L’accampamento di Pirgopolinìce diviene quindi ipostasi grottesca, ma vicina e tangibile, dei grandi scenari militari e, nel rovesciamento parodico, non si irride alle tragedie della guerra e ai suoi martiri, ma se ne svelano i meccanismi distorti, gli interessi meschini, le gerarchie inconsistenti; insomma, la nudità del re.
Il comandante è nudo
Al termine della commedia, il re – ovvero il comandante del campo – è letteralmente nudo.
Palestriòne (“il combattente”), servus callidus, l’ha convinto che la giovane moglie dell’anziano vicino (in realtà una prostituta assoldata all’uopo: il vecchio è infatti un simpaticissimo scapolone impenitente) si sia pazzamente innamorata di lui. Pirgopolinìce non esita allora a congedare la scaltra cortigiana Filocomàsio, che ha costretto a fargli da concubina, dopo averla rapita con la forza a Plèusicle, adulescens ateniese. Attirato con l’inganno in casa del vicino, dove è convinto di incontrarne la moglie, viene sorpreso senza indumenti e così trascinato sulla pubblica piazza, bastonato dai suoi (ex) sottoposti e minacciato di evirazione. Insomma, Pirgopolinìce paga l’essere pessimo miles – e per di più gloriosus – con una deminutio della virilità che ne inficia il ruolo di comandante più di quanto non facciano le sue opinabili prestazioni militari. A scontare le sue manchevolezze di soldato non è il comandante ma il lenone, o, per dir meglio, il comandante le sconta in quanto lenone; e il lenone va in bianco perché è stato cattivo comandante di truppe infide, addestrandole alla piaggeria e alla menzogna, tenendole a bada a suon di minacce e focaccette e dunque in qualche modo autorizzandole al tradimento. Plauto, equiparando i due ruoli, traccia quindi un’equazione significativa, che depotenzia il teorema della guerra fondata sulla forza e sul corollario della virilità. Anche per questo risulta particolarmente felice la scelta registica di affidare i ruoli maschili (inclusa la nutrita squadra di soldati) a interpreti donne, la cui stessa fisicità è sottolineatura ironica della fragilità del corollario come dell’intero teorema.
Strateghi del quotidiano
Il vero stratega della vicenda non è dunque il comandante fanfarone, bensì il servo astuto. Si tratta di un doppio rovesciamento, dei ruoli e delle gerarchie. Chi detiene ufficialmente il comando l’ha ottenuto servendo e non possiede arguzia né valore: «ha la sensibilità di un elefante ed è più duro di comprendonio di una pietra» (II, 2); chi è ridotto alla condizione servile ha il controllo d’ogni cosa e in animo coraggio, astuzia e determinazione: «eleganti trovate e ingegnosi inganni» (II, 1). È un dispositivo drammaturgico frequente, che risarcisce almeno sulla scena sperequazioni difficilmente sanabili nella vita reale; e tuttavia non è inverosimile come si potrebbe pensare. Palestriòne e il piccolo drappello di uomini e donne comuni che si raduna intorno a lui combattono tutti i giorni, sulla scena come nella vita reale, la loro battaglia per la sopravvivenza. I loro discorsi, le loro metafore attingono ripetutamente al campo semantico militare. Così parla Periplectòmeno, senex lepidus, per spronare Palestriòne:
Non vedi che il nemico ti minaccia alle spalle? Su, deciditi: raduna tutti i mezzi che hai. Fai presto, non c’è un minuto da perdere. Previenilo l’avversario, se puoi, guida il tuo esercito attraverso qualche gola, stringilo d’assedio, cerca un riparo ai nostri; ai nemici taglia i rifornimenti, apriti una via che garantisca cibo e rifornimenti per te e le tue schiere. (…) Se mi dici che sei sicuro di accollarti da solo l’intera faccenda, c’è speranza di sconfiggere il nemico. (atto II, 2, p.94)
Così Acròteleuzio, appena ingaggiata dall’«architetto» Palestriòne:
Quando l’architetto è valido, una volta che abbia impostato una chiglia ben ideata, è facile costruire una nave in base a una struttura robusta. Nel nostro caso, la chiglia mi pare solida; e poi ci sono operai e architetti tutt’altro che impreparati. Se il fornitore non ritarda nel procurarci il materiale necessario, conosco bene la nostra abilità, la nave sarà pronta in un attimo (atto IV, 3, p.110)
Così lo stesso Palestriòne:
Abbiamo bisogno di un posto tranquillo: nessun nemico deve far bottino del nostro piano. Un disegno ben congegnato, infatti, finisce per diventare mal congegnato, se lo mette in pratica il nemico. E non c’è scampo: se lo mette in pratica il nemico, danneggia noi. D’altronde, niente di più facile che un buon piano, quando non si scelga attentamente e con cautela il posto per discuterne, finisca in mano al nemico. Perché i nemici, una volta che sono venuti a saperlo, col tuo stesso piano ti tappano la bocca e ti legano le mani e fanno a te quel che tu volevi fare a loro. (atto III, 1, p.103)
«I nemici ti tappano la bocca e fanno a te quel che tu volevi fare a loro». Il campo comandato da Pirgopolinìce non è un campo di battaglia: la guerra resta lontana, sullo sfondo, destinataria remota di soldati mercenari da spedire a piacimento del re Seleuco. Ma l’umanità portata in scena da Plauto è in guerra, sempre, anche quando tacciono i tamburi. Ed è pronta a fare ad altri quel che non vorrebbe fosse fatto a lei. Nessuna pietà, dunque, per il fanfarone, pestato a sangue dai suoi stessi adulatori.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento