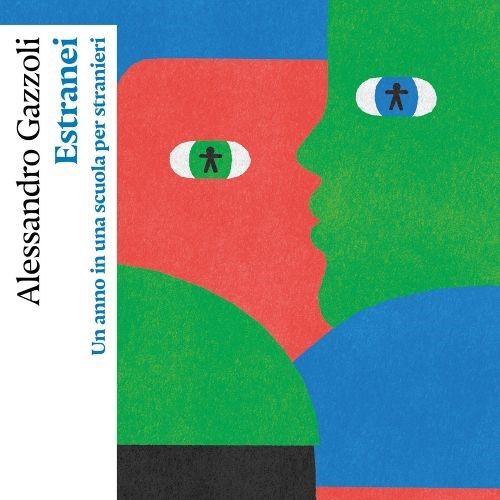
“Estranei. Un anno in una scuola per stranieri” di Alessandro Gazzoli
Pubblichiamo un estratto da “Estranei. Un anno in una scuola per stranieri” di Alessandro Gazzoli, uscito per Nottetempo editore. Ringraziamo l’autore e l’editore per la gentile concessione.
Bianco e nero
Tra la metà e la fine di novembre, dopo lunghi indugi, mi appresto a somministrare le prime verifiche. Non so come andrà, anzi, so in anticipo che per alcuni sarà un disastro, e perciò continuo a posticipare i test veri e propri con esercitazioni “in preparazione a”. Temporeggiare non è da ottimisti, e infatti la resa dei conti si annuncia impietosa. Mi preoccupa soprattutto Shazia, che non regge una spiegazione vagamente astratta per più di due minuti, si attarda a ricopiare parole che ho scritto a caso alla lavagna e va in confusione se alla domanda di un esercizio bisogna dare un parere personale, un’informazione che sul quaderno non c’è. A quel punto (se, per esempio, l’ultimo quesito a cui rispondere è: “Secondo te, siamo più vicini all’Austria o al Pakistan?”) mettiamo in scena la solita pantomima: guarda Shazia, le dico, è inutile che cerchi, la risposta non è lì (dito sul foglio) ma è qui (dito sulla sua fronte). Lei annuisce, sorride, e mentre inghiotte l’ennesimo gianduiotto mi sussurra con gli occhioni beati: “Non ho capito un cazzo”. Appena la lascio lavorare da sola, Yara non perde poi occasione per coinvolgerla in risatine e occhiate, alle quali si accoda regolarmente anche Priti, quando è in classe; uno schiocco di dita o uno “ssst!” di solito bastano a riportarle all’ordine, che però nel loro caso significa fissare il vuoto con aria colpevole per interminabili minuti, senza mai rimettersi con la testa sulle domande. Nel frattempo, Samira scrive le risposte su un foglio, me lo allunga sorridendo per le correzioni, ricopia in bella, ritaglia, decora, incolla, e alla fine di tutte queste operazioni gli altri sono grosso modo a metà dell’esercizio. Senza volerlo, lascio sempre in coda Marisol, che mi pare la meno bisognosa di aiuto, visto che è in Italia da una vita e sostiene di cooperare ai compiti della figlia tutti i pomeriggi. Ma non è una scelta vincente: dopo aver corretto (si fa per dire) le risposte perfette di Samira, dopo aver sedato il cerbero a tre teste Priti-Yara-Shazia e dopo aver tradotto on-line dall’italiano all’arabo le parole che servono a Bilal e Amna, mi avvicino finalmente a Marisol, che intanto sta compulsando affannosamente il suo materiale, si rigira tra le mani il foglio del compito e soprattutto non ha ancora scritto una riga (“Ehm, yo credo de essermi persa che cosa dobbiamo fare, prof”). Le rispiego la consegna (“Rispondi a queste domande, trovi tutto sul quaderno”, ovvero tre paginette scritte enormi più una fotocopia di sole immagini valida come “approfondimento”), la incoraggio per quanto possibile (“Per te dovrebbe essere facilissimo”) e da ultimo lei si avvia ad affrontare il cimento, inforcando gli occhiali orfani di una stanghetta, sostituita da un filo di lana che, fendendo la massa dei ricci castani, le si attorciglia attorno all’orecchio destro.
Disastro doveva essere e caporetto è stata: alla verifica di geografia, Yara, Shazia e Priti hanno preso un’insufficienza talmente grave che non mi sono sentito nemmeno di registrarla; Bilal se l’è cavata con un 6+, Amna e Marisol (con sproni continui) 8 e mezzo; Samira, ovviamente, 10. Chiedo alle tre grazie indopakistane se hanno voglia di riprovarci, visto che mi sembrano sinceramente afflitte, e loro incredibilmente accettano. Perciò stabiliamo di fermarci per una lezione di recupero al pomeriggio, durante la quale rileggiamo le spiegazioni sul quaderno, riproviamo a capire insieme tutte le domande, a fare esercizi alla lavagna, a stilare un glossario dei termini più ostici; mi sembrano determinate, convinte, attente, e il lunedì successivo si presentano addirittura un’ora prima per riprovare il test che sottopongo loro con impercettibili modifiche rispetto alla versione precedente. Sembra impossibile ma, quando correggo, le risposte sono persino peggiori del primo tentativo: più brevi, meno approfondite, incerte, con frasi lasciate a metà, come se a loro non importasse nemmeno riprendere quanto di buono c’era nella vecchia verifica; alla fine scucio un 6 “per l’impegno” che non si nega mai a nessuno, e cerco di alleviare la loro comprensibile delusione alla riconsegna dei compiti pronosticando improbabili successi futuri (d’altronde, non saprei nemmeno come valutare risposte come quella di Shazia che, alla domanda “Dov’è il Trentino in Italia?”, ha opposto un sibillino “Trentino è ovest, Italia è est”).
In storia, per semplificare gli argomenti ed evitare un approccio troppo nozionistico alla disciplina, ho pensato invece a un’unità tematica sulle grandi invenzioni (la ruota, la scrittura, la carta) che mi permetta di chiarire il concetto di evento storico – fondamentale per periodizzare il passato – e di mostrare come il progresso dell’umanità sia una serie di lente conquiste che si raggiungono a forza di tentativi ed errori. Utilizzando un carretto per la legna che stavo costruendo in baita, mi sono anche filmato in un video in cui, travestito da sumero, cercavo di trascinare il mezzo senza ruote e, subito dopo, riuscivo a spostarlo agevolmente grazie all’innesto di due pneumatici da carriola (il successo della proiezione non è venuto tanto, come prevedevo, dal mio abbigliamento bizzarro o dalla didascalia “Mesopotamia 3000 a.C.” che compariva a inizio video, ma dal fatto che io, proprio io, il loro prof quasi quarantenne, sia stato in grado di fare delle riprese e montarle con effetti e musica di sottofondo in maniera dignitosa).
Approcci diversi per un medesimo risultato: la prova di storia ha un andamento identico a quella di geografia, con gli stessi voti e persino la coda di un secondo tentativo concesso al trio Shazia-Priti-Yara dopo l’immancabile insufficienza. A entrambe le prove Dmytro non si è presentato ma, mi dico e ci diciamo tra docenti, ha appena iniziato una scuola serale, torna a casa tutti i giorni a mezzanotte, ha bisogno di prendere confidenza coi ritmi nuovi.
Ma perché, nonostante tutti gli aggiustamenti, c’è qualcosa che non va, che non funziona in questo modo di presentare la storia e la geografia (per l’italiano i problemi sono altri, e non sono nemmeno problemi, solo fasi diverse di un avvicinamento graduale alla lingua)? Perché non entrano in testa concetti così semplici? Perché è così complicato capire i quattro punti cardinali? Perché imparare a memoria soltanto le risposte, sperando che mi vadano bene? Certo, la mia è un’impostazione eurocentrica, che procede, come lo Spirito Santo, da un sistema scolastico occidentale, al quale riesce ad adattarsi soltanto chi ha frequentato scuole in cui è ancora forte l’impronta del lascito coloniale (non per niente posso intendermi molto facilmente con Amna, Samira e Bilal, che sono stati educati in istituti in cui è ancora fortissima l’influenza del modello francese o, addirittura, come nel caso di Amna, il francese stesso è stata la lingua veicolare dell’insegnamento in Tunisia). Me l’hanno detto più volte, che la scuola non è necessariamente la scuola in tutto il mondo, che capita spesso di imbattersi in pakistani brillanti e laureati che non saprebbero riconoscere il loro paese su una cartina geografica, in sudamericani che non riescono a riprodurre in scala la piantina della loro camera da letto, che non sono nemmeno in grado di concepire l’idea di rappresentare qualcosa dall’alto.
Evidentemente è troppo radicata, anche in me, la convinzione che solo questo sia il modo giusto di mostrare le cose, il sistema più efficace per apprendere, e che esista un solo metodo adeguato per accompagnare la mente degli stranieri verso il mondo dell’istruzione; in fondo, è come se tutta la fatica che avverto quando mi genufletto tra i banchi di Shazia e Yara per spiegare termini come “facilitare” o “tavolette di argilla” non fosse altro che il “fardello dell’uomo bianco” di cui parlava Rudyard Kipling alla fine dell’Ottocento.
Quest’anno devo, e dobbiamo, parlare soprattutto di questo, analizzare come il colonialismo sia per prima cosa un’attitudine mentale, una pulsione con cui gli europei non sono in grado di fare i conti, della quale occorre spogliarsi per poi demolirla apertamente insieme a chi ne sta pagando ancora le conseguenze, immigrando proprio nei paesi dai quali continua a provenire sentore di dominio.
E tuttavia questo è solo il rovescio della medaglia, l’autoaccusa di un occidentale che biasima i pregiudizi che lui stesso porta inevitabilmente con sé, anche quando ammette (ammetto) di essere senza dubbio erede di una cultura di conquista e di sfruttamento, e denuncia (denuncio) che la civiltà di cui è figlio ha fatto danni incalcolabili su tutti i continenti nel corso della storia. È un pentimento comodo e ben congegnato, che non implica alcuna ridefinizione dei valori e che, anzi, sottintende l’idea che i popoli del terzo mondo debbano comunque farsi spiegare da qualcun altro le ragioni della loro rabbia: persino quando quest’ultima esplode in violenza e rivolta, dall’altra parte troveranno sempre qualcuno pronto a giustificarla, a interpretarla al posto loro, visto che, si sa, mica possiedono una coscienza storica, la capacità di analisi profonde, e soprattutto ignorano il gusto nobile e perverso del mea culpa. È un esercizio tonificante e assolutorio, a cui mi lascio andare volentieri quando, per il secondo modulo di storia, decido di partire con una lezione appassionata sul colonialismo, illustrando in tono contrito le vignette razziste del secondo Ottocento e deprecando la spartizione a tavolino dell’Africa decisa durante la Conferenza di Berlino del 1884-85.
È un atteggiamento che va ben oltre il peccato di orientalismo additato da Edward Said nel suo celebre saggio, perché non contempla soltanto l’implicito riconoscimento di un’inferiorità di fondo, ma presuppone un’aggiunta supplementare, un bisogno dal sapore squisitamente cristiano come la supplica del perdono.
Io sono qui, sono io quello in cattedra e con lo stipendio garantito a fine mese, non c’è niente da fare, lo scambio non sarà mai paritario, e nemmeno vorrei che lo fosse. Ricordo ancora con una stretta al cuore quel che ho provato a Londra nella primavera del 2014, quando, durante un soggiorno previsto dal dottorato, una volta a settimana percorrevo a testa bassa la strada da Victoria Station all’Istituto Italiano di Cultura per partecipare a una conferenza o alla proiezione di un film; lungo il cammino fiancheggiavo le lunghe file di palazzi in cui avevano sede le rappresentanze diplomatiche di diversi paesi, tutte identiche nella loro successione di altissimi cancelli, giardini impeccabili e finestre ermeticamente chiuse. Mai come allora ho avvertito la rabbia di sentirsi una nullità in un paese straniero, di sfiorare con le dita il mondo dei ricchi che ti esclude senza appello: in quei frangenti, la sola consolazione possibile era il pensiero di poter avere con me una bomba da scagliare contro quelle villette a due piani, non appena la moglie dell’ambasciatore del Canada si fosse azzardata a mettere il naso fuori di casa.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento