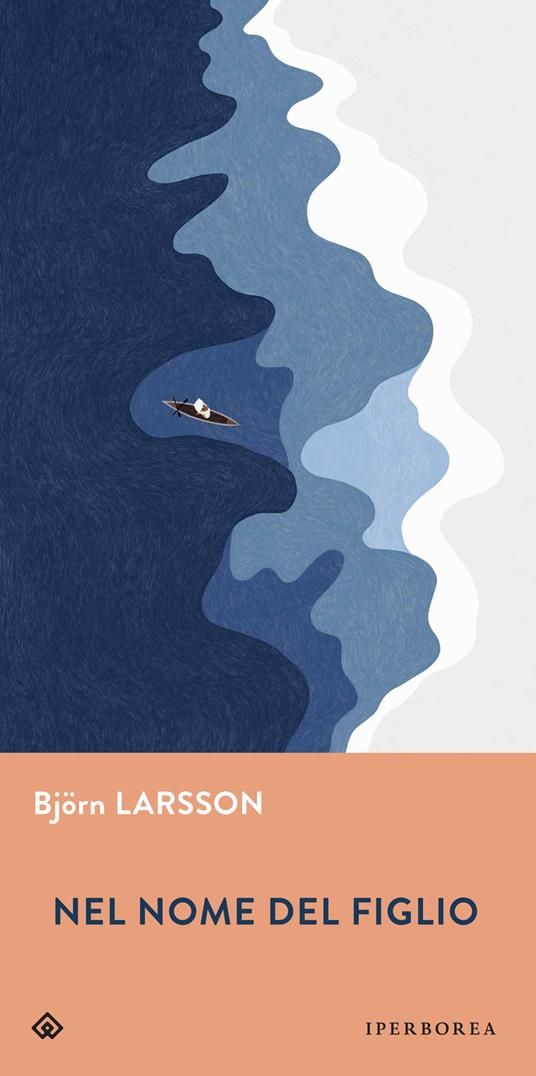
Perché leggere “Nel nome del figlio” di Bjorn Larsson
Quand’è alla scrivania e lascia scorrere lo sguardo sui dorsi, si rende conto che molti di quei titoli, a prescindere dal genere, non gli dicono granché. Nella memoria sono rimasti solo i libri che ha letto più di una volta, per piacere personale – i romanzi di Maurice Leblanc su Arsenio Lupin, ladro gentiluomo, I tre moschettieri di Dumas, Festa mobile di Hemingway – o perché li ha usati per i suoi corsi, come Madame Bovary di Flaubert, Perceval di Chrétien de Troyes e La principessa di Clèves di Madame de La Fayette.
Gli piace credere, ed è quasi certo, che tutte quelle pagine lette e a lungo rimuginate, come pure le citazioni che ha trascritto, siano state determinanti per la sua formazione personale. Di sicuro sa che alcuni di quei libri lo hanno aiutato concretamente a formulare dei sogni e poi a realizzarli. Soprattutto quello di fare lo scrittore, ma anche di vivere a Parigi, navigare, fare immersioni e andare a caccia di minerali. I libri gli hanno anche fornito gli strumenti per comprendere il mondo e crearsi una visione dell’essere umano in generale, e questo a sua volta l’ha aiutato a vivere con gli altri.
Non sa invece, e vorrebbe sapere, se tutte le sue letture e esperienze di vita si siano stratificate da qualche parte nel suo cervello o siano perdute per sempre. Che fine ha fatto tutto quel che ha dimenticato, per esempio suo padre? Potrebbe recuperarlo, riviverlo? O quello che viviamo e proviamo agisce a nostra insaputa?
(Bjorn Larsson, Nel nome del figlio, 2021 Iperborea, pag. 153)
Perché l’onestà è un valore assoluto
Il 27 agosto 1961 a Skinskatteberg, una regione della Svezia centrale, una barca a motore troppo carica prende il largo per una gita sul lago. Nessuno saprà mai con esattezza che cosa sia successo, ma la barca si rovescia e le otto persone a bordo muoiono nell’incidente. Fra essi c’è Bernt Larsson, l’elettricista del paese. Suo figlio Bjorn, che all’epoca ha sette anni, su quella barca non è voluto salire ed è tornato a casa. Lì nella notte apprende, dal grido straziante della zia, della morte di suo padre. Nei giorni successivi non si parla d’altro e iniziano a circolare ipotesi e commenti accorati sulla tragedia che ha colpito il paese. Il figlio si rende conto invece che non sta reagendo come dovrebbe e come ci si aspetterebbe da lui: non prova dolore, al contrario si sente sollevato, liberato da un peso. Questa sensazione, che imparerà a celare ma di cui non si vergogna, non lo abbandonerà mai.
Ѐ questo il fatto centrale nella trama dei ricordi del figlio diventato adulto. Nel suo percorso esistenziale, ha realizzato alcuni sogni: viaggiare, essere libero, insegnare, scrivere. E ha conservato e nutrito in un angolo della mente interrogativi legati a quella morte che si faceva sempre più lontana nel tempo. Ora è venuto il tempo di estrarre l’idea di questa storia dalla cartellina in cui archivia i suoi progetti di scrittura, e di tradurla in parole: nasce così “Nel nome del figlio”, un’opera lucidamente in bilico fra romanzo e saggio, uscita in Svezia nel 2021 e tradotta da Iperborea. Il figlio è coraggioso e determinato; soltanto l’idea della perdita della coscienza suscita in lui una “vertigine ontologica”. Anche se sa che lo sforzo del singolo individuo, il suo sforzo di ricordare con onestà, non salverà la coscienza collettiva di una specie che sembra destinata all’autodistruzione, il figlio si porta dentro da quando è nato una determinazione feroce a cercare liberamente la verità. Sente che deve farlo attraverso la scrittura, perché per lui “la libertà si basa sulla capacità dell’uomo di usare la lingua (…) per mettere in discussione quello che si percepisce con i cinque sensi e capire se è la realtà”.
Cosa porta in sé, il figlio, di quel padre dal quale si è staccato con tanta facilità? Se fosse rimasto con lui, sarebbe stato capace ugualmente di realizzare i propri sogni, o avrebbe scelto diversamente? Dei sogni del padre, se ne aveva, che ne è stato?
Perché cerca nella memoria le ragioni dell’identità
“I fatti, direttamente dalla memoria”: così il narratore, alter ego dell’autore, introduce il suo percorso di osservazione del figlio, matrice dell’uno e dell’altro. La narrazione muove dalla memoria individuale, il povero corredo di certezze materiali del figlio: dieci fotografie, sette ricordi su cui può contare con certezza. Tocca poi le memorie della ristretta cerchia familiare: racconti troncati e rapidi accenni, della zia, del nonno e di qualche conoscente. Si allarga infine al contesto sociale e politico: cosa accadeva in Svezia e nel mondo, mentre il dramma familiare di Bernt Larsson si consumava? Alla costruzione di questo edificio psicologico e sociale si accompagna, con intensità crescente, una riflessione filosofica sull’identità, caratterizzata da razionalità e scetticismo: perché “Cercare di comprendere sé stessi a partire dalle teorie generali sulla psiche umana è un esperimento interessante, ma può dare frustrazione. E resta da capire se serva davvero a qualcosa”. Il narratore esplora diverse ipotesi sul processo di costruzione e mantenimento dell’identità attraverso la memoria (Freud, Bergson, Tadié, le moderne neuroscienze), e intreccia le sue riflessioni con appunti e suggestioni tratte dai romanzi che hanno segnato il suo percorso di vita.
Il filo rosso del discorso è rappresentato dai libri, primi fra tutti i pochi che ha ereditato, e dalle supposizioni che si possono fare a partire da essi, confrontando le passioni e le scelte del padre con quelle del figlio. Ad esempio, l’esistenza di un nucleo comune – la passione per la geologia e i minerali – basta ad affermare che “il padre ha lasciato un’impronta nel mondo attraverso il figlio, e che attraverso di lui ha continuato a vivere?”:
E la passione del figlio per le immersioni? Non dovrebbe ricollegarsi al desiderio segreto di emulare il padre? O magari padre e figlio condividevano la tendenza a essere affascinati da quello che non era stato ancora scoperto, dall’ignoto? Era anche questo ereditario? (pag. 85)
Analizzando i gruppi parentali di cui ha fatto parte (la sua famiglia di origine e quelle danese e salentina delle sue compagne di vita), il figlio non nutre alcuna fiducia nella famiglia, luogo di affetti che non si scelgono e spesso si fingono. Diffida quindi della supposta ereditarietà di atteggiamenti e valori, e ne prende le distanze anche rispetto alla ricostruzione memoriale e al rischio costituito, nella riflessione su sé stessi, dai falsi ricordi. Il figlio condivide con Georges Perec, uno scrittore che ama particolarmente, un atteggiamento di “spudorata sincerità”: entrambi “non possono che accontentarsi dei ricordi che hanno. Perché l’alternativa sarebbe “cedere alla tentazione di inventarne di nuovi, di crearsene con la menzogna”. Ѐ forse per questo, come gli hanno mostrato i critici, che i suoi personaggi sono privi di un passato.
Per l’idea di letteratura
“Nel nome del figlio” è anche una riflessione potente sulla letteratura. Con crescente intensità e sempre in forma di frammenti e osservazioni non sistematiche, Larsson riconosce nella tradizione letteraria debiti e ispirazioni, mostrandosi invece diffidente di fronte ai meccanismi editoriali contemporanei. Egli rifugge l’appartenenza a una qualsiasi “casa” letteraria e diffida del favore incondizionato concesso spesso in modo acritico dal pubblico a libri e scrittori: “non solo – afferma – perché uno scrittore deve essere libero dai legacci di qualsiasi senso di appartenenza, ma anche perché quella luce accogliente che circonda la nostra casa, quale che sia, non ci offre la minima garanzia di pace contentezza e serenità”. Nel mondo contemporaneo, “la letteratura è diventata merce deperibile, con una data di scadenza a breve termine, stabilita dal mercato editoriale e dall’indiscriminata sete dei lettori per l’ultima novità”. L’ultimo grido nelle storie letterarie e in quelle sullo schermo, è scrivere romanzi basati su una storia vera: forse, osserva Larsson, scrittori e registi sono rimasti a corto di fantasia. O forse “la realtà è così piena di finzione” che appiattisce le storie su di sé, impedendo a scrittori e lettori di guardare oltre l’orizzonte di ciò che esiste già, per immaginare ciò che potrebbe esistere.
In modo coerente, l’autore dubita che la letteratura fornisca un preciso insegnamento, culturale o morale. Il suo insegnamento è semmai l’invito “a chiederci in assoluta libertà se vogliamo continuare a vivere, pensare, sentire e usare la lingua come ciascun* di noi (l’asterisco è per comprendere le persone ermafrodite, transessuali e transgender) ha sempre fatto fino a quel momento”: e la risposta può essere e spesso effettivamente è che non desideriamo affatto cambiare.
Da queste convinzioni discende il suo timore di ripetersi e l’esigenza di inventare invece storie sempre nuove. Tenersi lontano dalle mode e dalla tentazione rappresentata da ciò che già si conosce significa dare voce alla propria libera coscienza e fare un dono agli altri:
la letteratura deve porre interrogativi, mettere il lettore davanti a una sfida, nel migliore dei casi diventare una spedizione in terre ancora in gran parte inesplorate, geograficamente, storicamente, emotivamente e linguisticamente. Finito un libro, sia lo scrittore che il lettore dovrebbero chiedersi se vogliono rimanere quelli che sono. Vivere le esperienze degli altri, persone o figure fittizie che siano, è un modo di allenarsi a essere diversi da sé stessi, e magari di scoprire che si vorrebbe o si potrebbe, almeno in parte, diventare diversi. (pag. 203)
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo
Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo -
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
Commenti recenti
- massimo ferrari su Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivoOttima recensione, sintetica com’è giusto che sia, ma preceduta da un lavoro di analisi che…
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento