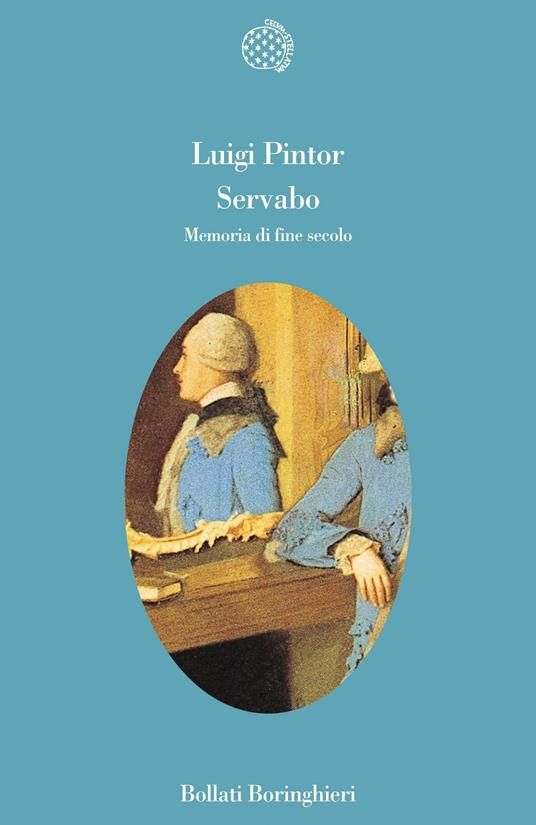
Servabo: soggezione e utilità della memoria secondo Luigi Pintor
Sarei stolto se attribuissi a fattori esterni tutto quanto mi è accaduto di buono o di cattivo. È probabile che per un difetto del carattere o una congenita debolezza io fossi in partenza più disposto di altri a subire l’eredità della guerra. Scritta sotto il ritratto di un antenato mi colpì, quand’ero piccolissimo, una misteriosa parola latina: servabo. Può voler dire conserverò, terrò in serbo, terrò fede, o anche servirò, sarò utile. Ma conservare o servire sono termini sconvenienti, che implicano una soggezione, il senso di un limite, un vincolo. Può darsi dunque che se la mia psicologia è rimasta prigioniera della guerra e di altri sfavorevoli eventi sia tutta colpa di quell’antenato e del suo enigmatico precetto. (Luigi Pintor, Servabo. Memoria di fine secolo, Bollati Boringhieri, 1991¹; 2005, p.14)
Servirò, sarò utile
La complessa e spesso tirannica fisionomia della memoria era chiara, molto prima che a Freud, alla latinità; tant’è vero che, per indicare l’azione del ricordare, il latino ricorreva a verbi diversi a secondo della modalità, dell’inclinazione, del contenuto, della profondità del ricordo. Su tutti colpisce il verbo memini, meminisse, il rigore della sua coniugazione esclusiva: solo al perfetto, come il confratello odi, odisse. Niente a che vedere con il ricordo (o l’antipatia) fugace o flebile: questi verbi ci parlano piuttosto di una memoria (o di una avversione) stratificata, consolidata, perfecta, appunto.
Oggi per ricordare (o, come si dice, per non dimenticare) abbiamo avuto bisogno di istituire le giornate della memoria e del ricordo. Torna utile – allora – rileggere questo piccolo e prezioso libro. Luigi Pintor (prima redattore poi condirettore de “L’Unità”, nonché fondatore de “Il manifesto”) vi racconta in brevi e intensissimi capitoli L’isola (la Sardegna dove «sobria e benevola scorreva la vita familiare»), La città (la Roma pre e post bellica), La guerra (il secondo conflitto mondiale, Pintor era nato nel 1923), La mina (quella che uccide suo fratello Giaime), La prigione («per imprudenza cospirativa»), La pace («normalità che somigliava a una diserzione»), Il matrimonio («impulso innocente»), Il mestiere (il giornale vissuto come «un centro di addestramento, una comunità e una scuola»), Lo scenario (il tempo delle «passioni sincere, nobilmente iscritte nella gigantesca cornice della storia»), L’esilio (per aver varcato «una soglia proibita oltre la quale ogni pensiero è abusivo»), L’avamposto («di nuovo dopo trent’anni in un giornale povero»), Il dolore (la malattia, «sinonimo di separazione e solitudine», che irrompe nella sua casa), fino all’Epilogo («un libro serve a chi lo scrive, raramente a chi lo legge»).
Torna utile prima di tutto per proiettare la memoria nel futuro – servabo –, per farne lievito e non conservante. È vero che, come tutto ciò che abbia utilità, questo impone alla memoria soggezione a un servizio e relativi vincoli. Ma sono vincoli di lealtà, di onestà intellettuale, di lucidità: se tutte e tutti ai nostri giorni ne avvertissimo la soggezione, non sarebbe sconveniente; anzi.
Torna utile lo stile in cui il libro è scritto: elegante, sobrio, rispettoso, del tutto antieroico e antiretorico. Luperini, recuperando la lezione di Foa e di Timpanaro, ricondurrebbe questo stile a una scelta di scrittura democratica e lo stesso Pintor lo racconta così:
Per anni ho applicato alla scrittura le tecniche meticolose che si usano su una tastiera [Pintor suonava il piano, n.d.r.]. Ritagliavo e limavo i miei scritti stampati sul giornale, interminabili resoconti di discorsi altrui e timide prove personali, scoprendo che c’è sempre una riga su tre di troppo e arrivando alla conclusione che due pagine (come ancora sostengo) bastano a esaurire qualsiasi argomento (p.61).
Torna utile la ragione profonda di questa scelta stilistica – anche se oggi, a definirla ideologica, avremmo timore di farle torto. A sostenere quella scrittura così limpida, così pudica e generosa, c’è infatti un convincimento (una “fede”) forte, solidale: «Non c’è in un’intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi» (p.85). E questo vale sia che un altro sia una persona familiare e molto amata, sia che un altro sia semplicemente una persona sconosciuta e meno fortunata:
Sentivo che la mobilitazione proclamata nei giorni di ferro e fuoco non poteva finire nella banalità e cercavo un compito da assegnarmi. E così mi convinsi a prender partito, non per grandi imprese, ma per stare in compagnia della gente meno fortunata e sostenerne le buone ragioni. (p.49)
E poiché gli operai possono fare da soli moltissime cose meglio di chiunque, ma più difficilmente un prodotto immateriale com’è un giornale, fui persuaso che questo compito spettava a dei giovani acculturati, purché lo assumessero come un compito speciale: un compito d’onore. (p.59)
Conserverò, terrò in serbo, terrò fede
Per adempiere dignitosamente «un compito d’onore», è necessario serbarne intatta la spinta etica, tenergli fede. E sono struggenti, ma esemplari – anche stavolta – per stringatezza e rigore, le pagine in cui Pintor racconta di cosa quella fede si sostanziasse. Lontani di oltre quindici anni dalle polemiche (sopite, ma forse non spente) che avevano accompagnato la pubblicazione degli scritti del fratello Giaime, «questi appunti sono soltanto un espediente per riordinare nella fantasia dei conti che non tornano nella realtà» (p.89). Bilancio malinconico per chi aveva fermamente creduto di dover «stare in compagnia della gente meno fortunata e sostenerne le buone ragioni», per chi aveva imparato «prima di leggerlo sui libri, che gli operai avrebbero liberato il mondo liberando se stessi» (p.43), per chi, giovanissimo, incurante del coprifuoco, si era «avventurato fuori di casa per appendere agli alberi o ai lampioni piccole bandiere rosse», «le bandiere che avevano sbaragliato sul campo le armate tedesche e umiliato le loro insegne uncinate, le bandiere da cui dipendeva in quei giorni l’onore del mondo», per chi si rifiutava di capire «come molti che hanno vissuto una così grande stagione l’abbiano dimenticata fino a rovesciarne il senso» (p30): «la realtà» pesantemente scuoteva chi aveva osservato quella fede fino in fondo. Ma di questa realtà Pintor non dimentica mai di essere stato, fino alla fine, attore e responsabile, anche quando la rabbia, la delusione o più genericamente «le circostanze» avrebbero potuto indurlo a scaricare la responsabilità altrove. Così racconta se stesso quando, ancora liceale, si decide a prendere parte a un attentato contro sconosciuti, in un qualsiasi pomeriggio domenicale:
Avevo saputo che mio fratello era morto, la notizia mi era arrivata in quei giorni con incredibile violenza e anche questo potrebbe spiegare il mio comportamento. Ma non lo credo, non c’è nei miei ricordi un sentimento di vendetta o ritorsione, il colpo che avevo ricevuto non era così epidermico. Semmai fu per un senso del dovere, che può essere ingannevole se non si accompagna a una matura convinzione. O forse fu semplicemente una questione di circostanze, alla fine è sempre una questione di circostanze. Amo tuttavia credere che nessuna circostanza mi farà agire di nuovo come quel pomeriggio, contro un bersaglio occasionale, anche se avrò di nuovo quell’età. (pp.31-32)
Fin dalle prime pagine, dedicate alle esperienze giovanili, si avvia una riflessione luminosa sulla responsabilità individuale, che non stonerebbe, pur negli accenti diversi, accanto a quella di Manzoni, di Sciascia, di Arendt e che trova, nella lezione impartita dalla guerra, argomenti che, fino ai nostri giorni, inchiodano tutti e tutte alla stringente necessità delle scelte:
Non ero neanche sicuro che la guerra fosse finita. Sembrava piuttosto una tregua carica di minacce, come se gli uomini non avessero imparato nulla e quel lascito di cadaveri e di macerie non li avesse convertiti alla saggezza ma addestrati a una futura ecatombe. I vincitori somigliavano stranamente ai vinti (…) come se la guerra fosse stata svuotata delle promesse che l’avevano nobilitata e confessasse ora la sua vera natura, fredda regola di una storia sempre uguale.
Ero stupito che la normalità si riproducesse così velocemente (…). Ora non c’erano tante divise, tutti indossavano abiti indistinti ma la diversità dei destini, quella divisione in due tra superiori e inferiori che si vede così bene nella guerra, riappariva identica sotto le forme della civile convivenza. Chi tornava a comandare nelle nuove istituzioni aveva gli stessi connotati dei predecessori, chi tornava a ubbidire nella vita quotidiana conosceva le stesse umiliazioni (…).
Strana e subitanea metamorfosi, le gente non aveva più nello sguardo quella domanda e quell’offerta di solidarietà che trasmetteva tacitamente nei giorni della sofferenza. Ora un desiderio di rivalsa animava ciascuno contro l’altro, ciascuno alla ricerca della sua parte di bottino, nella grande fiera che imparerò a chiamare capitalistica, dove miseria e abbondanza e ogni genere di mercanzia sono in perenne compravendita. (pp.48-49)
Di fronte a quella lezione si pone, senza infingimenti, senza alibi, il giovane intellettuale; e se, appena conclusa la guerra, incontrando «il vecchio compagno di cella tornato al suo mestiere di muratore» non riesce a reprimere «un vago senso di colpa» (p.49), qualche anno dopo, nella campagna «dove due braccianti erano morti poche ore prima uccisi dal fuoco della polizia», comprende come non ci sia «nessuna differenza tra i colpevoli altolocati di quel delitto di paese e la filosofia del privilegio che aveva incendiato il mondo» (pp.66), comprende che «ci sono due mondi», che «quei morti appartenevano al più degno» e che «stare da una parte diventa più complicato ma più necessario»:
Non cesserò di pensare che i mondi sono due ma imparerò che la linea divisoria non è segnata su nessun atlante e passa fin dentro il cuore dell’uomo (…). Era giusto stare da una parte anche là dove la linea divisoria si assottiglia fino a scomparire, nelle fredde istituzioni dove il potere celebra se stesso, aule o palazzi fastosi dove i passi girano in circolo su percorsi ciechi, le immagini si inseguono in un gioco di specchi, le parole sono ovattate e i pensieri ignorano la verità. Qui, dove mi portava il lavoro quotidiano, era facile smarrirsi, qui i due mondi si confondono in quello peggiore e stare da una parte è un giuramento da ripetere ogni giorno. (p.66)
Due pagine. Ci fermiamo qui, non perché qui si esaurisca la riflessione di Pintor, ma per onorarne anche così, con la misura da lui suggerita e perseguita, la lezione di dignità, di umanità e di rigore.
Articoli correlati
No related posts.
Comments (2)
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Donato Russo su Nuovi doveri per il mondo in trasformazioneElio Vittorini. Grande Intellettuale. Prodigo di tante meravigliose idee letterarie. Autore da leggere e riscoprire…
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


La parabola di Luigi Pintor (1925-2003) attraversa, a partire dal periodo fascista, dalla seconda guerra mondiale e dalla Resistenza, tutta la seconda metà del Novecento, legandosi per un lungo tratto al Pci, del quale questo intellettuale sardo fu dirigente, giornalista e deputato. La fisionomia che ha contraddistinto la personalità di Pintor è stata quella propria di un intellettuale di stampo giacobino, di un polemista corrosivo, di un tenace, inquieto ed elegante interprete della direttiva gramsciana sul pessimismo dell’intelligenza e sull’ottimismo della volontà. “Servabo” è un secco e nitido autoritratto, in cui Pintor rievoca le scoperte culturali che segnarono la sua adolescenza: Vittorini, Pavese e, in particolare, Melville, rappresentante eponimo della narrativa americana, che restò sempre uno dei suoi autori prediletti; vi era poi la musica, una passione di famiglia. L’attività di Pintor fu quella tipica degli intellettuali “organici” all’interno del Pci: giornalista dell’“Unità”, prima come redattore politico, poi come condirettore dell’edizione di Roma; membro dell’Ufficio di segreteria del partito, consigliere provinciale a Roma e, nel 1968, deputato della Camera, eletto in un collegio sardo. Quando, nel Pci, l’ala sinistra rappresentata dai seguaci di Pietro Ingrao, il leader sconfitto all’XI congresso nel 1966, si pose come nucleo di una opposizione interna, fra i suoi esponenti vi furono Luigi Pintor, Rossana Rossanda e Aldo Natoli. Dopo la radiazione dal partito, nel giro di due anni la rivista si trasformò in quotidiano: era nato così “il manifesto”. Nei decenni successivi Pintor, dopo essersi riavvicinato al Pci, nelle cui liste sarà eletto deputato “indipendente” nel 1987, si distaccherà dal Pds, la formazione politica nata nel 1991 dalla liquidazione del Pci. Pintor era infatti un vero intellettuale marxista e comunista (con tutte le tensioni che sono ìnsite in questa duplice identità), talché accostare il suo nome a quelli di Manzoni, di Sciascia o della Arendt fa un po’ sorridere per l’ingenuità e l’acrisia che un siffatto accostamento rivela. Al contrario, è opportuno ribadire che le straordinarie doti di editorialista e di polemista, nonché lo spirito lucido e caustico che hanno reso Pintor una delle penne più scarnificanti e temibili del giornalismo politico-culturale italiano, non sono separabili da quella duplice identità. Gli editoriali che egli veniva scrivendo, una scelta dei quali apparve in un volume del 2001 intitolato “Politicamente scorretto”, erano spesso ironici, caratterizzati da quel “sarcasmo appassionato” che Gramsci faceva risalire a Lenin e che il grande comunista sardo aveva impersonato in modo esemplare. Simili a parabole laiche e a fulminanti epigrammi, esprimevano la stessa felicità di scrittura e lo stesso distacco raffinato e pungente che Pintor rivela nelle sue memorie, dal già citato “Servabo” (1991) alla “Signora Kirchgessner” (1998) al “Nespolo” (2001).
Oltre che molto bello, questo contributo è veramente utile, anche per la stringatezza rivendicata e praticata. Utile all’umano colloquio, specie in questi tempi in cui l’oscena mescolanza di iperliberismo e cultura neo-fascistoide, spossessamento sociale civile e culturale programmato, angoscia per il presente e per il futuro, futilità totalizzante della chiacchiera, hanno superato le peggiori previsioni dei più pessimisti.