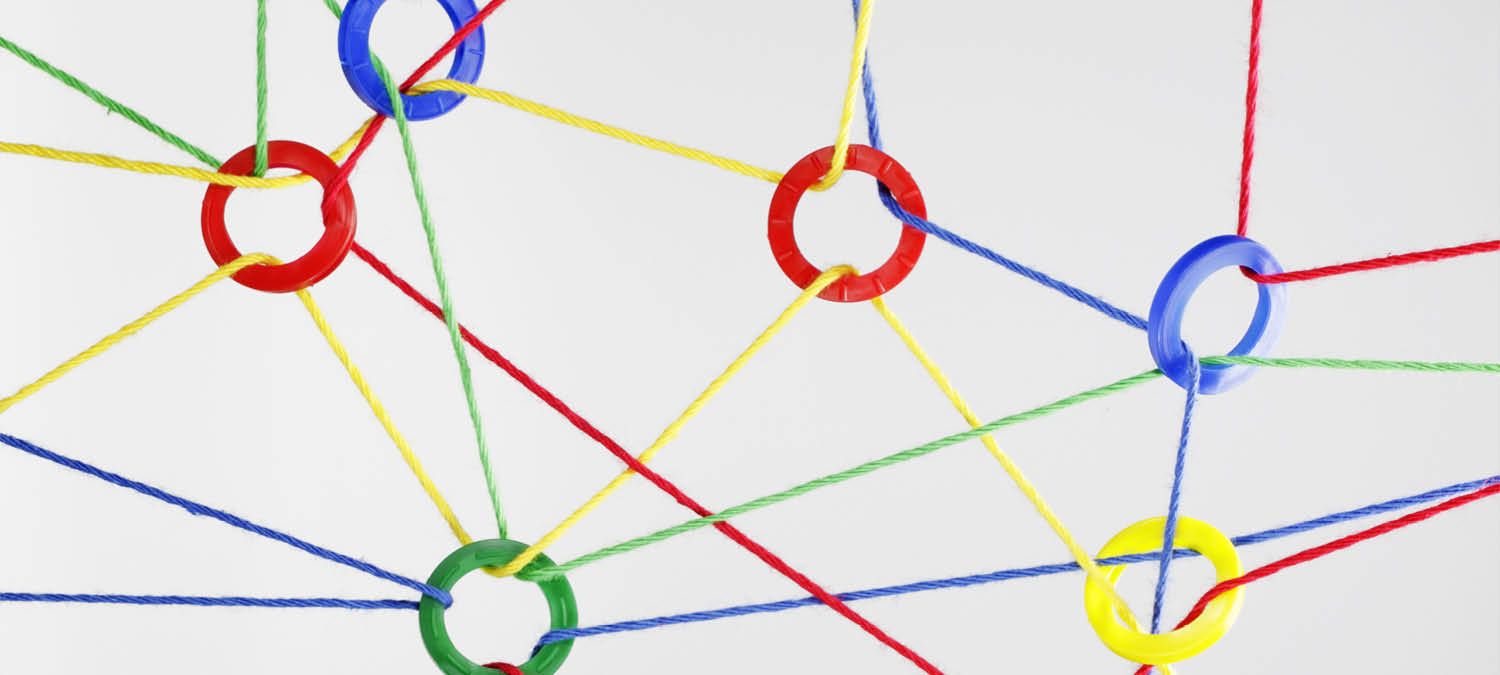
Pinocchio resta a scuola. Smartphone a scuola /1
Per amore o per forza
«Canta pure, Grillo mio, come ti pare e piace; ma io so che domani all’alba voglio andarmene di qui, perché, se rimango qui, avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà a studiare; e io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia».
La scuola è ripresa e lo ha fatto, come dice Pinocchio, per amore o per forza, portando in dote i soliti buoni propositi di settembre che poi, a ben vedere, sono gli stessi amari bilanci di giugno dopo il clemente oblio dell’estate.
Un tema, in questi giorni molto popolare, può essere, però, il volano per altre, più ampie riflessioni.
La possiamo forse collocare fra le questioni più comuni e spinose dello stare a scuola: esiste un modo per impedire l’uso dei cellulari durante le lezioni che metta d’accordo tutti? Se n’è parlato recentemente perché un liceo di Bologna li ha vietati, non solo in classe come già succede in molte scuole, ma anche a ricreazione. Il provvedimento è stato esteso anche ai docenti.
Come sappiamo, la querelle, da sempre, sembra ingabbiata in una dicotomia che va dalla sottrazione coatta del telefono, con le sue temute implicazioni legali agli esempi delle scuole che invece ce l’hanno fatta, come quella bolognese, senza incorrere in conseguenze nefaste.
Una volta scelto da che parte stare, cosa rimane della lezione?
E soprattutto, con o senza telefono in classe, cosa accade, oggi, durante la lezione?
Alla fine dello scorso anno scolastico, nella scuola secondaria superiore in cui insegno, è stato sottoposto agli studenti un questionario di gradimento che chiedeva loro di fare un bilancio e di rispondere alla ferale domanda su cui Pinocchio non avrebbe avuto alcun dubbio: vieni volentieri a scuola?
La stragrande maggioranza degli allievi aveva risposto di no.
Anche quelli seduti ai primi banchi che prendono sempre appunti e ti seguono nei corridoi, ebbene, anche loro avevano confessato una segreta insofferenza.
Bella scoperta! Diranno subito i miei colleghi, che diversamente dai lettori di Collodi hanno sicuramente più esperienza e per i quali, talvolta, il binomio scuola-infelicità è una componente spiacevole ma inevitabile dell’apprendimento. Cercare quindi di rendere la scuola un luogo felice sembrerebbe la più disperata delle imprese. Quest’esercizio della frustrazione, apparentemente ontologico dell’ambiente scolastico, perché la disciplina porta con sé un corollario di regole e castrazioni, però oggi non riguarda solo gli studenti. Lo stare a scuola per amore o per forza e la ricerca di vie di fuga digitali sembrano sempre di più anche una prerogativa degli insegnanti.
Secondo Luciano Floridi, filosofo dell’Informazione e della Tecnologia all’Università di Oxford, siamo alle prese con una “quarta rivoluzione” che riguarda il ruolo centralissimo del digitale nelle nostre vite, Floridi lo teorizzava già nel 2009. Nel suo libro Pensare l’infosfera,pubblicato da Cortina Editore nel 2020, il paradigma viene ribaltato e si passa dall’analizzare il cambiamento drastico, all’effetto che piuttosto ha prodotto su di noi tutto questo potere computazionale. Insomma, come e quanto ci ha trasformato la quarta rivoluzione.
La lotta sempiterna ai cellulari che negli ultimi quindici, vent’anni si è focalizzata esclusivamente sugli studenti sembra infatti aver dimenticato che ormai siamo tutti phono sapiens e che, come dice Byung-Chul Han nel suo ultimo libro: Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale (Einaudi), ambiamo solamente a liquefarci nel Cloud.
Quello che potrà sembrare benaltrismo è in realtà un tentativo di rovesciamento della diffusa visione manichea che ci vede come educatori che si sono salvati dagli effetti vischiosi dell’infosfera contro gli studenti-anime prave.
Forse considerarci tutti coinvolti in questo processo di enorme trasformazione potrebbe essere, finalmente, se non la chiave di volta, il punto di partenza per cominciare un percorso che punti al recupero del valore della lezione?
Se cambiassimo il paradigma che vede i cellulari come i principali responsabili della perdita d’interesse e ammettessimo che la didattica sta attraversando una crisi epocale perché è necessario trovare nuovi linguaggi, nuovi mezzi e nuove strategie per parlare con una generazione che si evolve con una velocità che non avevamo mai sperimentato prima, ebbene se lo facessimo, non sarebbe come ammettere la sconfitta, piuttosto significherebbe che la scuola è ancora viva e, come tutto ciò che vive, ha bisogno di adattarsi al cambiamento per andare avanti.
L’ora di lezione
L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento di Massimo Recalcati resta, ancora oggi, uno dei testi più citati quando si vuole elogiare il lavoro del docente e operare un discernimento fra la classica lezione frontale che riduce lo studente a oggetto di apprendimento passivo e quella partecipata in cui l’insegnante riesce ad “accendere il desiderio” attraverso poche, ieratiche verità che pronunciate nel momento giusto possono cambiare le sorti di un allievo. Il testo di Recalcati ci parla della sua esperienza come studente che – penalizzato e messo ai margini dal sistema scolastico – ha trovato la giusta motivazione grazie all’intelligenza e allo sguardo attento di una giovane insegnante di italiano. Quello che sembriamo dimenticare quando citiamo gli efficaci passaggi del testo è che la scuola di cui ci parla lo psicoanalista è quella degli anni Settanta, in cui una figura dissonante come la Professoressa Giulia portava davvero una ventata di novità e trasgressione e in seconda battuta che il libro è del 2014 e in questi otto anni la scuola è stata attraversata, salvata e cambiata irreversibilmente dalla tecnologia. Queste precisazioni non vogliono togliere valore al principio del trasporto erotico verso il sapere di cui si fa portavoce Recalcati ma sono necessarie per evidenziare i limiti di alcune riflessioni legate all’uso dei dispositivi informatici in classe:
«Se una maestra propone ai bambini delle elementari una ricerca sui fiumi della Lombardia – ricerca che un tempo avrebbe richiesto uno sforzo di consultazione che avrebbe impegnato un intero pomeriggio -, oggi è sufficiente cliccare su google per avere immediatamente la risposta che si cerca. La dimensione dell’esperienza è totalmente evasa da un sapere pret-à-porter, sempre a disposizione, che, di fatto, genera anoressie mentali, rigetto della ricerca del sapere nel nome di una sua acquisizione senza sforzo».
La retorica della ricerca che necessita di tempo e fatica per poter essere completa, pur contenendo una verità, è ormai anacronistica rispetto alla modalità che oggi tutti utilizziamo per reperire informazioni. Il sapere che Recalcati definisce pret-à-porter lo è a causa dell’eccesso di semplificazione che ha coinvolto e stravolto il sistema scolastico negli ultimi anni e non per l’uso dei dispositivi tecnologici che, anzi, se usati correttamente possono essere dei validi ausilii didattici. Nella “scuola delle competenze” è diventato indispensabile dare più spazio al generale che al particolare. Diventare competenti in tutto però si avvicina molto a esserlo in niente. Nel bel testo di Edgar Morin, La sfida della complessità, che è già stato meritatamente citato su queste pagine, si dice che «L’incapacità di riconoscere, trattare e pensare la complessità è un risultato del nostro sistema educativo. Questo ci insegna a convalidare ogni percezione, ogni descrizione, ogni spiegazione in base alla chiarezza e alla distinzione. Ci inculca un modo di conoscenza emerso dall’organizzazione delle scienze e delle tecniche nel XIX secolo, che si è esteso all’insieme delle attività sociali, politiche e umane. In tutti i campi, esso astrae, cioè estrae un oggetto dal suo contesto e dal suo insieme, rifiutandone i legami e le intercomunicazioni con il suo ambiente, l’inserisce in un compartimento che è quello della disciplina le cui frontiere spezzano arbitrariamente la sistematicità […] e la multidimensionalità dei fenomeni». Questo metodo che tipo di sapere produce? Morin lo definisce anonimo perché ignora il singolare, il concreto, il soggetto, l’affettività, la sofferenza ecc. Il suo è quindi un invito a percorrere una strada che regala ben più grandi soddisfazioni di quella più modesta del pensiero semplificante. Immaginare di poter “sedurre” con il solo potere della parola tra i venti e i trenta adolescenti, per quasi un’ora ed evitare che ci siano sguardi furtivi sui monitor dei cellulari, non è quindi solo utopico, ma ci allontana anche da quello che dovrebbe essere il vero obiettivo della lezione: la complessità.
Una complessità che traccia un solco, un vuoto che i ragazzi dovranno riempire anche con gli strumenti che padroneggiano e conoscono. Un sapere che parte dal testo e si fa ipertesto ma non per questo ne tradisce la verità. La scelta di approfondire alcuni argomenti, sacrificandone altri, creando nuclei tematici che possano connettere gli studenti con il reale. Problematizzando la disciplina, soprattutto correndo il rischio di non essere sempre ascoltati.
La rappresentazione cinematografica e letteraria dell’insegnante à la John Keating de L’Attimo fuggente ha prodotto un senso di inadeguatezza in tutti coloro che, in questi anni di profonde trasformazioni dei codici comunicativi, si sono ritrovati a perdere autorevolezza nelle classi.
Negli ultimi anni, la lezione e ciò che contiene è diventata una piccola parte di un tutto fatto di moduli, modelli, relazioni e funzioni strumentali. Un lavoro che ha abdicato al principio della complessità intellettuale per sposare quello della semplificazione burocratica e, spesso, della frustrazione.
Da grillo a fata madrina
Da quando non indossiamo più le mascherine, i miei studenti hanno potuto notare che spesso sorrido mentre sono con loro. Giorni fa, un allievo me lo ha comunicato con un certo stupore; di solito i professori non sorridono, mi ha detto.
È da poco uscito per Marsilio l’ultimo romanzo di Gaja Cenciarelli, scrittrice, traduttrice e docente d’inglese in un liceo romano. Domani interrogo, rispetto al testo di Recalcati, ci restituisce un ritratto della scuola italiana e dei docenti molto più disperato ma abbastanza realistico, in cui la protagonista è felice, sorride, nonostante gli sforzi non sempre ripagati; le piace stare in classe e gli studenti lo sanno e, come spesso accade, se ne approfittano, lo apprezzano, lo mettono in dubbio, lo usano come criterio per assegnarle affetto e fiducia e poi a volte se ne dimenticano. In questa complessità, galleggiano e a volte affondano le fragili certezze della professoressa che cerca di insegnare Joyce a ragazzi di periferia, con storie personali e familiari difficili. La felicità di cui ci parla questo romanzo non è quella levigata dell’Attimo fuggente o quella di tante (troppe!) fiction sulla scuola che si ostinano a mostrare sempre e solo due modelli scolastici: quello del liceo-fucina-di-geni con insegnanti carismatici e infallibili e quello della scuola di frontiera dove non c’è spazio per la conoscenza perché bisogna solo pensare a sopravvivere. Ciò che resta sul fondo è fatto di istituti tecnici e professionali, licei non solo classici e scientifici in cui si lavora sodo, in cui gli insegnanti a volte sono soddisfatti e a volte no, in cui gli studenti a volte sono felici e a volte no, più spesso no, ma comunque, per amore o per forza si insiste. Questo fondo è la scuola italiana.
“Con una classe docente sempre più precarizzata e con studenti che vengono da famiglie sempre più precarie”, dice giustamente Chiara Valerio, editor e responsabile della narrativa per Marsilio, la casa editrice che ha pubblicato il romanzo della Cenciarelli. Diventa a questo punto fondamentale capire come rendere di nuovo la scuola, nonostante lo stato in cui versa e il perpetuo disinteresse delle istituzioni, il felice luogo dell’incontro.
L’incontro con il sapere e quindi anche con l’Altro, con tutto il bagaglio di contraddizioni che oggi comporta: la progressiva perdita del supporto cartaceo per il digitale, della scrittura a mano e del corsivo, dell’attenzione oltre la soglia dei dieci minuti, della liturgia dell’ora di lezione. Sono tutte cose con le quali siamo chiamati a fare i conti anche nel nostro quotidiano. La vera sfida della complessità è quella che trova nuovi linguaggi e getta ponti tra il passato e il presente senza mitizzare il primo e condannare aprioristicamente il secondo. Una volta accettato che il nostro lavoro come docenti si è modificato ma non ha perso importanza, si può davvero operare una rivoluzione: trasformare la tecnica in cura, quel pharmakon di Platone che si fa medicina e non veleno come dice Carlo Bordoni ne L’intimità pubblica, quello che da grillo parlante ci muterebbe in fata madrina, l’unico personaggio del romanzo di Collodi che ha un impatto trasformativo sulla vita di Pinocchio. Colei che fa diventare il burattino un bambino vero ma che è anch’essa multiforme: umana, volto, animale, notizia, sogno.
Articoli correlati
No related posts.
Comments (8)
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
Commenti recenti
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
- Matteo Zenoni su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Stefano, isolo questa frase “la digitalizzazione non ha prodotto una riduzione del lavoro, ma…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Ciao, penso che dovresti dare un’occhiata a questo libro, “Emergenza smartphone: I pericoli per la salute, la crescita e la società” di Manfred Spitzer, Giuliana Mancuso.
Inizia a leggerlo gratuitamente: https://amzn.eu/50mIiIb
La ringrazio del consiglio, Ernesto. Lo farò sicuramente.
Grazie di aver analizzato l’aspetto controverso dell’uso degli smartphone in classe da un punto di vista complesso, illustrando proprio la complessità del “fare lezione” in relazioni, luoghi e tempi complessi, e menzionando la difficoltà per gli studenti di stare a scuola. Ho trovato utile anche il riferimento ai modelli opposti di lezione frontale e insegnanti ideali in versione “attimo fuggente”: quest’ultima narrazione è particolarmente presente nel campo dell’insegnamento dell’inglese negli ultimi decenni (insegno inglese privatamente e vedo quotidianamente i due modelli), ora solo da alcuni riconosciuta come non più adeguata ai tempi. Diffondo volentieri.
Grazie Laura! Dal confronto con i colleghi, che è uno degli aspetti più preziosi dello stare a scuola, ho capito che siamo in tanti a pensare queste cose ma raramente troviamo una loro rappresentazione al cinema, in TV o nella narrativa. Forse già iniziare a parlarne è importante per invertire la tendenza.
Gentile Valentina,
grazie del contributo.
Grazie a te, Marco.
Articolo davvero interessante, profondo e soprattutto senza paraocchi. Lei ha qualche esempio concreto di “buona pratica” che va nella direzione da lei auspicata?
La ringrazio, Francesco. Far dialogare la mia materia con le altre e con la realtà è la “buona pratica” che cerco di applicare ogni volta che entro in classe. Non sempre ci riesco ma a volte i risultati sono sorprendenti. L’anno scorso ho proposto agli studenti un laboratorio di fotografia e scrittura autobiografica. Ne ho parlato proprio qui, se le interessa lo trova come “Scatti consapevoli”. In quell’occasione i ragazzi hanno usato lo smartphone per scattare dei ritratti e poi sono passati alla macchina fotografica; il passaggio, quindi, dal selfie all’autoritratto. Hanno riflettuto sulla differenza del mezzo e sulla permanenza o meno dell’immagine. Hanno usato ciò che conoscono ma con una consapevolezza inedita.