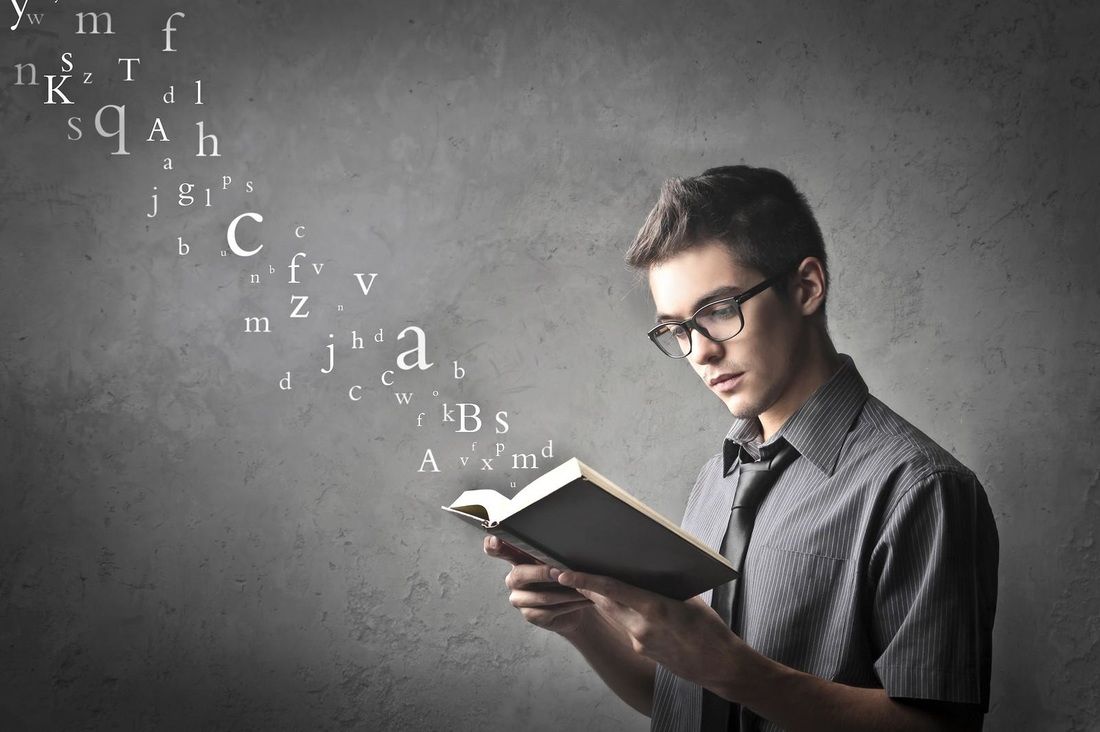
Il viaggio avventuroso dal pensiero alla scrittura
Il tema di cui discuterò alcuni aspetti in quest’articolo è la distanza fra voler dire e saper dire, al centro dell’esperienza linguistica e intellettuale vissuta dagli studenti a scuola e della costruzione di un percorso condiviso con gli insegnanti, di crescita e valutazione.
Si tratta di un elemento immediatamente percepibile, nell’ascolto e nella lettura delle parole delle ragazze e dei ragazzi di cui sono formate le nostre classi. All’altezza della secondaria superiore – l’ambito pressoché esclusivo della mia esperienza – la distanza è quasi sempre marcata: chi parla/ scrive spesso non dice quel che intende dire.
Nella comunicazione orale è possibile che lo studente proceda per progressivi aggiustamenti, e che il docente ricorra a strumenti molteplici (fra i quali rientra a pieno titolo la mimica facciale), verso una strutturazione logica e comprensibile del pensiero.
Non così nella comunicazione scritta, in cui la produzione avviene in solitaria, e c’è sempre una dissincronia (anche marcata) fra il momento della produzione e quello della correzione/ restituzione. Anche per questa ragione, la scrittura è un mezzo potente per accrescere l’autonomia e la capacità di ciascuno studente di avvicinare la lingua al pensiero. Intervenire per ridurre questa distanza è vitale, perché il prepotente sviluppo psicofisico e la crescita intellettuale delle ragazze e dei ragazzi determina di solito un notevole accrescimento della curiosità e del desiderio di collegare, criticare, interrogare se stessi e il mondo; ma lo sviluppo delle abilità linguistiche è ben lontano dall’accompagnare armoniosamente questa crescita, e se la distanza fra pensiero e lingua è marcata in partenza, sembra destinata inesorabilmente ad aumentare.
L’argomento mi è caro da anni, ma solo di recente sono riuscito a definirne alcuni punti cruciali in modo più preciso. È accaduto in un corso di formazione al liceo “Cattaneo” di Torino, sulla valutazione per competenze, prima che le circostanze tragiche che stiamo vivendo ci negassero la possibilità di stare insieme davvero.
Anche per questo è bello ricordarlo, e potrà forse essere utile discuterne insieme.
Focalizzare il problema
In un pomeriggio di attività seminariale, le docenti e i docenti dell’area umanistica che partecipavano si suddivisero in dodici piccoli gruppi, secondo la logica delle sottocommissioni dell’esame di Stato (aree disciplinari). Ogni gruppo aveva il compito di correggere e valutare cinque verifiche scritte; le prove erano le stesse per ciascun gruppo, e identica era la griglia di valutazione che si usava per descrivere e formalizzare il voto. Si trattava di elaborati che avevo assegnato ad una mia classe quarta durante l’anno precedente, riscritti al computer in modo che non ci fosse alcuna traccia della mia correzione, né del voto che avevo assegnato.
Gli esiti dell’esperienza furono molto interessanti, perché rivelarono notevoli discrepanze (fino a 2/ 10 per quasi tutte le verifiche) fra i voti attribuiti ad una stessa prova dalle diverse sottocommissioni.
Raccogliendo le idee su quest’esperienza metacognitiva – una sorta di valutazione collegiale sulla valutazione collegiale – ci sembrò di poter individuare due componenti che avevano determinato una così forte discrepanza fra i diversi soggetti che valutavano, nonostante il filtro costituito dalla pluralità di voci e punti di vista presenti nei gruppi (esattamente come accade nelle sottocommissioni d’esame).
In primis, a sollevare maggiore disaccordo erano le valutazioni legate alla correttezza formale, in tutti i suoi aspetti. I voti più bassi, infatti, erano spesso determinati da una doppia valenza della forma: mentre per alcuni gruppi questa veniva valutata una volta sola, utilizzando indicatori separati (i consueti aspetti di correttezza morfologica, lessico, sintassi, …), per altri – pur essendo oggetto di una valutazione separata – rientrava in gioco ogni volta che si dovevano valutare gli altri indicatori (conoscenze, comprensione, scelte interpretative).
La seconda riflessione riguardava il tipo di compito su cui si discuteva: a suscitare dibattito e a determinare voti molto diversi erano gli scritti caratterizzati da una forte discrepanza fra aspetti positivi e negativi, e da una profonda disarmonia fra il pensiero tradotto in parole (forma) e il pensiero in sé (contenuto).
Sin dalla preistoria, …
Riporto di seguito due passi significativi dei lavori sui quali la valutazione dei gruppi fu pressoché unanime, tratti dallo svolgimento di un testo argomentativo sul concetto di “opinione pubblica” e sul diritto di voto; nel lungo lavoro di preparazione allo scritto, svolto insieme al collega di Storia e Filosofia, era stato posto in particolare un quesito: se riconoscere indistintamente a tutti i cittadini il diritto di votare non potesse innescare pericolosi meccanismi di manipolazione del consenso.
Martina e Ruggero avevano scritto:
Beccaria discute sulla necessità di creare attraverso l’istruzione un canale comunicativo efficace fra il popolo e le istituzioni governative, per consentire una partecipazione consapevole di ciascuno alla vita sociale.
Prima di analizzare questa posizione, è necessario evidenziare almeno due differenze fra il nostro contesto storico-culturale e quello in cui egli maturò le sue convinzioni. In primo luogo, lo scenario politico attuale non deve essere pensato in termini di regioni o di singoli Stati, bensì in una dimensione di “globalizzazione”. In secondo luogo, nel XVIII secolo l’unico strumento di informazione era la stampa, mentre oggi disponiamo di molteplici canali comunicativi, caratterizzati da velocità di trasmissione e marcata facilità di manipolazione delle informazioni e delle opinioni.
Cesare Beccaria dice, nel suo brano, che i mezzi d’informazione come la stampa siano d’aiuto per la comprensione delle leggi del pubblico. Come dice lui: “Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno tra le mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti”. Anche in mia opinione, sin dalla preistoria l’ignoranza e il nemico principale e credo proprio che sta degenerando ai giorni nostri dove è sempre più alto quello che è il tasso di disinformazione dovuto principalmente dai social che per primi mascherano la realtà effettiva mostrandole al popolo in modo diverso.
Sono scritti esemplari per la compiuta adesione della forma al contenuto.
Nel primo, i riferimenti alle conoscenze sono impliciti e qualitativi. Da esso emerge una piena comprensione della complessità del testo e dei problemi che evidenzia, e lo sforzo riuscito di interpretarlo attualizzandone il senso. Questa articolazione del pensiero è accompagnata dalla lingua in modo dinamico e sfaccettato: la costruzione dei periodi è chiara e incisiva, attuata in base ad una logica di progressivo ampliamento del quadro culturale; il lessico è vario ed appropriato. Un pensiero autonomo incontra una lingua corretta e originale.
Nel secondo passo, all’autonomia del pensiero si sostituisce la ripetizione/ citazione e lo stereotipo (la degenerazione dei giovani, la responsabilità dei social media). Il lessico è approssimativo e impreciso, e ci sono alcuni gravi errori sintattici e ortografici. Spia inequivocabile di un incontro fra pensiero debole e lingua debole è la presenza di una delle formule linguistiche più vuote che si incontrano negli svolgimenti dei compiti di Italiano: “sin dalla preistoria” è infatti una formula per fingere profondità storica e riflessione personale, quando invece di solito l’una e l’altra sono assenti.
Che la valutazione di diverse soggettività sia stata coerente ed unanime, di fronte a scritti come questi, non stupisce: l’uniformità della valutazione è infatti determinata dalla piena coerenza fra forma e contenuto, sebbene ovviamente a livelli molto diversi fra loro.
Qui (non) si parrà la tua nobilitate
Non è questa la situazione più consueta: più di frequente la lingua insegue il pensiero, talvolta arranca dietro ad esso, nel tentativo di dargli una forma compiuta.
Elisabetta e Eljus, altre due cavie del nostro esperimento, scrivevano, commentando la poesia di Wyslawa Szymborska “L’odio”:
Confrontare ciò che studiamo alla nostra vita è importante nel nostro modo di vivere e soprattutto di pensare. Anche se è difficile, perché la scuola è lontana dalla nostra vita.
Questa poesia “Odio” ci costringe invece a farlo. Perché parla di ciascuno di noi e può essere interpretata personalmente da ciascun lettore. Prima di tutto mi fa venire in mente diverse altre poesie liriche che abbiamo studiato, come quelle di Catullo e Petrarca. Nelle quali il sentimentalismo vissuto è al centro dell’io lirico.
Dico che l’odio viene “liberato” perché in ognuno di noi si cela un angolo della mente dove risiede, e può essere diretto verso il nero immigrato o i guaiti del cane del vicino. La differenza tra i due esempi e che i secondi tengono a bada il proprio lato animale, cioè non ritornano ad essere “umane belve”, in uno stato di natura che, come teorizzato dal filosofo Hobbes, è uno stato in cui l’uomo si fa bestia manifestando i suoi istinti primordiali, pretendendo di avere qualsiasi diritto su tutti e trovando un limite solo nella prepotenza altrui.
Entrambi i testi sono caratterizzati da un forte polarizzazione.
Da una parte, evidenti limiti di compiutezza e precisione espressiva: la giustapposizione di pensieri che segna la sintassi di Elisabetta e, al contrario, l’accumulo disordinato di idee che andrebbero articolate separatamente, nella scrittura di Eljus; la comune vaghezza lessicale, manifestata da lei soprattutto con le ripetizioni, da lui con l’adozione di un registro metaforico che mescola livelli differenti e, in una certa misura, maschera le improprietà.
Dall’altra parte, è chiarissimo il tentativo di spostare il ragionamento dal piano ripetitivo/ esecutivo (individuazione di figure e di temi) a quello del giudizio critico e della valutazione soggettiva. Elisabetta e Eljus cercano di mettere a fuoco questioni importanti (il valore dell’attualizzazione, la complessità della psiche umana), facendo ampio ricorso alle conoscenze disciplinari (perfino a lungo termine, traendole dall’anno precedente) e interdisciplinari, mentre cercano di comprendere un testo che non conoscono.
In buona sostanza, evidenziano elementi di autentica competenza critica, ma non sono in grado di supportarne l’espressione con un linguaggio all’altezza del pensiero.
Di fronte a scritti di questo genere, furono praticate dai differenti gruppi di docenti impegnati nel laboratorio, due prospettive valutative.
La prima tendeva a considerare la forma a parte rispetto al contenuto. Ne conseguiva un giudizio più o meno penalizzante sulle componenti espressive di volta in volta descritte e analizzate. A seguito di quest’azione, però, gli altri indicatori di competenza (conoscenze, comprensione, interpretazione) venivano per così dire liberati dal peso della forma, e valorizzati autonomamente.
Un’obiezione ragionevole mossa a questa scelta didattica fu che esprimeva in una certa misura la pretesa di leggere nel pensiero dello studente: assumendo che il contenuto avesse una sua validità, indipendentemente dalla qualità dell’espressione, si sarebbe teso quindi ad alzare il voto alle prove.
Su questa base, le due prove di cui i passi citati costituiscono un esempio molto rappresentativo ottennero voti oscillanti fra 6,5 e 7 (in un caso, 7,5).
In modo diverso e per certi versi opposto, la seconda prospettiva valutativa considerava la forma componente essenziale di ogni manifestazione del contenuto, in quanto mediatrice fra la volontà comunicativa di chi scrive e la possibilità di comprensione di chi legge. Ne conseguiva un giudizio che penalizzava in varia misura non solo le forma in sé e per sé, ma anche le conoscenze, la comprensione e l’interpretazione.
In questo caso, l’obiezione ragionevole fu che questa posizione tendeva a svalutare il valore del pensiero soggettivo, a meno che non fosse espresso compiutamente: assumendo che la forma sia inscindibile dal contenuto e i suoi limiti si riverberino su ogni manifestazione di esso, si sarebbe stati inclini ad abbassare il voto.
A partire da questa visione, le prove di Elisabetta ed Eljus “presero” voti dal 5,5 al 6 (in un caso, 5).
Orizzonti di realtà, orizzonti di utopia
Pochi giorni fa, Luisa Mirone ha raccontato su questo blog una bella esperienza di scrittura, sottolineando che “la valutazione non è l’operazione conclusiva di un’azione didattica, ma ne è addirittura il motore”.
In questo senso, l’esperienza di ricerca seminariale che ho brevemente descritto sottolinea la complessità di due finalità fondamentali dell’insegnamento letterario e linguistico, a forte vocazione interdisciplinare/ trasversale:
- conoscere le norme linguistiche e valorizzarne il rispetto, consentendo che l’espressione della soggettività e l’espressione autentica di sé non degenerino in impressionismo ed arbitrio
- accrescere la libertà e la creatività del pensiero e il coraggio di mettersi in gioco sul piano critico/ interpretativo, anche quando siano disgiunti da un’affinata abilità di esprimersi in modo preciso e puntuale
Secondo le docenti e i docenti che parteciparono al seminario dal quale ha preso le mosse questa riflessione, una mediazione costruttiva fra queste finalità è possibile solo entro precise condizioni, non sempre condivise e attuabili.
La prima è l’accordo sul processo di apprendimento delle abilità di scrittura, che non procede – questa la nostra conclusione di allora – per gradini successivi.
Non si ha una sorta di sviluppo “naturale” e lineare, che dall’acquisizione di strumenti appropriati di espressione conduce alla definizione di un corretto approccio di comprensione, e successivamente all’emergere di competenze critiche e interpretative. Questa rappresentazione ideale è in realtà una semplificazione, perché ad ogni livello di apprendimento (e anche ben prima che si formi un’idea di “lingua scritta”) si manifesta e si sviluppa l’intreccio fra pensiero e lingua: paradossalmente, è assolutamente possibile che la curiosità critica e interpretativa sia molto più avanzata in una/ un bambina/o della scuola dell’infanzia che in una della secondaria superiore, e che il progredire nello studio indebolisca quest’aspetto della formazione, favorendo invece il conformismo e gli stereotipi culturali.
Una seconda condizione è che per praticare seriamente queste finalità ideali bisogna (bisognerebbe) lavorare a piccoli gruppi, e creare momenti significativi di didattica individualizzata.
Infine, occorre privilegiare l’incontro fra le persone rispetto ai numeri e alle tabelle. Un modo molto diffuso per “risolvere” le questioni sollevate dalla soggettività nella valutazione, infatti, è l’adozione di strumenti pseudoscientifici/ matematici (tabelle, griglie, tassonomie sempre più articolate e descrittive). Basta però sedersi attorno a un tavolo (vanno bene anche quelli delle stanze di Meet) per valutare una prova, insieme alle colleghe e ai colleghi, per capire che non è lo strumento a decidere, ma chi lo usa.
Solo il recupero di un’autentica collegialità, allora, può consentire alla valutazione di essere onesta, obiettiva e condivisa: le sole proiezioni reali del famoso “mito dell’oggettività”.
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento