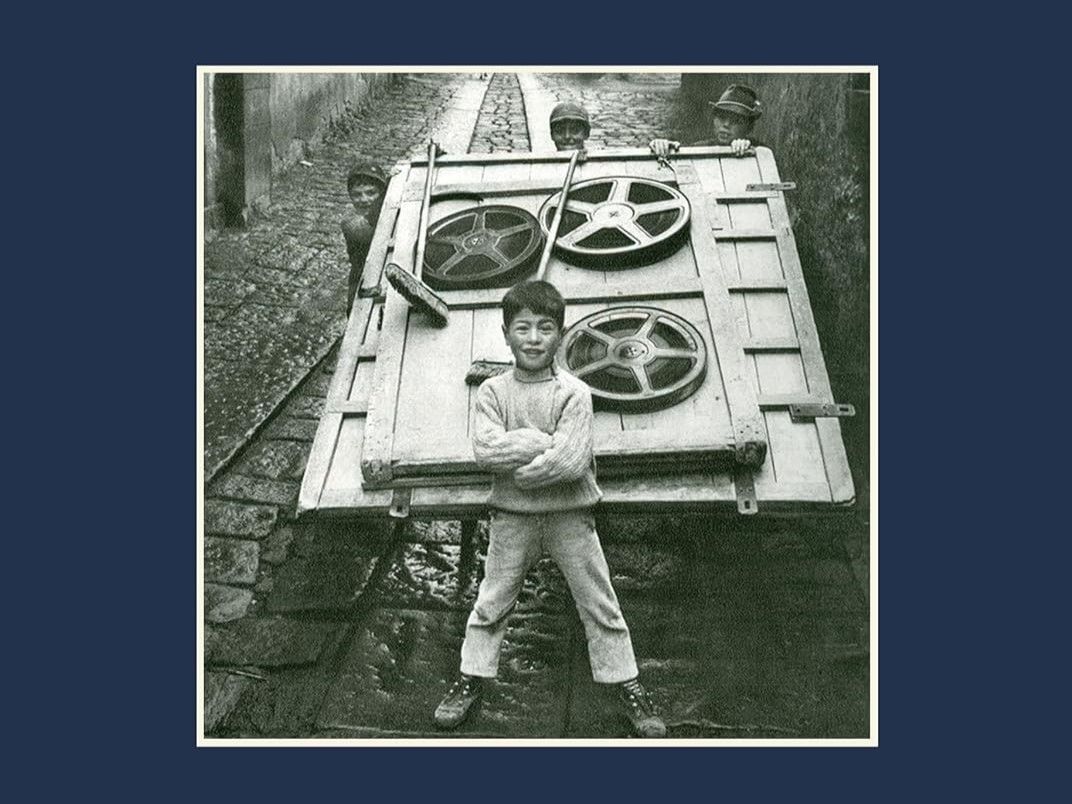
Lunga vita al principe di Danimarca! Rileggere Carla Melazzini
1. …«it is an experimental school»
Riproposto da Sellerio in una nuova edizione accresciuta, Insegnare al principe di Danimarca di Carla Melazzini (1944-2009) è a mio avviso uno dei tre-quattro libri italiani più belli mai scritti sulla scuola. Accidentalmente, quello di Melazzini non è proprio un libro-Libro, ma una selezione di scritti assemblata con discrezione dopo la morte dell’autrice dal marito Cesare Moreno. Il libro, una sorta di diario in pubblico o di informale registro scolastico, si compone di sei capitoli (gli ultimi due ampliano l’edizione del 2011), campiti da paragrafi, aneddoti e riflessioni di lunghezza medio-breve. La sua struttura antologica rende Insegnare al principe di Danimarca un livre de chevet ideale per insegnanti e lettori che hanno poco tempo per leggere, una sorta di breviario laico per educatori, a cui tornare per rinfrancarsi nei momenti di sconforto o, semplicemente, per recuperare una delle tante osservazioni notevoli in esso contenute.
Ricordo di essermi imbattuto per la prima volta nel nome di Melazzini leggendo Contro l’impegno (Rizzoli 2021), il discusso pamphlet di Walter Siti. Non senza buone ragioni, Siti menzionava il libro di Melazzini come caso virtuoso di letteratura dedicata alla scuola, da opporre a quella galassia di letteratura didascalica e risarcitoria che, in Italia, ha il suo maggior esponente in Alessandro D’Avenia. In Insegnare al Principe di Danimarca l’autrice racconta e riflette sull’esperienza del Progetto Chance, avviato da alcuni “maestri di strada”, «un gruppo di insegnanti di media cultura ed umanità» (p. 33), alla fine degli anni Novanta e proseguito per circa un decennio allo scopo di intercettare studenti e studentesse provenienti da “famiglie multiproblematiche” (così recita l’eufemismo sociologico) della periferia napoletana, che non erano riusciti a ottenere la licenza media, un traguardo che pare alla portata di tutti ma che, in certe circostanze, per molti può restare un miraggio.
La secondaria di I grado (la vecchia scuola media) mi pare il ciclo di studi meno raccontato nella letteratura dedicata alla scuola: figura di transizione fra il “non più” e il “non ancora”, il preadolescente è rimasto spesso all’ombra di due mitologie ben più potenti, quella del Bambino e quella del Ragazzo. Sul purgatorio della scuola media, collocato fra il cielo dei grembiulini e il girone dei motorini, anche gli scrittori spesso hanno preferito glissare. Questo è un primo merito del libro di Melazzini, che non solo si fa carico di raccontare la più ingrata delle età scolastiche, ma lo fa relazionando di un’esperienza di frontiera, che ha cercato di coinvolgere ed educare gli ultimi senza addomesticarne l’alterità entro sagome prefabbricate e rassicuranti, in un contesto, quello delle periferie napoletane, che facilmente si presterebbe alle rappresentazioni convenzionali e stereotipate.
Le volte che mi è capitato di consigliarlo a qualche collega davanti alla macchinetta del caffè, ho notato un certo disorientamento di fronte al titolo del libro – l’equivalenza principe di Danimarca = Amleto può non essere così immediata dopo tre ore di fila passate in classe con venticinque alunni –, che istituisce un’analogia fra la tragedia shakespeariana e il caso di Mimmo, uno degli studenti del progetto Chance, un quindicenne «sicuro che il suo dovere sarebbe di uccidere l’uomo per il quale sua madre ha abbandonato da un giorno all’altro i cinque figli. È una ferita immedicabile, che impedisce di vivere (essere o non essere), figuriamoci di andare a scuola» (p. 35). Melazzini confida nell’esemplarità dei casi da lei presentati, fra maternità precoci, storie di carcere, malavita e violenze di ogni genere: come insegnano i manuali di retorica, gli esempi concreti sono più memorabili delle teorie astratte. Alla luce di questo assunto si spiega anche l’ampio ricorso nel libro a inserti documentari, come gli stralci recuperati dagli scritti degli studenti, spesso più eloquenti di ogni possibile chiosa.
Insegnare al Principe di Danimarca è un cantiere a cielo aperto, un libro scritto “per strada”, che descrive le cose a caldo, nel momento in cui accadono. Il confine a cavallo del quale si muove Melazzini è quello che divide, da un lato, l’essere non solo testimone diretta ma coprotagonista di quanto il Progetto Chance riesce e a far accadere nelle sue classi e, dall’altro, il riuscire a essere abbastanza distaccata dal punto di vista intellettuale ed emotivo da poter offrire un resoconto interessante anche per chi legge e valuta questa esperienza a partire da luoghi, tempi e contesti diversi da quello rappresentato. Giocando intorno a questa linea, Melazzini è riuscita a scrivere un libro sapienziale sulla scuola senza mai sdottoreggiare.
Proprio per il suo essere un’esperienza non istituzionalmente inquadrata, la storia del Progetto Chance contiene ipotesi e spunti interessanti per provare a vivere la scuola in modo diverso da come si fa di solito. Chi abbia una qualche esperienza di insegnamento, sa bene quanto sia difficile liberarsi della narcosi burocratica che l’istituzione scolastica instilla in tutti i suoi attori, dagli studenti ai dirigenti, privando anche i docenti della loro immaginazione controfattuale, quella facoltà che rende capaci di immaginare pratiche diverse e migliori da quelle in uso. Melazzini è consapevole della peculiarità del Progetto Chance e non offre al lettore la sua scuola come modello da imitare.
Fra tutte le mediazioni difficili raccontate nel libro (quella fra scuola e famiglia, fra scuola e territorio, fra scuola e immaginario, fra scuola e lavoro, fra scuola e malavita…), proprio quella fra scuola e Scuola, cioè le difficoltà che il Progetto Chance ha incontrato nell’accreditarsi presso «l’istituzione autoproclamantesi educativa» (p. 333), è forse la più complicata. Anche di fronte ai risultati innegabili del progetto, ci sono insegnanti e dirigenti che perseverano nel pensare di trovarsi di fronte a una marmaglia di «ragazzi impuniti» (p. 198), troppo coccolati dai loro insegnanti. La perplessità e lo sconcerto degli osservatori esterni al progetto, che faticano a capire che razza di scuola sia quella proposta da Chance sono immortalate da Melazzini in questo aneddoto impagabile:
Primavera 2000, Napoli. Intorno al cratere del Vesuvio, l’attenzione di alcuni turisti è attratta da una ventina di ragazze e ragazzi, accompagnati da adulti.
I ragazzi parlano con voce sguaiata, fanno scherzi volgari, pericolosi.
Un turista si avvicina a uno degli adulti e, con atteggiamento comprensivo, gli chiede se si tratti di uno «psychiatric asylum».
«No, sir» risponde flemmatico l’altro «it is an experimental school».
«I see, I see». (p. 43)
2. Con la vittima o con il carnefice?
È quasi commovente la fedeltà di Melazzini di fronte alla realtà che racconta. Mi spiego meglio: spesso i libri che parlano di scuola incappano in una fallacia induttivista, che li conduce a elaborare teoremi partendo dalle singole storie, o, al contrario, in una fallacia deduttivista, che porta a intruppare le peculiarità di ogni caso individuale sotto i vessilli di filosofemi o slogan politico-pedagogici. In un panorama siffatto, Melazzini ha scelto di rimanere ancorata ai dati di esperienza, restituendo nella loro definizione i chiaroscuri di ogni vera avventura educativa e sospendendo il giudizio anche quando sarebbe molto più facile fare il contrario. Si veda per esempio questo passaggio, in cui Melazzini riflette sull’opportunità di celebrare i funerali religiosi a un morto di camorra, in questo caso un ex-studente del Progetto: «Nel rione di Filippo viene organizzata una fiaccolata per chiedere l’ingresso in chiesa: il parroco strappa lo striscione e lo butta nella monnezza. Neanche fare i preti è facile da queste parti: è una scelta continua tra essere conniventi o impietosi» (p. 103).
Questa attitudine di fronte all’esistente rende Insegnare al principe di Danimarca un libro pluralista, antiretorico e non massimalista, non privo di pagine venate di umorismo quando non di comicità vera e propria. È un libro scritto con una disillusione che non è figlia del cinismo, ma il frutto dell’esposizione prolungata a una realtà che chiede di ritrattare, di continuo e non senza fatica, i propri ideali, i propri pregiudizi e i propri schemi operativi in base alle esigenze di ogni giornata, pena la rottura di un patto educativo già precario: «Come si vede, grande è la confusione da queste parti, molto difficile tirare linee nette di separazione: tra vittime e carnefici, ordine e disordine, giustizia e pietà» (p. 114). Mi pare sia un atteggiamento sempre più raro da trovare in un’epoca dove ogni agenzia informativa, dai social ai giornali, premia le opinioni più polarizzate e prive di sfumature.
La mobilità del suo punto di vista permette a Melazzini di ribaltare molti luoghi comuni come un judoka, sfruttando il peso della retorica virtuista e benpensante del momento per ribaltarla nel suo contrario, cioè in una conoscenza non preconcetta, figlia dell’esperienza diretta. Magistrali in questo senso le pagine, anticipate sulla rivista «Una Città», dedicate alla pratica, ancora diffusissima, di proporre la visione a scuola di film come Schindler’s List, che vorrebbero sollecitare l’empatia e spronare la consapevolezza degli studenti, senza considerare possibili controindicazioni:
Prendiamo una quindicenne che non riesce a coabitare con il suo corpo, lo sente brutto e spregevole, facciamole vedere immagini di uomini e donne nudi che in lunghe file attendono il loro turno per la morte, e cerchiamo di indovinare le sue reazioni.
La frase «come sono brutti!» segnala che l’identificazione è avvenuta; il risolino denuncia il disagio se non l’angoscia che ne deriva. Immaginiamo anche i rimproveri scandalizzati degli insegnanti presenti.
Cerchiamo di non dimenticare (la memoria!) che un ragazzo si trova statutariamente in posizione di inferiorità e impotenza di fronte all’adulto, e pertanto, posto dinnanzi a qualunque tipo di narrazione, proietta se stesso e si identifica spontaneamente con il debole, l’inferiore. Questo è il motivo per cui, con millenaria saggezza, la narrazione – dalla fiaba al romanzo di formazione – presenta al giovane storie nelle quali il debole e l’inerme, grazie alle sue doti e agli opportuni aiuti, riesce alla fine a costruire l’edificio del suo futuro.
Che effetto gli deve fare invece una storia dove il debole, spogliato delle sue vesti cioè della sua identità, si avvia senza ribellarsi all’annientamento insieme a milioni di suoi simili? (pp. 125-126).
Qui non voglio dilungarmi, ma prometto a chi legge che nel libro si inciampa di continuo in riflessioni di questo livello, che pretendono orecchie agli angoli delle pagine, appunti a matita, ma soprattutto seria meditazione. Gli insegnanti di lettere resteranno deliziati dalle cronache sulla ricezione della Metamorfosi di Kafka in una scuola siffatta (Il libro dello scarrafone) o dalle Convinzioni generali sulle quali mi sono basata per promuovere la lettura presentate dall’autrice.
A tutti gli insegnanti, invece, Melazzini porge uno specchio a cui è difficile affacciarsi ma in cui, purtroppo, è fin troppo facile riconoscersi. Con l’ennesimo ribaltamento prospettico di grande efficacia, Insegnare al principe di Danimarca mette a nudo, senza mai dismettere la propria pietas, le ipocrisie e le menzogne del mondo adulto, che lascia riprodurre nella scuola «il disordine e l’illegalità del mondo esterno: l’assenza di controlli e l’intimidazione; il favoreggiamento e la raccomandazione» (p. 333). È una diagnosi difficile da accettare, perché implica la connivenza anche del corpo docente rispetto a simili dinamiche. Molte volte ciò non accade per chissà quale negligenza o cattiveria, ma perché a scuola è sempre più difficile per il corpo docente «reggere l’urto senza disgregarsi» (p. 39), come recita una formula azzeccatissima dell’autrice. Sconsolata, Melazzini si chiede quanto tempo la scuola dedichi davvero alle questioni che stanno più a cuore agli studenti: «Moltissimo sicuramente ne dedica al trattamento dei sintomi di questi malesseri, sotto forma di rapporti disciplinari, sospensioni, prediche moralistiche» (p. 138). Leggendo questi affondi, non sembra passato un giorno da quanto sono state scritte queste pagine, e invece sono passati più di vent’anni.
Insegnare al principe di Danimarca è un libro chiaro, schietto, piacevole da leggere, ma i cui referti non sono facili da accettare; è anche un libro solitario, che persegue un’idea radicale di scuola e di cultura, refrattaria a essere ridotta e impacchettata per bandi, progetti, linee guida, hashtag, presentazioni, festival culturali, saloni e ospitate televisive. Solitaria e radicale è stata anche la stessa Carla Melazzini, che giovanissima ha avuto il coraggio di abbandonare gli studi alla Normale di Pisa perché sentiva la sua lontananza da un’idea di cultura percepita come troppo accademica, celibe e un po’ muffa. Davvero non so se basti un libro, anzi meno di un libro, per fare di un’autrice un classico della letteratura sulla scuola: secondo me sì. In ogni caso c’è da augurarsi che il passaparola fra insegnanti non smetta mai di far circolare le pagine di Melazzini da un’aula all’altra.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento