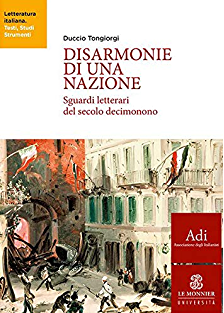
Disarmonie di una nazione
I miei nonni dicevano patria
Impiego sempre moltissimo tempo a traghettare la quarta (quando ce l’ho; e quest’anno ce l’ho) dall’Illuminismo al Romanticismo. Forse dovrei imparare a prendere un bel respiro e fare un agile salto, uno di quelli a quattro, cinque, sei rimbalzi che fanno i sassi piatti se uno li sa lanciare su uno specchio d’acqua calma: Cuoco, Beccaria, Parini, Alfieri, Foscolo e finalmente via, un bel tuffo dentro Manzoni. Ma non ci riesco, non ci riesco mai. È uno snodo troppo importante, un crocevia dove ogni strada diventa utile da percorrersi, perfino irrinunciabile. Uno snodo dove “le questioni” mi sembrano tutte urgenti perché mi sembrano ancora aperte, e dove (absit iniuria verbis) quelle questioni mi sembrano a volte perfino più importanti degli autori; non solo perché (non dico certamente cosa nuova) è lì, in quell’incrocio, che si definisce il terreno su cui si gioca la partita della modernità, inclusiva di audacissimi slanci e vertiginose cadute, ma perché per noi, per l’Italia, si definisce l’idea di nazione, e non sono mai tanto sicura (anzi: sempre meno lo sono) che questa parola sia per i miei allievi referente degli stessi contenuti che ha per me. Certo, leggo i giornali e mi guardo intorno, se non con cinismo, con una desolazione a cui soltanto l’antica militanza e il mestiere che faccio impongono di non scivolare in rassegnazione. Ma agisce in me non tanto il ricordo del sussidiario della mia infanzia, con l’immagine di Garibaldi ferito in Aspromonte e tutto l’eroico repertorio precedente e conseguente, non solo il ricordo maturo delle pagine della Storia della letteratura italiana desanctisiana e poi di tanti romanzi che mi hanno fatto italiana (L’Agnese va a morire, La storia, Conversazione in Sicilia…), quanto piuttosto e soprattutto il racconto familiare: nonni (classe 1901), genitori, zii e cugini di ogni grado, amici cari, un intreccio di vicende dolorose e straordinarie, umanissime sempre, che attraversano l’Italia letteralmente dal Cenisio alla balza di Scilla. E capisco allora che per me nazione non è contenitore asettico: i miei nonni la chiamavano patria, e queste sono cose che lasciano il segno. Sicché mi chiedo sempre se io sia buona a fare da traghettatore alla mia quarta, con queste stimmate, se io debba fasciarmele prima d’impugnare il remo o esibirle con onestà. Sicuramente sento il bisogno di un radar, non m’imbarco mai senza. Quest’anno ne ho sperimentato uno nuovo e utile, che mi ha aiutato a intercettare rade, secche e correnti: Disarmonie di una nazione. Sguardi letterari del secolo decimonono (Le Monnier Università, 2020) di Duccio Tongiorgi.
Questioni di stato
Il libro è opportuno fin dal titolo, che anticipa la questione fondamentale: si può parlare di nazione senza incorrere nella doppia retorica del patriottismo roboante come della sua cinica smitizzazione? Sì, se si prova a «porre lo sguardo soprattutto sugli aspetti disarmonici, sulle memorie non condivise» (Premessa), ma che non smettono, per questo, di essere memorie e di adempiere quindi al compito importante di una contronarrazione, necessaria a restituire, accanto ai «miti costituenti l’idea di nazione», anche «la capacità di immaginare una cittadinanza ancora – spesso drammaticamente – da costruire» (ibidem). Di questa capacità immaginativa il «discorso letterario» è deposito e volano; e del resto, Nulla si compie senza la parola: il verso delle Supplici di Euripide, che – a quanto pare – Monti teneva «sul suo tavolo di lavoro», «abbraccia ad endiadi motivi politici e letterari» (p.22) e ci introduce alla riflessione antica e attualissima sulla dimensione politica della letteratura – e sappiamo quanto ce ne sia bisogno nelle nostre aule dove alternativamente risuonano moniti rancorosi (“Non si fa politica a scuola!”) e fervore di civica educazione. È una riflessione scandita in sei tappe diacroniche e, anche in questo caso, ogni titolo ne individua in modo significativo il portato, rivelando linee di tensione e nervi scoperti del percorso di lenta costruzione della identità nazionale: Orizzonti nazionali e richiami all’ordine; La velleitaria ‘concordia discors’ del Conciliatore; Censure; Popolo; Parabole moderate; Narrare la sconfitta. Coraggioso e prudente, spregiudicato e frustrante, ipocrita, cinico, grottesco, lucidissimo e velleitario, il cammino identitario si snoda sotto gli occhi del lettore attraverso l’evidenza della parola testuale, sino al riconoscimento della sconfitta «degli istituti più resistenti e (…) più consacrati della ideologia patriottica: il coraggio, il valore, il dovere», fantasmi dietro cui si cela (per dirla con Tarchetti) lo spettro feroce di una monarchia, approdo paradossalmente necessario alla ridefinizione della «nazione come comunità condivisa» (p.186).
A ben guardare, tutte le questioni affrontate da ogni singola sezione possono rappresentare in aula una risorsa, non solo per lo svolgimento consapevole e approfondito di quel tratto di storia letteraria, ma come strumento per individuare alcuni nuclei imprescindibili per ogni riflessione che aspiri ad avere un valore civico (e non parliamo poi di quando l’ambizione sia addirittura quella di fare educazione civica…). Cosa c’è di impraticabile nella «concordia»? Perché si è rivelata fin da subito «velleitaria»? E perché – allora – continuiamo a proporla come modello di comportamento socialmente utile, politicamente corretto? E ancora: perché le nostrane «parabole moderate» non sono affatto senza miserie di partiti, senza gare meschine, come vorrebbe il mito ottocentesco nato intorno alla contessa Maffei (cfr. p.161)? E ancora: di cosa si sostanzia la censura? Perché continua a esistere, a operare anche se ufficialmente non c’è più? Sono tutte domande che (ce lo illustra benissimo Tongiorgi) nascono da quel passato, ma investono il presente. E, come ha scritto Luperini
Ricostruire il rapporto passato-presente comporta tanto una messa a punto storico-filologica del primo quanto una assimilazione del secondo quale filtro di domande attuali da porre alla tradizione. (Dal modernismo a oggi, Carocci, 2018, p.130)
Popolo
Fra tutte le questioni, una ce n’è tuttavia a cui senz’altro darei la precedenza, giacché mi pare che orienti anche le altre e che fra tutte sia quella capace di parlare agli studenti; che magari non avvertono ancora il potere occulto della censura, o che ancora si sentono estranei alle trappole di una parabola moderata, o che ancora (beati loro) una sconfitta storica non sanno cosa sia, ma che invece percepiscono già, più o meno consapevolmente, di appartenere al popolo, non fosse altro perché compiono diciotto anni e sono chiamati a votare. E Popolo è – appunto – la sezione che qui ho scelto di privilegiare. Il profilo che emerge è bifronte: come di plebe che fatichi a diventar popolo o di popolo che cerchi la lingua e i modi che lo rappresentino e lo legittimino ad essere tale, a non essere più plebe; e del resto, come scriveva Eleonora Pimentel Fonseca sulle pagine del Monitore (ce l’ha ricordato poche settimane fa Adriana Passione su questo blog), finché la plebe mercé lo stabilimento di una educazione Nazionale non si riduca a pensare come Popolo, conviene che il Popolo si pieghi a parlar come plebe. Da un lato dunque il popolo è chiamato addirittura ad essere il primo giudice naturale de’ suoi poeti, come voleva Terenzio Mamiani (cfr. p.116) e diviene per questa strada «consapevole che anche la trasformazione degli istituti poetici e linguistici in alcuni casi ha potuto svolgere una funzione ‘rivoluzionaria’» (p.115); il che significa, sulle lunghe percorrenze, che, mercé lo stabilimento di una educazione Nazionale, la plebe, ormai popolo, potrà perfino definire il canone letterario, con le conseguenze del caso (e in questo senso è interessantissimo il capitolo dedicato al dibattito risorgimentale sulle antologie poetiche, apripista di annose discussioni sul canone, e in particolare sul canone scolastico, che ancora durano e non accennano a concludersi, cfr. pp.109-113). Dall’altro tuttavia questo popolo ha ancora le movenze, le istanze, i desideri della plebe e come plebe viene impietosamente rappresentato forse da quegli stessi che l’hanno convinto, attraverso pubbliche e trascinanti orazioni, di essere popolo. Tongiorgi propone una sequenza di «parodie di comizi alla folla» (pp.137-148) che potrebbe essere riproposta in aula senza esitazione: il debol parere di Renzo (e di Fermo prima di lui) e il discorso, il più continuato nel tempo e il più sconnesso nel senso, di Ferrer; il turbine di eloquenza di Carlino a Portogruaro, tra tutti il più mite e suscettibile di identificazione; la velenosa arringa della Zuppidda, che sale su un ballatoio come su una tribuna e da lì, colla schiuma alla bocca, si mette a predicare contro il dazio sulla pece; l’altro discorso, il vero, la confutazione di quello tenuto dinanzi alla canaglia che Consalvo Uzeda pronuncia, in privato, alla zia Fernanda, divertita e quasi cullata da quella recitazione enfatica e teatrale. E mentre scrivo penso che davvero non dovrei esitare un istante a sottoporre ai miei allievi questa rassegna spaventosa, che dovrei allenarli a riconoscere, come accade a Carlino, che non sempre «l’abito fa il leader» (p.142); che dovrei allenarli a riconoscere nelle parole del Duca, come di Ferrer, quell’«esercizio retorico estenuante e vuoto di senso» (p.147) di cui sono diventati esperti tanti politici, e vittime noi; a riconoscere nella Zuppidda tutte le Angele da Mondello e i predicatori issati sui ballatoi dei social.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo
Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo -
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
Commenti recenti
- massimo ferrari su Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivoOttima recensione, sintetica com’è giusto che sia, ma preceduta da un lavoro di analisi che…
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento